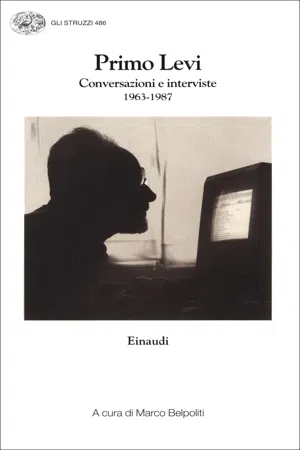Nel corso della trasmissione radiofonica, l’ospite di turno sceglie la scaletta musicale e commenta i diversi brani con interventi della durata di alcuni minuti.
(La radio trasmette una canzone popolare piemontese).
LEVI Questa canzone s’intitola: O dì-mi ün po’, bel giuvu, da lu capè burdà… Traduco: «Giovane, o bel giovane dal cappello bordato | sapreste darmi notizie del mio innamorato?» Devo dire che la memoria che ne ho, il ricordo acustico di questa canzone, non coincide con quello che abbiamo sentito, è leggermente diverso. È una canzone popolare, qui è cantata dal Coro La Grangia e il testo è stato raccolto da Costantino Nigra. Devo dire che la memoria che ne ho non viene per vie colte, per vie erudite. È la canzone di cui ho memoria piú lontana. La cantava mia madre1 a mia sorella e a me quando eravamo bambini e la cantava in una versione diversa; era quella che lei, a sua volta, aveva sentito da sua madre, e sua madre dalla madre di sua madre. Mia madre la canta ancora adesso, l’ha cantata a noi e noi l’abbiamo cantata ai nostri figli; quindi sono ricordi molto lontani, di un tempo in cui la musica meccanica, meccanizzata, la musica dei mezzi di diffusione non aveva ancora fatto irruzione nelle case, ed in cui quindi una canzone poteva veramente costituire l’anima di una casa, di una generazione, anzi poteva essere un filo conduttore fra generazioni.
(La radio trasmette Che farò senza Euridice, da L’Orfeo all’inferno di Offenbach).
LEVI Mentre il primo ricordo è legato a mia madre, che è ancora viva, questo ricordo di Offenbach è legato a mio padre, che è mancato da quasi quarant’anni oramai… da quarant’anni, anzi. Mio padre2 aveva studiato seriamente ed esercitava seriamente il mestiere di ingegnere, ma era un autodidatta. Si era costruito con gli anni una cultura parallela; leggeva confusamente tutto quello che l’industria culturale di allora offriva. Aveva anche studiato musica, anche questo abbastanza seriamente, questo non in proprio: la sua educazione musicale non era frutto di autodidattismo, aveva studiato il pianoforte. Aveva poi lavorato a lungo, come ingegnere, in paesi musicali, in Austria e in Ungheria, e si era in qualche modo saturato di musica. Tutti i suoi momenti d’ozio, che erano molto pochi del resto, era un uomo molto attivo, erano riempiti di musica. Quando si faceva la barba, cantava questo motivo o altri motivi, non tutti di Offenbach, ma naturalmente anche molti altri. Si direbbe che la musica riempisse i suoi vuoti. Suonava anche, suonava il pianoforte, suonava alla sera; come adesso si sente o si vede la televisione, a quel tempo lui si ritirava nel suo salotto privato, diciamo cosí, aveva il pianoforte e suonava, non bene ma con entusiasmo, suonava con gioia. Ad esempio, nel suo repertorio c’erano queste arie, questi motivi di Offenbach. Era simile a Offenbach, come tipo umano: era un innamorato della vita, gli piaceva vivere, si divertiva a vivere, tendeva a rifiutare i guai e anche i pericoli, lo si è visto, purtroppo, anche negli ultimi anni, ha cercato fino all’ultimo di non vedere quello che capitava intorno a lui e intorno a noi. Di questo repertorio faceva parte il concerto che ora udremo, il Concerto n. 5 per piano e orchestra, detto Concerto imperatore [di Ludwig van Beethoven].
(La radio trasmette il Concerto).
LEVI E adesso invece, ma siamo sempre negli stessi anni, qualcosa di molto diverso; si passa, per cosí dire, dal privato al pubblico.
(La radio trasmette l’inno fascista Fischia il sasso).
LEVI «Fischia il sasso, il nome squilla del ragazzo di Portoria…» Eh be’, non sono ricordi tanto allegri! Come tutti, salvo rarissime eccezioni, forse neanche dell’1 per cento, sono stato balilla anch’io. Mi dovevo infilare in quella antipatica divisa, non per ragioni ideologiche, perché certamente non ero a questo punto, ma per la scomodità, perché tirava da tutte le parti, perché era brutta, aveva una specie di… si chiamava «pastasciutta», mi pare, una trina di… una cordella bianca che doveva passare sul petto, stare a posto; le scarpe non erano le scarpe solite, le calze dovevano stare su, c’era il fez con il fiocchetto che cadeva sul naso e c’erano le adunate, un qualcosa di soprannumerario, qualcosa che si sovrapponeva al già noioso programma scolastico e si svolgeva fuori ora; e poi bisognava andare al passo. Non che fosse difficile, ma mi appariva qualcosa di contro-natura, di fuori natura, quella di camminare inquadrati; fino a che era per fare ginnastica, si poteva ancora ammettere, aveva un certo suo divertimento, ma invece andare a spasso in giro per la città in quel modo facendo finta di essere soldati, era veramente una cosa che non mi piaceva, che mi annoiava, mi faceva piangere addirittura, certamente non promettevo di diventare un buon soldato, e infatti non lo sono mai diventato.
(La radio trasmette La mia canzone al vento).
LEVI Non ricordo da quale film, certamente un film famoso, fosse stata lanciata questa canzone, ma io la ricordo cantata abbastanza presto, già negli anni ’37-38. Erano gli anni in cui io avevo finito il liceo, mi ero iscritto all’università ed erano sospese per aria le leggi razziali. Per qualche motivo, che cercherò poi di enucleare, questa canzone è la sigla di quegli anni… sí mi viene in mente perché, ne circolava una versione parodistica in cui si diceva: «Vento vento, portalo via con te». Non posso assicurare che la ragione di questo privilegio nella mia memoria di questa canzone sia la parodia, certamente per me è legata a delle ore stranamente non sgradevoli, anzi che ricordo volentieri e con affetto: le ore dell’università. Io ero già segnato, con altri miei compagni di studio eravamo catalogati come «cittadini italiani di razza ebraica»3, non c’erano ancora gravi pericoli o per lo meno non ce ne rendevamo conto, ma eravamo stati contrassegnati. Ugualmente l’ambiente in cui vivevamo, che era quello dell’università fascista, non era ostile, o per lo meno non percepivamo nessuna ostilità intorno a noi, io non la percepivo. Cantavano questa canzone i miei amici e le mie amiche ariani, come si diceva allora, nel laboratorio. Questo laboratorio della Facoltà di Chimica era veramente una specie di falansterio, era un luogo di socializzazione, di grandi amicizie che durano tuttora infatti. Si lavorava seriamente cinque ore al giorno in laboratorio, dalle due alle sette, e nel fondo dei fumi ammoniacali e cloridrici c’era per l’aria questa canzone: «Vento vento…»
(La radio ritrasmette un brano della canzone, a cui subentra una marcia militare tedesca che resta in sottofondo mentre Levi parla).
LEVI Il nome ufficiale di questa marcia, di questo inno nazista – era l’inno ufficiale del partito nazionalsocialista – era Die Fahne Hoch, «La bandiera in alto», «In alto la bandiera». Il nome in cui, sotto cui era conosciuto dal popolo tedesco era Horst Wessel [Lied], cioè la Canzone di Horst Wessel, e la storia era curiosa. Horst Wessel era un magnaccia, era un uomo che professionalmente si faceva mantenere dalle donne, che era iscritto al Partito nazionalsocialista fin dagli inizi e che era stato ucciso in qualche scaramuccia di strada con i rossi, non so dire con precisione con chi e quando, ed era diventato un martire, era diventato addirittura l’uomo simbolo del martirio nazionalsocialista in Germania; tra l’altro non è brutta, è una bellissima marcia, è molto bella, e questo è istruttivo. A noi, a me per lo meno, alla mia generazione, questa musica fa drizzare i capelli sul capo, non cosí per i fruitori dell’epoca. Questo gap, questa spaccatura che c’è tra il livello musicale, il livello artistico di un pezzo, gli effetti che può provocare, l’effetto di trascinamento che può provocare, e il modo con cui viene fruito da un pubblico e da un altro pubblico, mi sembra estremamente istruttivo.
(La musica della marcia copre le parole di Levi e la radio trasmette il brano, cui subentra una musica allegra).
LEVI Questa polca è nota in tutto il mondo come Rosamunda, vedo però sulla copertina del disco che il suo titolo ufficiale è un altro. È La polca del barile di birra, senza che io capisca bene cosa c’entri il testo italiano, per lo meno sarà tradotto male, e per me è importante, è importante per due motivi almeno: quando sono stato deportato ad Auschwitz4, lo sbarco in questo universo spaventoso e ignoto del Lager è stato accompagnato da marce, da motivetti musicali suonati dall’orchestra di Auschwitz. Non sapevamo allora che l’orchestra suonava tutte le mattine e tutte le sere, quando partivano e ritornavano le squadre del lavoro. E quindi era del tutto incomprensibile come su questo scenario tragico, un tramonto sanguigno, il gelo di un paese per noi sconosciuto, gli ordini urlati in lingue che non sapevamo che lingue fossero, erano ordini urlati in polacco o in tedesco da caserma, fosse accompagnato, fra gli altri, da questo motivo, Rosamunda, che a noi era noto; in Italia lo si cantava, era una canzone da balera, lo si ballava; ed era veramente un effetto, quello che si chiama estraneamento, di alienazione: il non capire piú, non capire perché l’ingresso, il varcare le porte degli Inferi fosse accompagnato da un ballabile. Poi, nei giorni seguenti, ci siamo accorti che la cosa era molto meno misteriosa di quanto apparisse; non tutte le mattine, ma sovente, questo Rosamunda veniva alternato con altri canti, altre canzoni militari, ma non tutte militari, che accompagnavano questa sinistra cerimonia delle squadre di fantasmi che zoppicando si avviavano al lavoro al mattino e zoppicando di piú ancora tornavano dal lavoro alla sera. Ma la cosa non finisce qui, il mio rapporto con Rosamunda non finisce qui. Nel ’64, cioè parecchi anni dopo la pubblicazione del mio libro Se questo è un uomo, la Rai mi aveva proposto di farne una versione radio5. Per me l’esperimento, il primo esperimento, questo, è stato a un tempo appassionante, divertentissimo e, ancora una volta, sinistro, perché sperimentalmente le riprese sono state fatte all’aperto allo scopo di riprodurre anche acusticamente i suoni dell’aria libera, invece dei suoni dello studio. Di notte, per evitare i rumori diurni, a Brozolo, un paesino delle colline torinesi, e per mia scelta, il motivo accompagnatore, il leitmotiv, il motivo dominante, è stato proprio questo Rosamunda, non nell’edizione che avete sentita, ma in una, se non sbaglio, suonata dalla banda musicale di Bolzano, cioè Zackig [ritmo spezzato], mi sfugge la parola italiana, il modo duro, militaresco, bellicoso addirittura, e si prestava benissimo. Mi fa piacere ricordare che il tecnico del suono di allora è Pierino Boeri che è il tecnico dall’altra parte della vetrata attraverso cui stiamo registrando.
(La radio trasmette musica di Čajkovskij).
LEVI Avete sentito l’ultima parte dell’ouverture della Sinfonia 1812 di Čajkovskij; avete forse percepito una citazione della Marsigliese. È stata scritta da Čajkovskij, se non sbaglio, a commemorare la vittoria russa su Napoleone, nel 1812, appunto; La Marsigliese è quella dell’armata francese in rotta. Ma a me è rimasta confitta in capo per un altro motivo, perché, quando dopo la liberazione da Auschwitz andavo in giro per la Polonia alla ricerca di un letto e di un tetto, ero sbarcato, in mezzo alla neve e con un freddo polare, alla stazione ferroviaria di Cracovia mentre gli altoparlanti in tutta la città trasmettevano proprio questa. Ora avviene, e non solo a me, che un motivo musicale si incida, come qualche volta accade con gli odori, nella memoria e diventi rievocatore. A me rievoca, benché sia un pezzo eroico, rievoca un periodo… una settimana di mendicità, in cui veramente giravo da una mensa all’altra, da un ospizio all’altro, alla ricerca di un posto caldo e di una scodella di minestra.
(La radio trasmette una canzone popolare russa, Kalinka Kala, che si ode in sottofondo mentre Levi parla).
LEVI Questa è Kalinka Kala, una canzone popolare russa, una bellissima canzone, non è vero? che è anche questa rievocativa. Mi trovavo nell’estate del ’45 in piena foresta, in una caserma mezza diroccata dall’Armata Rossa insieme con un migliaio di altri italiani in attesa di un rimpatrio che era abbastanza problematico perché non se ne parlava6. I russi ci dicevano: state tranquilli, verrà anche il vostro giorno, neanche noi siamo ancora rimpatriati; abbiamo fatto la guerra e voi no, voi siete italiani, quindi fascisti, quindi perché vi lamentate? Noi siamo russi, abbiamo vinto i tedeschi e siamo ancora qui, non siamo ancora nelle nostre case. Ora, in questi giorni di attesa, non infelici, perché era estate, faceva caldo, non c’era da lavorare, da mangiare ce ne davano, l’unica infelicità era l’incertezza, abbiamo sentito all’orizzonte, lontano, lontanissimo, le note di questa canzone e di altre canzoni russe, ed erano delle squadre di soldati sovietici che erano stati smobilitati nel modo piú elementare, piú semplice: i loro comandi gli avevano detto: «Avete finito di fare la guerra, andatevene pure a casa»; e tornavano a casa a piedi. Ora chi abbia un’idea della distanza, della lunghezza lungo i paralleli, dell’Unione Sovietica, si rende conto di che tipo di rimpatrio fosse. Erano squadre alcune a piedi, alcune addirittura di uomini scalzi che portavano le scarpe a tracolla per non consumarle, altri coi mezzi piú incredibili: montati su camion, montati su autobus di Berlino che venivano rimorchiati come un treno; c’era una motrice che rimorchiava due o tre bus della città di Berlino, ancora con le scritte berlinesi e che portavano gente selvaggiamente gioiosa che ci salutava con entusiasmo, andava verso Oriente, andava verso casa loro, doveva ancora fare mille duemila tremila chilometri, magari fino nel cuore della Siberia e cantava Kalinka Kala, passavano davant...