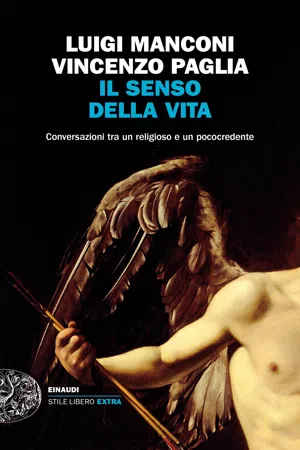MANCONI Il discorso sul dolore che abbiamo fatto nel capitolo precedente è, per me, davvero essenziale. Ho ricordato qualche pagina addietro che trent’anni fa, mentre curavo un libro in materia di sostanze stupefacenti, mi imbattei in quel documento della Congregazione per la dottrina della fede del novembre del ’74, dove si sviluppava una riflessione sulla teoria (e la teologia) del male minore. Fu una lettura illuminante, in primo luogo, per la questione specifica delle droghe e, in termini generali, per una prima elaborazione di un approccio razionale a tutte le condizioni sociali di marginalità, dipendenza e devianza. Un approccio pragmatico che parte da un presupposto pessimistico: il male (sia esso la droga o il crimine) non può essere messo al bando dalla società. Quel male e il dolore che porta con sé può venire ridotto e «governato» attraverso strategie che ne limitino gli effetti piú dirompenti e dannosi per il singolo e la collettività. Discendono da qui le politiche e gli interventi sociali che vengono definiti di «riduzione del danno». Per esempio, rispetto al consumo di sostanze stupefacenti, si possono realizzare programmi e terapie che non presuppongono l’astinenza, ma consentono forme di «mantenimento», le meno nocive possibili; e che attenuino le conseguenze piú pericolose per la salute e l’ordine pubblico (scambio di siringhe, uso di sostanze «tagliate», overdose). È, lo so bene, un’opzione che può apparire scandalosa, perché in apparenza rinunciataria. Cosí facendo, si dice, si viene a patto con la droga e non la si combatte. Ma è vero il contrario. Dal momento che «la guerra alla droga» ha avuto come risultato la massima diffusione, in tutto il mondo, della droga stessa, l’alternativa è una «convivenza conflittuale», che non si affidi alla minaccia e alla pratica della segregazione e della reclusione. Una strategia che permetta di contrastare la diffusione delle sostanze sul campo, metro per metro, attraverso lo sviluppo delle strutture territoriali, pubbliche e private, delle comunità aperte, dei servizi «a bassa soglia», e un’ampia attività di informazione che incentivi la consapevolezza dei consumatori; e attraverso – ecco ancora quella parola – l’accompagnamento delle persone vulnerabili lungo i programmi di emancipazione dalla dipendenza. È un tema di discussione, a mio avviso, importantissimo, proprio perché mette a confronto due concezioni opposte, difficilmente componibili, tanto sul piano pratico che teorico. Dal punto di vista dei modelli terapeutici, la strategia della riduzione del danno è l’esatto opposto della strategia che ha trovato la sua massima applicazione nella comunità di San Patrignano. Quest’ultima, cosí come altre esperienze laiche e religiose, ha adottato un modello che possiamo definire del «toccare il fondo». Si ipotizza, in altre parole, che il tossicomane o chiunque dipenda da sostanze, o la persona comunque fragile, debba precipitare fino a fare l’esperienza della massima privazione e degradazione («il fondo») prima di poter trovare l’occasione e i mezzi per salvarsi. Si presuppone, insomma, che il soggetto debole, solo quando avrà misurato e scontato tutta intera la sua debolezza e avrà perso ogni coscienza di sé e ogni dignità, solo quando si sarà ritrovato all’inferno, potrà uscire da quella condizione estrema. Dunque, quella situazione estrema va perseguita, in quanto l’unica capace di far scattare la molla della salvezza. Questo modello è inevitabilmente autoritario e punitivo, in quanto prevede una rigida gerarchia sociale, dove all’ultimo posto sia collocato il soggetto debole; e presuppone che i suoi atti siano sottoposti a un sistema di controllo fatto di sanzioni e misure di privazione della libertà. È una procedura che, per certi versi, viene fatta valere anche nei confronti del malato di mente, al quale non viene attribuita una responsabilità soggettiva da espiare «toccando il fondo», ma che in ogni caso va sottoposta a segregazione in quanto è ritenuto pericoloso per sé e per gli altri. All’opposto, la teoria della riduzione del danno, o del male minore, investe su quel tanto, poco o molto che sia, di consapevolezza e di volontà di emancipazione che resiste, nonostante tutto, anche nel soggetto piú vulnerabile e ferito. A quest’ultimo, di conseguenza, vanno date risorse di fiducia e di autonomia, strumenti per sviluppare la propria capacità di indipendenza, occasioni di partecipazione alle reti di relazioni sociali. È un’idea di società che tende a includere e ad accogliere, a rendersi permeabile alle nuove identità culturali e sociali, ai movimenti interni e a quelli provenienti dall’esterno. Ciò comporta che si limitino allo stretto indispensabile i provvedimenti e gli istituti del controllo e dell’esclusione, destinati solo a chi si riveli socialmente pericoloso.
PAGLIA Sono d’accordo con te che nella società bisogna accettare la compresenza del bene e del male. Ricorderai la parabola del grano e della zizzania del Vangelo. Agli zelanti contadini che volevano estirpare la zizzania perché restasse solo il grano nel campo, il padrone impedí che la sradicassero, perché – rispose a quegli zelanti agricoltori – cosí avrebbero sradicato anche il grano. E, sarai d’accordo con me, il bene e il male traversano ciascuno di noi, al suo interno. Non c’è il bene assoluto da una parte e il male assoluto dall’altra. E che nella società convivano ambedue è giocoforza. In tal senso, che la società debba essere inclusiva mi pare inoppugnabile. E quindi la politica della riduzione del danno è certamente una opportunità da considerare. Spesso si profila come la scelta del male minore. È il senso della dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede, già Sant’Uffizio che tu richiami. Per parte mia preferirei cambiare il lessico e parlare piú di «bene possibile» da compiere. Ma non fermiamoci sui termini. Quel che mi trova perplesso è l’applicazione di questa prospettiva alla faccenda delle sostanze stupefacenti. Nella tua impostazione vedo ben chiaro il pericolo di affrontare l’argomento in modo riduttivo, limitando il problema a un solo aspetto, quello legislativo. Mentre ce ne sono molti altri in gioco. Mi pare, ad esempio, che sottolinei poco il danno irreparabile che le sostanze stupefacenti producono a livello medico-psicologico. E purtroppo i dati piú recenti ci dicono che i termini della tragedia della tossicodipendenza stanno peggiorando, con una forte recrudescenza di consumo e delle morti per droga nelle età piú giovanili. Troppi credono che sia innocuo (o poco dannoso) prendere sostanze psicotrope a scopo «ricreativo». Ovviamente la stessa cosa dovrebbe dirsi dell’alcol e del fumo. Sono due fonti di incredibili drammi umani, familiari e sociali. Certo, vi è poi la sfida di elaborare politiche pubbliche adeguate, che si definiscono anche in interventi legislativi. E qui ti confesso la mia impreparazione. In ogni caso ritengo cruciale che ci si appelli alla responsabilità personale di ciascuno, ma occorre inoltre porre le premesse per rendere chiari i termini della questione e perché la libertà sia sostenuta per potersi davvero esercitare, senza essere condizionata da quelle che nella dottrina sociale della Chiesa si chiamerebbero «strutture di peccato».
MANCONI In realtà, attribuisco tanta importanza a questa riflessione perché, come dicevo, da essa discendono non solo diversi modelli di policy, ma anche differenti idee sul futuro della nostra società e su un sistema dei diritti di cittadinanza adeguato ai tempi e alla nuova composizione sociale delle comunità contemporanee. Insomma, penso che una società dell’inclusione debba prevedere la convivenza con i diversi mali sociali per ridurre al minimo la sofferenza individuale e collettiva che producono. Qualche decennio fa partecipai a un convegno dal titolo davvero eloquente: Dare un posto al disordine. In altre parole, adottare strategie sociali capaci di «negoziare» con tutti i soggetti (penso ai centri sociali), i gruppi e le minoranze (per esempio i rom), ma pure con ogni forma di trasgressione e devianza (ancora il consumo di sostanze), al fine di «dare un posto» anche a loro nella vita sociale, escludendo solo le manifestazioni di violenza e di sovversione delle regole democratiche. Se, poi, trasferiamo un simile discorso su un piano generale, è ancora questa strategia la piú adeguata ad affrontare problematiche di difficilissima composizione, come quella dei flussi migratori o quella rappresentata dalla popolazione detenuta. Qui l’approccio realistico può aiutare assai piú di quanto faccia il richiamo ai valori della solidarietà. Prendiamo la questione dell’immigrazione e consideriamola, per una volta, non come una disgrazia sociale o una minaccia per l’ordine pubblico, ma per quello che davvero è: un essenziale fattore economico e demografico. Un simile approccio richiede che si mobilitino grandi investimenti sociali e intellettuali, oltre che economici, in modo da realizzare politiche di inclusione tanto ampie e accoglienti da assecondare le tendenze, già in atto da tempo, al mutamento della composizione sociale delle nostre comunità; e cosí da ridurre le conseguenze criminali di quel mutamento a modesta variabile, che possa affrontarsi con gli strumenti già in uso del controllo di polizia e del diritto penale. Ma ciò può avvenire solo se quei flussi migratori saranno destinati non ai margini delle nostre società e alle periferie delle nostre città, bensí al cuore stesso del sistema di cittadinanza, partendo dal riconoscimento della parità di diritti e doveri tra straniero e residente. È a queste condizioni che diventa possibile e realistico parlare di cittadinanza universale. Detta cosí, e detta oggi, sembra una ingenua utopia. Penso, all’opposto, che si tratti di un concreto programma politico e, in ogni caso, di un approccio di metodo e di merito da cui muovere anche nelle condizioni piú avverse e nei tempi piú foschi. D’altra parte, ormai da qualche anno, non sono piú senatore e non ricopro alcun incarico istituzionale, mi sento libero, dunque, di pensare progetti che non dipendano immediatamente da un voto parlamentare, ma che provino a immaginare il futuro. Non è forse questo il senso del lavoro intellettuale? D’altra parte, mi colpiscono alcuni numeri: e mi colpiscono proprio perché i numeri vengono in genere utilizzati al fine di ridurre le ambizioni politiche, restringere l’ampiezza delle strategie pubbliche, rimpicciolire la portata delle riforme. Ecco i numeri a cui penso: la cancelliera Angela Merkel, nel 2015, di fronte alla catastrofe umanitaria in Siria e al flusso di profughi, decise di accogliere in Germania un milione e duecentomila richiedenti asilo di nazionalità siriana. E Joe Biden, tra i primissimi atti da presidente, ha indirizzato al Congresso la richiesta di un provvedimento che permetta ai circa undici milioni di stranieri irregolari presenti sul territorio degli Stati Uniti di ottenere la cittadinanza. Undici milioni!
A proposito della decisione della Merkel, ricordo che venne assunta qualche settimana prima di un episodio che ebbe un forte impatto emotivo su una parte delle opinioni pubbliche europee. La pubblicazione della foto di un bambino di tre anni, trovato morto sulla spiaggia turca di Bodrum. Nella mia testa, quella vicenda e un suo successivo sviluppo, pressoché sconosciuto, hanno preso i contorni e il senso di una parabola. Forse meritano di essere raccontati per esteso. Quel bimbo si chiamava Aylan Kurdî, era originario di Kobanê e tentava di raggiungere con la famiglia l’isola greca di Kos. La fotografia che lo ritrae lambito dalle onde con indosso una maglietta rossa, pantaloncini blu e scarpe da ginnastica scure, riuscí a scuotere, almeno per un po’, l’indifferenza collettiva. E a dare un (piccolo) corpo e un (piccolo) volto all’idea astratta che abbiamo dei ricorrenti naufragi sulle nostre coste. Mesi dopo, accadde che il padre di Aylan prendesse parte a una conferenza stampa e raccontasse gli ultimi momenti della vita dei suoi figli, Aylan e Galip, e di sua moglie Rehan. Poi ebbe come un soprassalto, modificò il tono della voce e si rivolse ai giornalisti, a metà tra la supplica e la protesta: «Vi prego, chiamatelo Ālān e non Aylan, come hanno scritto tutti i media del mondo. Ālān: senza quella y tra la a e la l. Ricordatelo, il suo nome è Ālān». Vi fu sorpresa: perché mai l’esatta grafia di quel nome diventava tanto importante? Perché mai esprimere, tra le mille ragioni di sofferenza, proprio quella? Ci ho pensato e sono giunto a questa conclusione: forse perché un nome scritto in maniera errata e trattato distrattamente accentua la sensazione di una serialità – anche delle vittime – indistinta e anonima. Che è il rovescio speculare del trasformarsi del proprio figlio in un simbolo potente ma disincarnato. Un padre può perfino tollerare la riduzione a icona funeraria di un bambino di tre anni, cosí sottratto al proprio dolore piú intimo, ma non può accettare che quel figlio, che ha visto nascere e vivere la sua prima età, venga rappresentato come un simulacro: un numero in una serie di vittime. Un numero che puoi privare del nome e dell’identità, in quanto il suo valore è tutto in un simbolo. Se questa è una parabola, ne ricavo una lezione: è inutile amare gli stranieri se non li conosci. Ovvero, se non ne sai nome e cognome.
Mi viene in mente un brano di Simone Weil (so che citarla è di moda, ma non posso farci niente), a proposito dell’attenzione. Ascolta, don Vincenzo:
L’attenzione è distaccarsi da sé e rientrare in se stessi, cosí come si inspira e si espira. […] Nella nostra anima c’è qualcosa a cui ripugna la vera attenzione molto piú violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica. Questo qualcosa è molto piú vicino al male di quanto non lo sia la carne. Ecco perché ogni volta che si presta veramente attenzione si distrugge un po’ di male in se stessi. Un quarto d’ora di attenzione cosí orientata ha lo stesso valore di molte opere buone.
L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto […].
Ecco, mi sembra una formidabile lezione, per cosí dire, politica.
PAGLIA Come ti dicevo prima, sono totalmente d’accordo sulla promozione di politiche di inclusione, soprattutto in una società globalizzata come l’attuale. Quando perciò tu parli di «dare un posto al disordine», mi trovi concorde. Del resto, la stessa scienza ormai parla di un disordine congeniale all’universo. Sono note le posizioni di Edgar Morin a proposito della società complessa. Ma proprio per questo vanno evitati i cortocircuiti di paragoni semplificati. Quando parli del disordine riferito alle tossicodipendenze è un conto, ben diverso è se lo applichi alle migrazioni: la tossicodipendenza danneggia il corpo e la mente di chi ne è affetto, mentre la migrazione non solo a mio parere (mi auguro che guadagni sempre piú spazio sino a divenire una convinzione giuridica) è un diritto umano che di certo va accolto, anche se deve essere governato per impedire che diventi occasione di conflitti. Già da ora possiamo dire che le migrazioni, a differenza delle sostanze stupefacenti, hanno significato un notevole arricchimento della umanità. E tu stesso giustamente lo riconosci, e senza tentennamenti. È noto peraltro il tuo impegno pubblico in tal senso. Mi pare comunque opportuno marcare la «ricchezza» che rappresenta il fenomeno migratorio.
MANCONI Ovviamente concordo. Le migrazioni rappresentano un (drammatico) bene in sé, eppure possono avere effetti negativi e, talvolta, molto negativi, quando non sono gestite con intelligenza. Le dipendenze – tutte: quelle da alcol e tabacco comprese – costituiscono un male in sé. Un male che può essere controllato, mediato, contenuto e limitato. La mia è una concezione antiproibizionista che prevede una politica di legalizzazione delle droghe. Ovvero, una strategia di regolamentazione delle condizioni di liceità della circolazione di sostanze stupefacenti e, viceversa, delle circostanze in cui esse devono restare vietate (al di sotto di una certa soglia di età, in assenza di chiare informazioni sulla loro composizione eccetera). Credo di poter dire che si tratta, con ogni evidenza, di una prospettiva fondata su una base di estrema ragionevolezza e su considerazioni di assoluto buon senso.
PAGLIA Torniamo al tema dell’immigrazione. Il nostro Paese – assieme all’Europa – è diventato un Paese di immigrazione. Non possiamo essere miopi di fronte alla storia. È vero che oggi l’immigrazione è percepita come un pericolo. Ma, appunto, la percezione del pericolo è superiore al pericolo reale. E grande è la responsabilità di chi la favorisce. È tristissima la moda di alcuni politici di rovesciare sui migranti il sentimento di paura e di insicurezza degli italiani. È vero che si guadagnano consensi. Ma la predicazione dell’odio sociale produce aggressività e violenza. Il profeta Osea avvertiva: «E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta» (Os 8,7). E quanta tempesta si è abbattuta, ad esempio, nel Mediterraneo, che da «Mare nostrum» è diventato piuttosto «Mare monstrum». Non sono davvero gli immigrati a causare l’insicurezza di un Paese. Certo, l’insicurezza c’è, eccome. Ma le cause sono ben oltre le migrazioni. Il senso di insicurezza che stiamo vivendo nasconde una paura profonda – quasi metafisica – verso un mondo senza confini, verso un futuro poco limpido. In effetti, il mondo globalizzato è troppo grande, troppo vasto, tanto da farci sentire spaesati, senza piú punti di riferimento precisi. È su questo versante che dobbiamo riflettere. Si scaricano sugli immigrati paure che affondano le loro radici nella crisi planetaria che coinvolge i popoli, nell’assenza di futuro per i giovani, in una violenza che si diffonde sempre piú nelle pieghe della società, e cosí oltre. E, poiché le vere crisi sono difficili da risolvere, è facile (soprattutto per i politici) che la paura venga proiettata sull’obiettivo piú semplice: gli immigrati. Costoro sono diventati i capri espiatori su cui far convergere le ansie collettive. C’è uno slittamento semantico: straniero è diventato sinonimo di clandestino. Non si distinguono piú i profughi dalle altre categorie di stranieri e neppure gli immigrati entrati in maniera regolare. Nell’immaginario collettivo, immigrato è uguale a clandestino (una parola che vuol dire «nascosto»), invisibile e quindi pericoloso. Gli studiosi continuano a mostrare il divario enorme tra la realtà dell’immigrazione e la sua percezione. Ma non conta nulla.
E si tace sui vantaggi che l’immigrazione apporta nel nostro Paese. Ovviamente, so bene che l’impatto con lo straniero è sempre un’esperienza complessa: la presenza di persone diverse, spesso emarginate e povere, di genere prevalentemente maschile, può essere una minaccia. Eppure l’Italia ha bisogno di immigrati, e l’integrazione è possibile. Basti pensare ai numerosi matrimoni misti che avvengono tra italiani e stranieri: è una realtà rivelatrice di una tendenza integrativa. Se piú complessa può apparire l’integrazione di comunità magrebine o cinesi, resta la responsabilità di operare un lavoro interculturale capace di valorizzare anche i frammenti delle diverse tradizioni, per costruire un alfabeto comune largo e comprensivo. Questo alfabeto fa scoprire che gli immigrati sono persone piú simili a noi di quanto crediamo. Quanti italiani fanno l’esperienza positiva di quasi un milione di badanti e colf, essenziali alla sopravvivenza familiare? Le ricerche parlano di una famiglia ogni dieci. Eppure, non si dice. Purtroppo, il discorso pubblico spesso stride con l’esperienza di tanti. C’è da dire che l’Italia ha bisogno di stranieri. Non sono essi a far finire il nostro mondo. È vero esattamente il contrario: senza gli stranieri il nostro mondo finisce. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo.
MANCONI Ah, che sollievo, per una volta, trovarmi esentato dal doverle dire io, certe cose, dal momento che c’è un altro che le dice. Tuttavia, pur condividendo il tuo pensiero, vorrei fare due rapide note a margine. La prima: i dati, le evidenze statistiche, le cosiddette «cifre irrefutabili» sono, alla prova dei fatti e del sentimento comune, largamente fallaci. Non funzionano. Dobbiamo almeno saperlo e tenerne conto. Seconda considerazione. Anche per quanto appena detto, è fondamentale, in quella porzione di discorso pubblico al quale prendiamo parte, privilegiare argomenti diversi rispetto a quelli ispirati dalla virtú della solidarietà. Che è un bene prezioso, ma che va ricondotto alla sfera delle scelte individuali e delle motivazioni che determinano l’azione: nella sfera pubblica e nell’attività politica, altre devono essere le motivazioni addotte e gli strumenti utilizzati. Insomma, credo che assai piú, a favore di un’accoglienza generosa e di una pacifica convivenza, possano valere le ragioni di natura economica e demografica. Quindi, ancora una volta, tendo a puntare sull’altruismo interessato. Sul fatto, cioè, che l’inclusione degli stranieri e il riconoscimento dei loro diritti si possano tradurre in un vantaggio per tutti; e che l’accoglienza e la convivenza pacifica siano fattori determinanti per la stabilità e la coesione della nostra organizzazione sociale.
PAGLIA E qui accenno a due considerazioni. L...