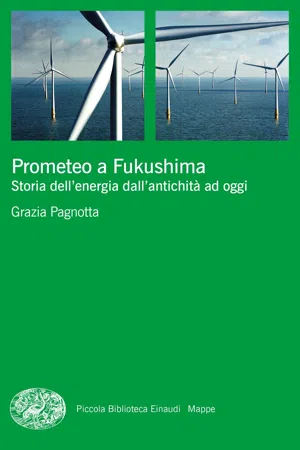1. La prima metà del secolo.
Fino alla metà del Novecento il carbone fu la fonte energetica di gran lunga preminente. All’inizio del secolo, nell’anno 1900, soddisfaceva ben il 95 per cento delle esigenze energetiche mondiali, e ancora nel 1948 rispondeva al 62,2 per cento delle necessità di energia nel mondo, sebbene si fosse allargato l’impiego del petrolio che rispondeva al 28,4 per cento; seguiva il gas naturale con il 9,4 per cento1.
I paesi in cui si estraeva piú carbone e che disponendone ne facevano un piú largo uso erano l’Inghilterra, gli Usa e la Germania, i quali alla data del 1913 assommavano l’82 per cento della produzione mondiale2. Dal 1900 gli Usa avevano superato la produzione inglese, con 245 milioni di tonnellate contro 230, e il divario si era accentuato velocemente con 517 milioni di tonnellate contro 292 nel 1913. A questa data seguivano come maggiori produttori la Germania con 277 milioni di tonnellate, la Russia con 30 e il Giappone con 21. Va anche detto, però, che nel loro insieme i paesi europei ne producevano piú degli Usa, esattamente 684 milioni di tonnellate. Negli anni seguenti continuò questa tendenza con gli Usa che alla data del 1929 ne producevano 552 milioni di tonnellate, la Germania 350, l’Inghilterra 239 e l’Europa nel complesso 873. Negli anni trenta invece la produzione si modificò, con un calo significativo di quella degli Usa3.
L’Inghilterra manteneva, comunque, il ruolo di maggiore esportatore, mentre gli Usa impiegavano il proprio carbone sul mercato interno4. A fare del carbone inglese una produzione di successo continuavano a essere gli stessi elementi del secolo precedente: la sua alta qualità adatta sia per gli impianti a vapore che per l’uso domestico, la geografia del paese con una localizzazione delle miniere non lontana dai porti e con una posizione di accesso facile e poco costoso attraverso il mare ai mercati europei e mondiali, e alcuni elementi del suo potere economico quali la rete internazionale dei commerci, quella dei suoi investimenti e la grande flotta; il tutto, infine, permetteva di applicare prezzi piú bassi dei rivali5.
La parte maggiore del carbone che l’Inghilterra destinava al mercato estero la vendeva agli europei, il 61 per cento alla data del 1913; per il resto il 7 per cento era venduto sul mercato dell’America Latina, un altro 7 per cento su quello africano, il 22 per cento era venduto nel mondo ai depositi carbonili, utilizzati soprattutto dalle navi, e il poco rimanente a mercati minori. Sul mercato europeo, l’Inghilterra vendeva alla Francia il 14 per cento, all’Italia il 10 per cento, alla Germania il 9 per cento, a Svezia e Danimarca l’8 per cento, alla Russia il 6 per cento, a Belgio e Olanda il 4 per cento e ad altri europei il 10 per cento. Sul mercato dell’America Latina la sua posizione era dovuta alla larga proprietà di ferrovie, miniere, industrie dei servizi e industrie di altro tipo, che insieme generavano un’ampia domanda di carbone. Sul mercato africano poteva vendere grazie al rapporto con le sue colonie, mentre minore era la sua presenza sulla piazza asiatica, dove le possibilità erano limitate dalla distanza e dalla presenza del carbone prodotto da Giappone, Australia e Sudafrica; il Giappone riforniva Hong Kong e i maggiori porti della Cina, la quale comunque aveva anche una sua produzione, mentre l’Australia e il Sudafrica rifornivano i centri urbani costieri dell’India6.
Negli Usa l’estrazione del carbone aveva un costo piú basso rispetto all’Inghilterra e ad altri paesi, ma il prezzo per la vendita aumentava perché vi pesava la spesa per il trasporto ai porti, molto lontani dalle miniere. La Germania tra il 1900 e il 1913 ebbe un momento di rimarchevole crescita della produzione, che raddoppiò passando da 153 milioni di tonnellate a 277. Tale risultato fu dovuto all’azione del Consorzio del carbone del Reno-Westfalia, nato nel 1893 nell’ambito di una politica volta a una migliore organizzazione delle industrie di acciaio e ferro e di quelle del carbone, a una loro integrazione, e a una stabilizzazione dei prezzi; all’inizio del nuovo secolo con la creazione di una rete di compagnie per le vendite, tutto l’insieme si rafforzò e fu possibile aumentare il ritmo di estrazione. La Francia aveva una quota di carbone proprio che estraeva dalle miniere della regione Nord-Pas de Calais e dalla Ruhr, ma necessitava di un’aggiunta che le arrivava nei porti di Le Havre, Rochefort, Bordeaux e Bayonne. L’Italia invece non aveva una propria produzione7.
Tra i tre settori d’impiego del carbone, quali l’industriale, i trasporti e il residenziale, in tutti i paesi continuò a essere preminente il primo. Tra le industrie le produzioni di acciaio e ferro continuarono a essere quelle che ne bruciavano la maggior quantità, ma grandi consumatrici erano anche le produzioni di alcuni metalli, come piombo, rame e zinco, il settore della chimica per il quale il carbone era materia base per un’infinità di prodotti, e poi le industrie del cemento, della ceramica e del vetro. Nel settore dei trasporti gli Usa erano il paese che ne faceva il piú largo impiego, per via della lunghissima rete ferroviaria; anche il Giappone ne consumava molto, ma per il trasporto navale. Nel residenziale a farne l’uso piú ampio erano gli Usa, l’Inghilterra e la Francia, con percentuali grossomodo costanti negli anni8.
Con la Prima guerra mondiale il carbone divenne scarso, a causa di tutte le problematicità determinate dal conflitto nelle attività di estrazione e di commercializzazione. Dunque, dopo una lunga fase di abbondanza e prosperità energetica nell’Ottocento e all’inizio del Novecento, dovuta all’aumento continuo dell’estrazione del carbone, alla capacità crescente di gestire l’elettricità, all’affiorare dell’impiego del petrolio e del gas naturale e al ritmo accelerato di scoperte in questi campi, la guerra mise per la prima volta i paesi di fronte al problema energetico. Fino ad allora tale eventualità era stata impensabile e quindi mai considerata dalla grande maggioranza della società, eccettuati Jevons e pochi altri.
Non si trattò soltanto di un problema economico che poteva compromettere la capacità degli stati, ma si presentò come un elemento di politica internazionale legato alle garanzie di sicurezza per ciascuno di essi, e con risvolti di politica interna. Tutti gli aspetti del settore energetico furono inscindibili dagli elementi politici e da quelli economici, e la questione comparve subito in tutte le sue sfaccettature: mantenimento del livello economico e capacità di ulteriore sviluppo, ruolo economico, politico e militare nello scacchiere internazionale, e soddisfacimento del livello di vita dei cittadini. Fu cosí che apparve per la prima volta sullo scenario internazionale il nesso tra «la sicurezza nazionale e la sicurezza energetica»9.
Con il trascorrere degli anni di guerra si evidenziò quanto nella gestione della risorsa non vi fossero state previsione e pianificazione, una mancanza aggravata dalla supposta breve durata del conflitto, che aveva indotto a non provvedere all’irrobustimento delle riserve. Cosí, prendendo coscienza della necessità di dover guardare a una pianificazione delle risorse carbonifere, negli ambiti nazionali si definirono con una maggiore attenzione le politiche energetiche, e nell’ambito internazionale si affermò un orientamento che chiamava in causa anche strumenti di cooperazione tra gli stati. Si intraprese la strada della collaborazione, con la creazione di una Commissione europea del carbone subordinata al Consiglio economico supremo, il cui compito doveva essere lo studio dei mezzi per assicurare le forniture all’Europa, e formata dai rappresentanti dei governi inglese, francese, italiano, belga, polacco e cecoslovacco; però in breve essa perse d’importanza10. Ma, terminato il conflitto bellico, la collaborazione sulla questione energetica continuò a essere trascurata e fu soltanto piú tardi, dopo la Seconda guerra mondiale, che in una nuova fase di crisi si perseguí la strada della cooperazione. Terminato il primo conflitto, inoltre, la questione energetica apparve in tutta la sua complessità, e anche pericolosità, nella contesa tra Francia e Germania sulle due aree carbonifere della Saar e della Ruhr.
Dopo la Prima guerra mondiale il centro del mercato mondiale rimase l’Europa, ma la modifica dei confini conseguente all’esito del conflitto ebbe un’incidenza sulla produzione di carbone. La Polonia divenne una protagonista nel mercato europeo in seguito all’acquisizione dell’Alta Slesia con i suoi giacimenti, importanti sia per la loro produzione sia per la posizione nel cuore del continente; non essendovi una significativa domanda interna, il governo favorí le esportazioni finanziando la costruzione di una flotta di navi carboniere, modernizzando i porti di Danzica e Gdynia, allacciandoli meglio mediante ferrovie, e autorizzando il taglio dei prezzi soprattutto per i mercati piú distanti11. Quanto all’altro grande produttore europeo, la Germania, per effetto del Trattato di Versailles la sua produzione scese fino a 181 milioni di tonnellate nel 1923, per riprendere a salire a gran ritmo nel 1924, passando da 243 milioni di tonnellate a 380 nel 193812.
Dal 1920 si modificarono le esportazioni, poiché diminuirono quelle inglesi, mentre crebbero quelle americane che divennero le piú importanti orientandosi soprattutto verso l’America Latina e verso il mercato europeo; crebbero anche quelle tedesche, russe, polacche e giapponesi, con andamenti alterni. Inoltre, diversi paesi si orientarono verso la ricerca dell’autosufficienza energetica con politiche commerciali nazionalistiche, operando per massimizzare la propria produzione. Germania, Francia, Belgio e Spagna lo fecero alzando barriere tariffarie e con politiche preferenziali, e fuori dall’Europa Cile e Argentina alzarono tasse sull’importazione e si volsero al petrolio13.
L’Inghilterra fu il paese che piú risentí dei cambiamenti. Prima del conflitto la sua ampia produzione permetteva agli esportatori di vendere a prezzo basso, ma ora a causa della non avvenuta modernizzazione degli impianti, dell’invecchiamento dei materiali ferroviari, di una trascuratezza nell’industria dei sottoprodotti e anche per la crescita dei salari e le richieste del movimento operaio, i costi di produzione divennero piú alti, in particolare rispetto a quelli di Germania e Polonia. Vi fu anche una mancata acquisizione di nuove quote di vendite. Francia e Italia, aumentando le necessità di carbone, continuarono a comprarne dall’Inghilterra ma aggiungendone una quantità di altra provenienza, che per la Francia derivò dalle riparazioni di guerra e dalle porzioni di territorio ottenute dalla Germania, e per l’Italia da acquisti da altri paesi europei14. L’Inghilterra cercò di conservare il commercio estero del carbone negoziando accordi bilaterali che le assicurarono una percentuale stabile di vendite; ma ormai non le era piú possibile mantenere la posizione avuta precedentemente15.
Dall’inizio del secolo la supremazia del carbone diminuí, erosa dallo spazio che conquistavano petrolio, gas naturale ed elettricità, mentre sempre piú marginale diveniva la competizione dei secoli precedenti con il legno, meno efficiente e piú costoso. Fu negli Usa che tale cambiamento iniziò e procedette piú celermente, essendo questo un paese con larga disponibilità delle tre fonti fossili: carbone, petrolio e gas naturale; qui il consumo di carbone dal 1900 al 1950 scese dal 71,4 per cento al 36,8 per cento, mentre quello del petrolio crebbe dal 2,4 per cento al 36,2 per cento16. Il petrolio fu il vero competitore, poiché offriva diversi vantaggi. Innanzitutto aveva una maggiore efficienza di potenza, ossia per generare una determinata quantità di energia occorreva una quantità di petrolio minore rispetto al carbone; per questo era meno ingombrante e quindi consumava meno spazio, richiedeva uno stoccaggio piú semplice e il lavoro d’immagazzinamento era piú facile rispetto a quello del carbone effettuato con meccanismi di spostamento articolati e spesso con aggiunta di un cospicuo lavoro manuale, il suo trasporto era meno complesso grazie alla ormai consolidata tecnologia degli oleodotti, e...