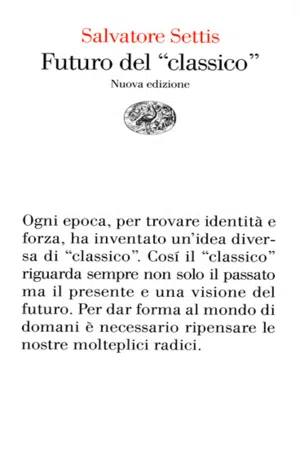1. Il “classico” nell’universo del “globale”.
Nel 1967, Arnaldo Momigliano tenne a Erice in Sicilia una lezione per studenti liceali (il contesto era il corso di orientamento preuniversitario organizzato dalla Normale di Pisa). Il suo tema era lo studio della storia antica, greca e romana. In quella lezione, per quel che so rimasta inedita, Momigliano cominciò con una domanda: perché si studia la storia antica? Ci sono due modi molto diversi, anzi opposti, di rispondere a questa domanda, egli disse allora: uno è di dire che tutte le vicende degli uomini, in ogni tempo e in ogni luogo, meritano studio e attenzione; l’altro, che le tracce del nostro passato (per esempio, in Italia) nella cultura, nella lingua, nei monumenti, nelle istituzioni, nel paesaggio, sono cosí imponenti da incuriosirci e da obbligarci a studiare il passato per capire una parte importante di noi stessi. Se stiamo alla prima risposta, a un italiano è del tutto indifferente studiare storia o arte dell’antica Cina o dell’antica Roma; se stiamo alla seconda, lo studio dell’antica Cina avrà un significato particolare per i cinesi, quello dell’antica Roma lo avrà per gli italiani; anzi, un europeo, per capire se stesso, dovrà considerare non solo gli antichi Romani, ma anche gli antichi Greci, gli antichi Ebrei e la cultura cristiana dei primi secoli come parti irrinunciabili e interconnesse delle proprie radici culturali. A quasi quarant’anni di distanza, vale ancora quella considerazione? In un’epoca dominata dalla retorica della globalizzazione, è ancora vero che il passato greco-romano è piú “nostro” di quello cinese? O il nuovo paesaggio culturale entro cui ci muoviamo ha reso obsoleto il bivio proposto allora da Momigliano, e spinge a cercare nuove strade?
Una risposta, superficiale ma assai diffusa, è che il passato “classico” ha una sua perenne attualità in quanto contiene e segnala le radici comuni della civiltà occidentale, offre all’Unione Europea un comune fattore identitario, incarna i grandi valori che, insieme alla tradizione giudaico-cristiana, accomunano le culture europee a quelle di matrice europea, dalle Americhe all’Australia. Questa risposta non convince: se le cose stessero cosí, infatti, non si capirebbe il progressivo, inesorabile arretrare della cultura “classica” nei sistemi educativi e nella cultura generale di tutti i Paesi che dovrebbero, stando alle dichiarazioni dei loro politici, rifarsi a quei valori immutabili e perpetui. Quello che va evidenziato e interpretato è dunque un curioso paradosso: via via che si sa (o si è disposti a imparare) sempre meno dell’antichità greca e romana, tanto piú si consolida nel nostro paesaggio culturale l’immagine delle civiltà “classiche” (specialmente la greca) come la radice ultima e unica di tutta la civiltà occidentale, come il deposito dei valori piú garantiti e piú alti (per esempio la democrazia). Tale immagine, potentemente operativa proprio perché data per scontata, resiste, e anzi si consolida, proprio mentre sempre piú marcato si va facendo, e proprio in Occidente, il distacco dal mondo “classico” della cultura piú condivisa e dei piú diffusi percorsi educativi. Meno sappiamo il greco e il latino, meno leggiamo (anche in traduzione) quelle letterature, e piú parliamo dei Greci e dei Romani, ma in modo sempre piú sclerotizzato, convenzionale, morto. Quanto piú persino gli intellettuali, i filosofi e i saggisti perdono (per propria scelta) la capacità e la voglia di controllare criticamente in prima persona lo spessore e il senso originario dei testi della cultura “classica”, tanto piú accanitamente essi vi cercano una vaga e incontrollata ispirazione, che prende quasi sempre la forma del piú arbitrario florilegio, delle citazioni fatte a caso (e tuttavia con valore legittimante).
Che in tal modo si pretenda di mascherare dietro la selva delle citazioni la sostanziale scelta di ignorare le civiltà “classiche”, è in fondo solo un male minore. Piú grave e insidioso è un altro aspetto di questo processo (davvero inarrestabile?): quanto piú generici e meno colti sono questi esercizi, tanto piú essi rischiano di innalzare la cultura “classica” sopra un piedistallo irraggiungibile, estirpandola dalla storia per proiettarla su un piano che si pretende universale, ma in realtà facendone arma e bandiera di una civiltà occidentale che possa poi rivendicare piú o meno copertamente la propria superiorità rispetto alle altre. Perché una risposta possibile alle ansie della globalizzazione culturale, al panico della perdita della propria identità (per omologazione e assorbimento in una qualche “globalità”) è la rivendicazione di identità locali “forti”, in grado di competere con quella temuta e mal definita globalità. La “civiltà occidentale” è certamente una di queste (tanto piú forte perché transnazionale), e il rischio di farvi appello senza specificarne coordinate e implicazioni si fa maggiore in tempi (come il nostro) di minacciati e praticati scontri fra tradizioni culturali spesso presentate come naturalmente e fatalmente opposte fra loro: per esempio, Oriente e Occidente; per esempio, cristianesimo e islamismo.
Non meno interessante è la constatazione che elementi, o frammenti, sconnessi e saltuari della tradizione “classica” emergono all’improvviso dove meno ce l’aspettiamo, e cioè nel cuore di grandi culture extraeuropee. Due soli esempi: Hayao Miyazaki, fra i piú grandi autori giapponesi di manga e anime (fumetti e cartoni animati), in quella che è forse la sua opera piú vasta e impegnativa (sette volumi nell’edizione italiana, 2000), racconta di un mondo post-tecnologico dove un’umanità respinta al margine dalla natura ostile e massicciamente inquinata cerca di sopravvivere, fra violenze tribali e scontri coi mostri che essa stessa ha creato. Una giovane principessa candida e non-violenta, in intima sintonia con la natura, porta il mondo alla salvazione. Il suo nome (che dà il titolo alla serie) è preso di peso da Omero: Nausicaa. Secondo esempio: subito dopo le stragi dell’11 settembre 2001 a New York e Washington, il primo commento del mullah Muhammad Omar, capo dei taliban afghani, paragonava l’America a Polifemo, «un gigante accecato da un nemico a cui non sa dare un nome», da un Nessuno. L’arcinemico della cultura occidentale, l’iconofobo distruttore dei colossali Buddha di Bamiyan, si presentava dunque al mondo come un lettore dell’Odissea, e attribuiva agli autori degli attentati l’astuzia di Ulisse.
Citazioni profondamente (in un caso: dolorosamente) sconcertanti, e per almeno due ragioni. Prima di tutto, perché ci vengono da fonti inaspettate, da fuori quella civiltà occidentale che secondo la piú comune retorica ha proprio nei Greci le sue radici comuni (ab Homero principium). Ma anche perché, prelevando dal compatto tessuto della narrazione omerica i nomi e l’ethos di Nausicaa, di Polifemo e di Odisseo per trapiantarli in ambiti cosí diversi e cosí lontani, esse sembrano ricalcare puntualmente la norma implicita in tanto citazionismo postmoderno, la scomposizione dell’antico in frammenti decontestualizzati, e perciò tanto piú pronti al riuso, ai piú arbitrari rimontaggi. Tanto piú, anzi, quanto piú essi siano gratuiti, senza implicare affatto quello statuto paradigmatico dell’antichità “classica” che per secoli ne ha assicurato nella tradizione europea la conoscenza e lo studio.
Ma è davvero cosí? Omero è davvero piú “nostro” che dei giapponesi o dei musulmani? Non dovremo sbalordire, piuttosto, per quanto quelle citazioni che vengono da cosí lontano sanno essere intense, appropriate, efficaci? O forse citazioni come queste (e sarebbe facile allungarne la lista: altri esempi al § 16) appartengono ormai a un assai piú vasto orizzonte globale, nel quale l’antichità “classica” debba avere un suo piccolo posto in mezzo a tante altre antichità – indiane, cinesi, maya –, tutte egualmente legittimate come altrettanti, equivalenti serbatoi di nomi, aneddoti, storie, citazioni, curiosità? Tutte con la loro sempre piú piccola pattuglia di specialisti, nessuna veramente patrimonio comune di una futura civiltà essenzialmente tecnologica, nella quale il remoto passato sarà sostanzialmente consegnato all’oblio? O (che è lo stesso) sarà ridotto a un retroterra nebbioso e indistinto, conservando semmai solo una qualche funzione ornamentale?
Una riflessione su questo tema non ha solo un riferimento di immediata attualità, rispetto tanto alle progettate riforme della scuola media superiore italiana quanto al continuo arretrare dello studio della cultura greca e latina che (anche senza quelle riforme) è sotto i nostri occhi; ma ha un significato e un ambito assai piú vasto, oltre il nostro tempo e il nostro Paese, e induce a interrogarsi sulla natura del “classico” e a chiedersi se esso abbia ancora una funzione nel mondo contemporaneo, o invece non ne abbia piú alcuna e debba sopravvivere solo come privato intrattenimento di sparuti e marginali cenacoli di specialisti. C’è tuttavia, e dovremo discuterne, un’opzione completamente diversa, e cioè di ripensare dalle radici la natura e la funzione del “classico” di marca occidentale, individuandone le peculiarità distintive (se ve ne sono) che siano rimaste in vita e abbiano ancora qualche significato, anche entro un contesto marcatamente multiculturale come il nostro.
Conciliare l’attenzione a un contesto tanto mutato con una puntuale consapevolezza storica del “classico” nella sua specificità è ambizione tutt’altro che ovvia. Vi si oppone in primo luogo la concentrazione ossessiva ed esclusiva sul contemporaneo, tanto caratteristica del nostro tempo, che allontana lo sguardo dal “classico” come, piú in generale, dalla storia, salvo la piú recente. Questa concentrazione sul contemporaneo si spiega forse per l’ansia di intendere l’enorme complessità di un mondo “globale”, limitandosi a conoscerlo quale esso è oggi (e lo sforzo è già grande). Ma gli eventi della storia (anche di uno o due secoli fa) tendono cosí a parere poco interessanti, oppure ad essere evocati saltuariamente in funzione dell’attualità politica (per esempio americana), dotandoli di una sorta di contemporaneità fragile ed effimera, con una data di scadenza. Il passato si appiattisce sul presente, viene assimilato ad esso in virtú del suo uso strumentale e costretto entro una soffocante simultaneità virtuale col presente, non tanto diversa dalla frequente petitio principii per cui si dà per scontato che le altre culture debbano condividere i valori della nostra. Si tende in tal modo a non riconoscere le diversità (nello spazio e/o nel tempo), o a minimizzarle; è in questo senso che secondo un professore di Berkeley, Nezar Al Sayyad, l’Europa sta abbandonando la propria memoria storica e non sa piú vedere se stessa come un prodotto della storia, ma identifica ormai la propria tradizione solo nella modernità, e cioè in valori dati per indiscutibili; ma allora «nessun cambiamento è piú possibile, una volta che l’ispirazione del cambiamento [la conoscenza del proprio passato] è stata sconfessata» (Kevin Robins). In questo nuovo orizzonte culturale, la concezione della storia come ininterrotta sequenza di eventi perde terreno a favore di un uso della storia come mero serbatoio di exempla, assemblati con sguardo sostanzialmente sinottico. Il ruolo del “classico” non è che un aspetto di questo processo assai piú vasto, ma è un aspetto molto rappresentativo, a causa della straordinaria centralità di questo tema nella storia culturale europea, ma anche perché quanto è etichettabile come “classico” si presta in modo speciale a un diffuso uso occasionale (come exemplum, appunto). Tuttavia, il “classico” può essere riscattato da un tal uso strumentale, purché ne venga recuperata e analizzata, con la necessaria acribia, la straordinaria complessità e singolarità.
Vale la pena di dire subito che – come vedremo – molte apparizioni o riapparizioni del “classico” hanno preso e prendono la forma non tanto della riscoperta, quanto della rinascita o del ritorno, quasi si trattasse di un fantasma dotato di propria volontà e personalità, capace di tornare allo scoperto quando meglio creda. Nella letteratura del Novecento, questo tema ha preso una forma peculiare, quella del ritorno degli dèi pagani nel mondo di oggi. Basti citare, a contrasto fra loro, due esempi, entrambi dal continente americano. In un poema di Ezra Pound (The Return, 1912), gli dèi rimettono piede sulla terra «con passo incerto e movenze esitanti, oscillando lievemente, muovendosi a tentoni, timorosi come si fossero appena ridestati: come neve che esiti mormorando nel vento, e quasi torni indietro». In un racconto di J. L. Borges (Ragnarök, 1960), gli dèi piombano in un’aula dell’università di Buenos Aires, fra gli applausi e le lacrime dei presenti. Ma presto si scopre che «secoli di vita fuggitiva e ferina avevano atrofizzato quanto in essi v’era di umano; la luna dell’Islam e la croce di Roma erano state implacabili con questi profughi. Fronti basse, denti gialli, baffi radi di mulatti o cinesi e musi bestiali mostravano la degenerazione della stirpe olimpica ... Bruscamente, sentimmo che erano astuti, ignoranti e crudeli come vecchi animali da preda ... estraemmo le rivoltelle, e gioiosamente demmo morte agli dèi». Sarebbe difficile evocare due immagini piú diverse di questo agognato e temuto ritorno. Gli dèi di Pound sono intatte figure dell’Olimpo, appena destate da un lungo sonno (secondo Yeats, «questi versi sembrano la traduzione da un ignoto poema greco classico»); quelli di Borges si sono mescolati e meticciati, sono irriconoscibili, e perciò vanno uccisi.
Ma forse Yeats aveva torto: nessun poeta antico avrebbe mai scritto le parole di Pound; forse gli dèi degli Antichi non furono mai immacolati e gelidi come la neve. Forse, al contrario, gli Olimpî non hanno mai rifiutato (non hanno mai smesso) di mescolarsi con gli uomini, e non solo in Grecia. Apollo ebbe dimora a Delo e a Delfi, ma volava ogni tanto nel remoto Nord, fra gli Iperborei; Dioniso errava fra l’Egitto, la Siria, la Tracia, l’Arabia, la Persia, l’India; Afrodite non nacque a Cipro, ma vi sostò nel suo lungo viaggio da Oriente a Occidente; lo stesso Zeus si recava in visita agli Etiopi, e non sarebbe neppure stato il signore dell’Olimpo, se non lo avessero nutrito in una grotta di Creta i Cureti, venuti dalla Frigia. Alcuni altri dèi, dopo aver migrato lungo le vie della seta, ricompaiono a distanza di secoli, trasfigurati ma riconoscibili pur nel contesto di un altro politeismo, nell’arte giapponese (è questo il caso di Hermes, Borea, Eracle e Tyche). Come gli dèi porteños di Borges, da sempre gli Olimpî si sono meticciati con altre genti e culture: se esitiamo a riconoscerli in vesti che ci appaiono impure, è perché noi stessi ne abbiamo ri-creato (per nostro uso) un’immagine incontaminata, splendente come il marmo o la neve, ma non necessariamente vera. Forse, invece di inseguire il “classico” solo sul nevoso Olimpo, sulle vette inaccessibili, dobbiamo invece cercarlo sulla terra, dargli nome e sostanza ripercorrendone la storia.
2. La storia antica come storia universale.
Rispetto agli sperimentati usi e riusi del “classico”, le sue due metà, i Greci e i Romani, sono fortemente asimmetriche. È vero infatti che la storia romana aspira di per sé (per l’estensione stessa dell’impero, dalla Scozia al Mar Rosso e dal Portogallo al Danubio) alla condizione di storia universale, della storia di un “mondo conosciuto” che in qualche modo inglobava persino vaghe nozioni non solamente dell’India ma addirittura della Cina, e solo escludeva i continenti “nuovi”, da scoprirsi assai piú tardi. È vero che all’impero romano si rifecero non solo quello di Bisanzio, che ne fu legittima continuazione fino al 1453 (e chiamò se stesso sempre “romano” e mai “bizantino”), ma anche quello di Carlo Magno, di Federico II, di Carlo V, il Sacro Romano Impero fino a Napoleone, e infine Napoleone stesso; a Est, l’impero “post-bizantino” degli zar (un titolo che, come quello germanico di Kaiser, perpetua il nome dei Cesari e la memoria del loro impero). E se in Roma si radicò e si radica la Chiesa cattolica, con la sua conclamata missione universale, ciò è avvenuto proprio perché quella era, nei secoli di fondazione della nuova religione, la capitale dell’impero, da cui proviene una persistente spinta ecumenica (in senso proprio, prima che traslato: oikoumene è infatti in greco l’insieme delle terre abitate). Eppure, le rivendicazioni di universalità e di validità perpetua del “classico”, ormai da molte generazioni, puntano piuttosto sulla piccola Grecia, che fu una provincia romana fra le tante e che prima di Roma era stata dilaniata da lotte intestine fra le sue mille città-stato; che aveva trovato effimera unità solo a prezzo della perdita della libertà delle poleis, e sotto i sovrani macedoni, gli stessi che avevano sospinto le frontiere della grecità fino all’Indo e al Nilo, e di fatto unificato culturalmente il Mediterraneo orientale.
Greco e latino furono le due lingue dell’impero, e poi quelle dei due imperi, d’Oriente e d’Occidente, secondo una linea di frattura ancor oggi viva e vitale nella separazione fra le Chiese occidentali e quelle ortodosse. Ma la priorità culturale della Grecia, come originaria culla di valori e di idee “classici”, e dunque occidentali, è un filo che percorre la storia europea degli ultimi secoli, quasi che l’immensa compagine dell’impero romano (che abbracciò di fatto quasi tutta l’Europa di oggi, ma anche il nord dell’Africa e alcune regioni asiatiche) sia tenuta in vita, nella nostra memoria culturale, da una linfa e da un sangue in prevalenza greci. Al punto che, nonostante il loro immenso e spietato potere, i Romani appaiono a volte, nello sbiadito scenario della memoria culturale corrente, solo come mediatori della cultura greca, come Greci “di secondo grado”. Al punto che anche in paesi come la Germania o l’Inghilterra (e cioè in aree culturali dove durante l’età “classica” nessuno sapeva nulla dei Greci) è potuto accadere che si additasse nei Greci (e non nei Romani) le proprie radici d’elezione.
Per fare un esempio solo, John Stuart Mill poté scrivere nel 1859 che «la battaglia di Maratona, anche come evento della storia inglese, è piú importante della battaglia di Hastings. Se in quel remoto giorno il risultato dello scontro fosse stato diverso (se i Greci non avessero vinto), Britanni e Sassoni forse vagherebbero ancora per le selve». Questa e cento altre citazioni simili, che sarebbe anche troppo facile evocare, presuppongono che le radici comuni della civiltà occidentale, scavalcando i confini dei popoli e le barriere dei tempi, risiedano nella grecità “classica”. Insomma, il mito di una “classicità” originaria e comune si traduce nella concezione della storia greca come storia universale, o meglio come un suo snodo essenziale, necessario a intendere il mondo moderno, a partire dalle sue conseguenze per noi (o da quelle che decidiamo di prendere per tali). Eppure, quest’immagine della storia greca come storia universale ha bisogno dei Romani non solo come mediatori culturali, ma soprattutto per l’impalcatura istituzionale, militare e amministrativa con la quale l’impero di Roma creò per la cultura “classica” il contesto appropriato perché essa si radicasse e si diffondesse nello spazio e nel tempo. Intravvediamo in tal modo due immagini diverse e complementari del nostro debito con la “classicità”, posto che ve ne sia uno: nella prima, essa è soprattutto romana (grazie all’espansione dell’impero, all’unificazione culturale che comportò e ai valori che resero possibile l’intero processo), pur includendo elementi greci in posizione privilegiata; nella seconda, il “classico” coincide con la civiltà greca nei suoi momenti piú alti, e i Romani non ne sono che i primi eredi e diffusori, secondo il motto oraziano, mille volte ripetuto, Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio [«Conquistata, la Grecia conquistò il suo selvaggio vincitore, e introdusse le arti nel Lazio agreste»].
Ma queste dispute sul peso relativo dei Greci e dei Romani nella formazione dei valori occidentali (sulle quali torneremo) non toccano il cuore del problema, in quanto danno per scontata la centralità della matrice “classica”, il suo valore fondante, la sua natura di “storia universale”. Come un monumento provato ...