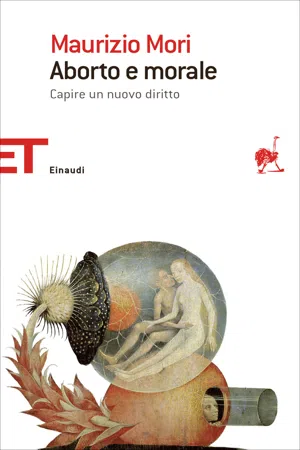
eBook - ePub
Aborto e morale
Capire un nuovo diritto
Maurizio Mori
This is a test
Share book
- 152 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Aborto e morale
Capire un nuovo diritto
Maurizio Mori
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
A trent'anni dalla Legge che in Italia ha legalizzato l'interruzione della gravidanza, il tema dell'aborto è tornato al centro dell'attenzione pubblica con una forza e con toni nuovi rispetto al passato. Il libro di Maurizio Mori, che in primo luogo ripercorre brevemente la storia della moralità dell'aborto in Occidente, mette in chiaro le posizioni in campo, e soprattutto si interroga sulla giustificazione razionale del divieto di aborto. Uno sguardo lucido e un ragionamento pacato e competente per chiarire un tema controverso. Il volume è corredato da un glossario e una bibliografia.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Aborto e morale an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Aborto e morale by Maurizio Mori in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Scienze sociali & Cultura e tradizioni. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
Scienze socialiSubtopic
Cultura e tradizioniUn saggio per riflettere
Esiste una giustificazione al divieto d’aborto?
L’embrione è persona dal concepimento?
Abbiamo visto nella parte precedente che per l’antiabortista la moralità o immoralità dell’aborto è determinata dalla risposta data a una sola domanda: «l’embrione è persona o no dal concepimento?» È giunto il momento di esaminare con cura tale questione che – pur essendo ovvio, è forse bene dirlo! – non è un problema comune o ordinario, cioè analogo a quelli che affrontiamo nella vita di tutti i giorni. Si tratta invece di un problema abbastanza peculiare e tecnico che coinvolge difficili tematiche, per cui sono indispensabili almeno le due seguenti precisazioni preliminari.
1) Vogliamo sapere se l’embrione sia una persona in atto, e non tanto una persona in potenza. Quando si dice che una cosa X è potenzialmente una certa cosa Y, si intende dire che X non è Y, anche se ha la capacità intrinseca di diventare Y. Cosí, quando di un bravo studente in ingegneria si dice che è un potenziale ingegnere, si intende affermare che non è ancora ingegnere, anche se ha le capacità per diventarlo; e quando si dice che una ghianda è potenzialmente una quercia, si intende affermare che non è la quercia, anche se ha la capacità di diventarlo e lo diventerà in presenza di favorevoli condizioni di sviluppo, essendo già iniziato un processo teleologico che porterà dallo stato di «ghianda» a quello di «quercia». È decisivo sottolineare che il dire che l’embrione è potenzialmente una persona è del tutto diverso dal dire che è già una persona in atto perché questo ci ricorda che il processo generativo comporta sostanziali cambiamenti: noi proveniamo da qualcosa di molto diverso da quel che siamo. Questo significa riconoscere che il seme non è l’esemplare adulto ed è sostanzialmente diverso da esso, anche se ha in sé la capacità intrinseca di autotrasformarsi nell’adulto (l’uovo è sostanzialmente diverso dal pollo che ne deriva).
2) Deve essere ben chiaro che la posizione dell’antiabortista presuppone che l’embrione sia già una persona (in atto), e non semplicemente che sia vita umana, o un essere umano, o un uomo ecc. Poiché nel linguaggio comune tutti questi termini sono spesso sinonimi, si può essere portati a usarli in modo intercambiabile, ma è proprio a questo punto che si ripresenta l’esigenza di un rigoroso linguaggio tecnico sopra avanzata.
Gli antiabortisti di solito affermano che tali distinzioni sono meri giochi o tranelli linguistici, dettati dal gusto (malvagio) per le sottigliezze, e quindi è bene chiarire subito quali sono le ragioni che portano a tracciare la distinzione sopra indicata, in modo da fugare eventuali riserve in materia.
Distinguere tra «vita umana» e «persona».
L’osservazione di partenza è che, in Occidente, la persona (fisica) è un ente che gode di speciali tutele e diritti. Questa situazione di «privilegio» è giustificata dal fatto che la persona sembra avere alcune proprietà del tutto peculiari che si fa fatica a esplicitare analiticamente, perché comportano qualcosa di ineffabile che di solito è colto piú facilmente dai poeti. Come dice Amleto:
Che opera d’arte è l’uomo! Quanto nobile per la sua ragione, quanto infinito per le sue facoltà, quanto espressivo e ammirevole per le sue forme e per i suoi movimenti; quanto simile ad un angelo per le sue azioni; quanto simile a un dio per la sua capacità di apprendere! (Atto II, scena II).
In altre parole, la persona sembra avere caratteristiche tali da farci credere che, in qualche senso, essa trascende la natura fisico-organica collocandosi cosí al di sopra del mero mondo naturale, ed è proprio questa particolare trascendenza che giustifica la speciale tutela a essa attribuita.
Quest’idea circa la trascendenza della persona è ampiamente diffusa, ma non è condivisa da tutti: i sostenitori del «materialismo duro» (hard materialism) affermano un radicale riduzionismo*, per cui anche la persona altro non sarebbe che un insieme di molecole piú complicato e quindi completamente spiegabile in termini fisico-chimici. Pur essendo sostenuta da valenti scienziati, e importante perché ci costringe a precisare meglio la nozione di persona e i presupposti a essa sottesi, questa posizione può qui essere abbandonata, sia perché chi accetta tale versione del materialismo deve poi ristrutturare l’intera visione del mondo diffusa in Occidente e cambiare la nozione stessa di moralità (e quindi anche il modo di giudicare l’aborto), sia perché a ben vedere la maggior parte dei biologi rifiuta il riduzionismo radicale: si osserva che la vita è un processo variegato e caratterizzato da livelli di organizzazione diversi e tali che l’aumento della complessità nell’organizzazione porta all’emergenza* di nuove caratteristiche che non erano presenti ai livelli inferiori di organizzazione e che non sono completamente spiegabili (riducibili) in base a essi.
In questo senso, le forme piú semplici di vita emergono dal mondo fisico-chimico (inorganico) e non sono riducibili a esso, e cosí via per i livelli successivi. In questo modo possiamo render conto delle differenze sostanziali tra il mondo inorganico e quello organico, e le altre differenze sostanziali interne al mondo organico. Come ha scritto il grande biologo Theodosius Dobzhansky,
il processo evolutivo non scorre come un fiume calmo, sempre alla stessa velocità. Può avere periodi di relativa calma ed altri di intensa innovazione. L’origine della vita e l’origine dell’uomo sono state crisi evolutive, punti di svolta, attualizzazioni di forme nuove di essere. Le innovazioni radicali possono venire descritte come «emergenze», o «trascendenze», presenti nel processo evolutivo. Nessuno di questi termini è esente da connotazioni indesiderabili, ma «trascendenza» sembra preferibile [...] L’evoluzione non è semplicemente lo spiegamento di ciò che era già presente sin dall’inizio in stato nascosto. È una fonte di novità, di forme di essere che non c’erano affatto negli stati ancestrali.
Questa prospettiva non-riduzionista ci offre buone ragioni per continuare a sostenere la nostra visione diffusa nel mondo occidentale, e con essa l’idea che la persona (in qualche senso) trascende il mondo naturale (biologico), presentando una differenza sostanziale rispetto a esso.
Ma nel momento in cui accettiamo questa visione non-riduzionista dobbiamo anche riconoscere che quella di persona è una nozione appartenente non alla biologia, ma alla filosofia intesa in senso lato: la biologia – in quanto scienza naturale – si occupa solamente del mondo organico, mentre è alla filosofia che assegniamo il compito di studiare i fenomeni culturali, ossia quei fenomeni che trascendono la natura organica. Quest’aspetto è ben colto dal linguaggio filosofico tradizionale secondo cui la persona è il composto di corpo (umano) e anima (razionale), dove la natura spirituale dell’anima non lascia dubbi sulla radicale (o sostanziale) differenza tra la persona e il resto della natura. Oggi possiamo forse abbandonare l’idea che ci sia una speciale «sostanza spirituale», ma non che con persona indichiamo quell’ente che ha peculiari caratteristiche non-naturali, ossia trascendenti il mondo organico-materiale (che per comodità possiamo continuare a chiamare ancora «anima»).
Le considerazioni fatte – stimolate soprattutto dalla necessità di replicare al materialismo duro – sono sufficienti a chiarire una ragione che rende necessaria la distinzione terminologica proposta: «persona» è termine tecnico che indica con precisione il composto di anima e corpo; mentre non possiamo dire la stessa cosa di termini come «vita umana», «essere umano», «uomo» ecc. È vero che nel linguaggio comune questi termini sono tra loro sinonimi, ma ciò dipende dal fatto che il linguaggio comune si riferisce a quelle situazioni normali e ordinarie in cui la vita umana (o l’essere umano) si accompagna sempre anche alle caratteristiche non-naturali (speciali) proprie della persona. Tuttavia il linguaggio comune è inadeguato alla situazione in esame che – come abbiamo visto – non è né normale né ordinaria: anzi, questa situazione è del tutto unica e diversa dalle altre, proprio perché riguarda quel processo generativo che comporta i radicali (o sostanziali) cambiamenti tipici del passaggio dalla fase di seme a quella di esemplare adulto. Credere che il linguaggio comune sia adeguato a trattare tale questione è come credere che i normali coltelli da cucina (adatti a tagliare il pane ecc.) siano adeguati per eseguire anche delicate operazioni chirurgiche al cervello.
Ma c’è anche un’altra ragione per introdurre una rigorosa distinzione terminologica tra persona, vita umana ecc. Infatti, «vita umana» ed «essere umano» sono anche termini del linguaggio tecnico della biologia: il biologo studia le varie forme di vita organica e tra queste anche quella umana. In questo senso «vita umana» indica la «vita degli organismi appartenenti alla specie homo sapiens», cioè la vita del solo corpo a prescindere dall’anima. La presenza di questo significato tecnico del termine rende ancor piú necessaria la distinzione terminologica: il biologo non si occupa né può occuparsi della «persona», perché tale termine non appartiene alla sua disciplina (non essendo l’anima oggetto di studio di una scienza naturale quale la biologia). D’altro canto il nostro problema riguarda proprio la persona (e non la semplice vita umana), perché solo per la persona è giustificata la speciale tutela. Pertanto, coloro che pretendono di affrontare il problema morale dell’aborto affidandosi al solo discorso biologico, credendo di poter evitare il discorso filosofico (che a loro giudizio è inconcludente), in realtà non fanno altro che precludersi la possibilità di affrontare il vero problema in discussione.
L’errore logico insito nel cosiddetto «argomento scientifico».
La necessità di un linguaggio rigoroso diventa ancora piú urgente ove si consideri che la mancanza di precisione terminologica sta alla base di quell’esiziale errore che vizia il cosiddetto argomento scientifico*, secondo cui sarebbero proprio le conoscenze biologiche a dimostrare direttamente che al concepimento c’è già la persona: insomma, assodati il principio morale di eguaglianza e l’unanime condanna dell’omicidio, basterebbe poi la sola biologia per risolvere il problema morale dell’aborto.
Ma l’argomento scientifico è fuorviante, perché la scienza ci dice solamente che alla fecondazione si forma un essere umano (un corpo), ma non può dirci nulla della persona (il composto di anima e corpo). Quest’ultimo termine, infatti, non appartiene al linguaggio della biologia (che, in quanto scienza naturale, si occupa solo del corpo e non dell’anima). Diventa chiaro il tipo di errore implicato: chi propone l’argomento scientifico confonde due linguaggi diversi. Dapprima usa «essere umano» in senso tecnico biologico (dove tale termine indica solo il «corpo»), e poi lo usa in senso comune (dove è invece sinonimo di persona: «anima e corpo»). Infine, forte del fatto che nel linguaggio comune quei termini sono tra loro sinonimi, conclude che la biologia dimostrerebbe che al concepimento si forma la persona. Ma non appena usiamo i termini con precisione e rigore, l’errore diventa palese e la conclusione si dissolve: il lettore è invitato a controllare i vari passaggi del discorso e a valutarne la correttezza.
A questo punto è forse opportuno ricordare che anche il magistero cattolico rifiuta esplicitamente l’argomento scientifico: nella Dichiarazione sull’aborto procurato (1974) afferma che «non spetta alle scienze biologiche dare un giudizio decisivo su questioni propriamente filosofiche [...] come quelle del momento in cui si costituisce la persona umana» (nota 13, il corsivo è mio), dal momento che «l’esistenza di un’anima immortale non appartiene al suo campo» (nota 19).
Di fatto, molti antiabortisti ormai riconoscono che l’argomento scientifico è insufficiente e fallace, e che la biologia di per sé non dimostra (né può dimostrare) che l’embrione è persona. Tuttavia, alcuni hanno modificato questa posizione osservando che è la corretta interpretazione (filosofica) dei dati scientifici che conduce a tale conclusione: le conoscenze biologiche sono rilevanti non piú direttamente (come si presuppone nell’argomento scientifico) ma solo indirettamente, anche se ciò non pregiudica la conclusione che l’embrione è persona dalla fecondazione.
La corretta interpretazione dei dati scientifici dimostra che l’embrione non è persona.
Dovendo esaminare questa nuova proposta, possiamo cominciare osservando che solitamente si appoggia a due ordini di dati scientifici: il primo riguarda la formazione dell’embrione e mette in luce che:
appena l’ovulo e lo spermatozoo interagiscono tra loro, ha immediatamente inizio un nuovo sistema, che comincia a operare come una «nuova unità», intrinsecamente determinata, che ha il suo centro biologico o struttura coordinante nel nuovo genoma («La civiltà cattolica», IV, 1992, n. 3420, p. 557).
L’altro dato riguarda lo sviluppo dell’embrione, che – si sottolinea – presenta tre fondamentali caratteristiche: coordinazione, continuità e gradualità del processo. Un’attenta interpretazione di questi dati scientifici porterebbe alla conclusione che l’embrione è persona dal concepimento, perché in quel momento il nuovo sistema inizia il suo ciclo vitale che continua poi ininterrotto.
È vero che al concepimento si forma un nuovo sistema biologico (il corredo cromosomico*), ma questo di per sé non è altro che una sequenza di DNA rivestita da proteine (un pezzo di materia), per cui – se davvero nel corso dello sviluppo seguente non emergessero altre «novità» e non ci fossero altri cambiamenti significativi – la logica ci costringerebbe a concludere che l’uomo maturo altro non è che un insieme di materia piú complicata e completamente spiegabile in termini fisico-chimici (proprio come vogliono i materialisti). Se si vuole continuare ad affermare la «trascendenza» della persona, si deve riconoscere che durante il processo riproduttivo avvengono rilevanti cambiamenti sostanziali, perché il seme (da cui proveniamo) è qualcosa di meramente materiale e radicalmente diverso dalla persona. Né sembra plausibile credere che tale trasformazione decisiva (o cambiamento sostanziale) avvenga immediatamente alla fecondazione quando si forma il «nuovo sistema» biologico: infatti, questa prospettiva per un verso è contraria alla (peraltro riconosciuta) gradualità dei cambiamenti biologici, che richiedono tempo; e per un altro non considera che il corredo cromosomico di per sé non ha sviluppato la complessità richiesta da cui emergono i cambiamenti e le novità. Per questo l’interpretazione sopra proposta viene inevitabilmente a presupporre una nuova versione di preformismo, diversa da quella del XVII secolo, perché mentre allora si poneva l’homunculus nel gamete oggi lo si pone nell’ovulo fecondato. Ma l’errore è lo stesso, e sta nel credere che nell’ovulo fecondato ci sia già una persona in miniatura e preconfezionata che aspetta solo di crescere quantitativamente (cosicché la «gradualità» dello sviluppo riguarderebbe solo quest’aspetto), e alcuni lasciano intendere che sarebbe già visibile se avessimo microscopi piú potenti di quelli oggi disponibili.
In realtà le cose stanno diversamente, tanto che neanche l’analogia diffusa dell’ovulo fecondato contenente il «progetto» o il «programma» del futuro organismo sembra essere adeguata. L’antiabortista afferma di solito che già quest’analogia è sbagliata, perché già essa sottolineerebbe troppo la sostanziale differenza esistente tra il progetto della casa e la casa finita (distruggere il foglio su cui c’è il progetto della casa non è distruggere la casa!)
Ma, in realtà, nel caso dell’ovulo fecondato la differenza sembra essere ancora maggiore di quella suggerita dall’analogia, perché un progetto indica già con precisione come sarà la casa (per esempio dove saranno le porte, le prese della luce ecc.), mentre nell’ovulo fecondato non è determinata la posizione dell’occhio, del naso ecc. L’ovulo fecondato sa come dividersi in due, in quattro ecc., ma in esso non è affatto stabilita la sorte e la posizione di ciascuna cellula: di fatto, due gemelli omozigoti hanno impronte digitali diverse, e questo è una chiara conferma che anche caratteristiche molto semplici (come le impronte) non sono già stabilite né definite nel corredo cromosomico, ma si sviluppano in seguito attraverso complesse interazioni tra le varie parti e l’ambiente. Ancora, non è stabilito quali cellule di un embrione di 8 o 16 cellule andranno a formare la placenta e quali il feto vero e proprio, e ciascuna cellula può andare a formare l’una o l’altro; se poi una cellula finisse per dare origine al feto, può ancora andare a formare varie strutture del corpo; e ove andasse a far parte dell’ectoderma, la parte da cui deriva il sistema nervoso, può contribuire a diverse sue parti. Queste osservazioni sono fatte per ricordare che nell’ovulo fecondato non c’è affatto quel rigido progetto prefissato che può far pensare alla presenza di una persona preconfezionata in miniatura: c’è la teleologicità del processo biologico, che si precisa pian piano al formarsi delle varie parti che, interagendo tra loro (e con l’ambiente), danno origine a nuovi livelli di complessità e all’emergenza di nuove proprietà.
Non è facile spiegare in poche parole il concetto di sviluppo biologico, che, attraverso una serie di cambiamenti, porta un certo processo (il seme) a diventare qualcosa di molto diverso da ciò che era all’inizio (l’esemplare adulto). Ma il preformismo è ridicolo, perché è sbagliato credere che tale sviluppo biologico non sia altro che una mera crescita quantitativa di ciò che è presente sin dall’inizio. A prima vista questa concezione sembra accettabile perché appare piú semplice, ma a ben vedere il preformismo è assurdo quanto il credere che nei semi della vite ci sia già il vino, o nei semi dell’arancio già l’aranciata. Certamente il vino (o l’aranciata) deriva dai semi della vite (o dell’arancio) grazie a un processo che è coordinato, continuo e graduale, ma senza dubbio c’è una radicale e sostanziale differenza tra lo stato iniziale e quello finale del processo!
Chi invece ritiene cruciale la fecondazione deve necessariamente sostenere che in tale brevissimo lasso di tempo avviene quel sostanziale cambiamento che fa passare il seme (un pezzo di materia) immediatamente in una persona (un ente trascendente il mondo materiale), scavalcando drasticamente la gradualità del cambiamento propria dei processi biologici.
Le considerazioni precedenti gettano altri seri dubbi sul fatto che l’interpretazione dei dati biologici menzionati (coordinazione, continuità e gradualità del processo) riesca davvero a sostenere la conclusione che il feto è persona dal concepimento. Ma per dare una risposta piú precisa al problema della corretta interpretazione dei dati biologici sembra necessario esplicitare meglio la nozione stessa di persona, perché solo avendo chiaro lo scopo della ricerca possiamo valutare l’adeguatezza dell’interpretazione. Si richiede quindi una piú puntuale e precisa definizione di persona.
Una definizione adeguata: persona come «in...