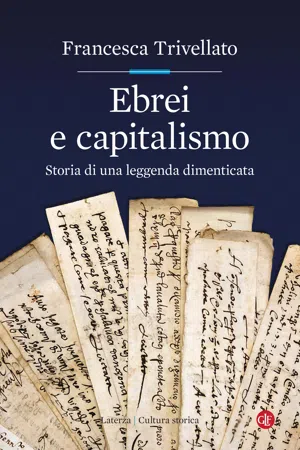1.
I retroscena: l’assicurazione marittima
e le lettere di cambio
Le polizze d’assicurazione, e le lettere di cambio, furono sconosciute all’antico diritto romano e sono un’invenzione postuma degli ebrei, secondo l’osservazione di Giovan[ni] Villani nella sua storia universale1.
Migliaia di lettori hanno avuto sotto gli occhi questo brano da quando fu dato alle stampe per la prima volta, nel 1647, eppure ancora adesso non sappiamo come interpretarlo. L’affermazione è evidentemente falsa: gli ebrei non inventarono né l’assicurazione marittima né le lettere di cambio. Ciononostante, per ben tre secoli, queste parole catturarono l’immaginazione di un gran numero di autori, alcuni tuttora celebri, altri ormai dimenticati ma un tempo letti da un ampio pubblico. Con questo libro mi prefiggo un duplice obiettivo: non solo dimostrare che questa narrazione delle origini della finanza europea in passato fu talmente diffusa che possiamo a buon diritto inserirla nel novero delle leggende, ma anche scavare nella sua formulazione e nei suoi adattamenti, per ripensare l’incontro dell’Occidente con la modernità economica2.
Il brano sopra citato, secondo cui gli ebrei avrebbero inventato l’assicurazione marittima e le lettere di cambio, proviene da una raccolta di diritto marittimo compilata e annotata da un avvocato francese di provincia, Étienne Cleirac, che uscì a Bordeaux sotto il titolo Us et coustumes de la mer. Oggi dimenticato, così come la storia che tramandava, il volume riscosse all’epoca un enorme successo. In questo capitolo e nei due che seguono, ne prenderò in esame alcune sezioni, cercando di chiarire ogni riferimento storico e testuale contenuto nelle tre righe citate poc’anzi e nella più ampia chiosa – circa sette pagine a stampa – in cui compaiono3. In questo modo intendo mettere in evidenza i significati espliciti e, più ancora, svelare quelli impliciti che dovevano apparire pressoché scontati ai lettori contemporanei. Comincerò col descrivere le caratteristiche dei due strumenti finanziari evocati da Cleirac – l’assicurazione marittima e le lettere di cambio –, per poi indagare le conoscenze e le aspettative del suo pubblico di lettori. Quindi, nei capitoli 2 e 3, passerò in rassegna la sorprendente varietà di citazioni che Cleirac cucì intorno a questo racconto sulle origini del credito, tra le quali la falsa attribuzione del ruolo degli ebrei al cronista fiorentino Giovanni Villani (m. 1348).
La prosa di Cleirac è confusa e barocca persino per i canoni dell’epoca – lo si noterà dai brevi estratti che verranno presentati, pur avendoli scelti tra i meno tortuosi e avendoli parzialmente normalizzati nel tradurli, per renderli più comprensibili –, ed è per questo che le sue parole vanno analizzate quasi una per una. Da questa esegesi si evince come il suo bric-à-brac di citazioni – che spazia dall’apostolo Paolo a Matteo Paris, dai cronisti francesi ai teologi gesuiti, da Dante ad Ariosto e molti altri ancora – nascondeva una preoccupazione costante: la necessità, e la difficoltà, di distinguere, in un mercato sempre più anonimo, i buoni creditori da quelli cattivi e gli usi legittimi degli strumenti di credito da quelli scorretti. La leggenda che Cleirac affidò alla pagina stampata si rivelò una risposta attraente, benché inadeguata, allo spinoso problema di dove tracciare la linea di confine tra i rapporti di credito appropriati e quelli indegni, un problema sollevato dalla rivoluzione commerciale del Medioevo e reso ineludibile dalla progressiva diffusione di nuovi strumenti finanziari nel corso del XVI secolo.
La mia interpretazione ha qualche lontano debito verso la lettura sintomatica, ovvero una modalità di analisi attraverso la quale i critici tentano di ricostruire i significati latenti che si trovano sotto la superficie del testo4. In questo modo mi sforzo di riportare alla luce una retorica di notevole forza seduttiva che attingeva alle definizioni cattoliche medievali di usura per adattarle a un contesto in cui l’assicurazione marittima e la lettera di cambio si erano ampiamente diffuse.
Perché assicurazione marittima e lettere di cambio?
La frase citata in apertura, che condensa la leggenda sulle presunte origini ebraiche dell’assicurazione marittima e della lettera di cambio, compare nella chiosa di Cleirac al primo articolo del Guidon de la mer (Lo stendardo del mare), un compendio di norme marittime emanato a Rouen nella seconda metà del XVI secolo e ripreso all’interno degli Us et coustumes de la mer5. Il Guidon, come suggerisce il titolo del suo primo articolo («Dei contratti o polizze di assicurazione: definizione, conformità e differenze rispetto agli altri contratti marittimi»), era dedicato all’assicurazione marittima e non accennava alle cambiali. Fu Cleirac a collegare tra loro questi due strumenti finanziari. Pur essendo storicamente infondata, la sua argomentazione non era priva di logica: dopo aver inventato la lettera di cambio – sosteneva –, gli ebrei inventarono anche l’assicurazione marittima per proteggere il valore dei beni che avevano lasciato nei paesi da cui erano dovuti fuggire e da dove erano tratte le cambiali.
L’assicurazione marittima e la lettera di cambio furono tra i più importanti sottoprodotti della rivoluzione commerciale del XIII secolo che, a differenza della rivoluzione industriale avvenuta cinque secoli dopo, fu innescata da cambiamenti non tecnologici ma istituzionali. Questi due contratti resero più semplice agli investitori condurre i propri affari senza mettersi in viaggio, e costituirono di fatto il tessuto connettivo del commercio europeo a lunga distanza6. Allo stesso tempo, sia l’una che l’altra divennero oggetto di animati dibattiti teologici e canonistici in materia di usura.
Nessun individuo o gruppo fu responsabile dell’invenzione di questi strumenti creditizi: entrambi scaturirono dopo una lunga incubazione e furono il risultato di una progressiva evoluzione che giunse a compimento nel XVI secolo7. Questo processo di formazione fu caratterizzato da tre aspetti principali. Primo, l’incertezza: benché l’assicurazione e la cambiale fossero pensate per facilitare le transazioni a lunga distanza, esistevano notevoli differenze nelle norme locali che regolavano la loro emanazione e il loro uso, e tali differenze generavano inevitabilmente incertezza. Secondo, la standardizzazione e la diffusione: nel corso del tempo le polizze e le cambiali divennero di uso sempre più comune, subirono una progressiva uniformazione tipologica, ma nel frattempo divennero anche strumenti più complessi e sofisticati, col risultato che le formule in esse contenute si fecero sempre più oscure agli occhi dei meno esperti. Terzo, la natura privata dell’accordo: in Età moderna i mercanti non avevano bisogno di sottoscrivere davanti a un notaio questi (e anche altri) contratti d’affari. Allora come oggi, nei paesi di tradizione romanistica, i notai erano ufficiali pubblici che, in cambio di un modesto compenso, rilasciavano documenti accettati come prove in tribunale. Per questo, tanto i ricchi quanto i poveri andavano dal notaio per tutelare i propri diritti di proprietà. I mercanti facevano tuttavia eccezione poiché il numero di documenti che passavano per le loro mani era talmente alto da rendere impensabile che ciascuna delle loro transazioni potesse essere certificata da un notaio; e la loro firma apposta a un contratto stilato in conformità alle norme scritte e alle pratiche condivise divenne presto sufficiente come prova legale. A partire dalla metà del XIV secolo, anche le lettere di cambio cessarono di essere sottoscritte davanti a un notaio, diventando un documento esclusivamente privato8.
Ai fini del nostro discorso, quest’ultimo cambiamento ebbe due conseguenze importanti. Per prima cosa conferì ai mercanti un margine di autoregolamentazione insolitamente alto, dal momento che nessun altro gruppo sociale nei paesi in cui vigeva il diritto romano poteva autocertificare i propri diritti di proprietà. Inoltre, in alcune città dell’Europa occidentale tale prerogativa venne estesa anche ai mercanti ebrei, che potevano dunque far valere i propri documenti di fronte ai giudici cristiani senza bisogno di recarsi da un notaio. Questo quadro normativo, pensato per rendere più generalizzato l’accesso al mercato, facilitò le relazioni di credito commerciale tra ebrei e non ebrei, e al tempo stesso rese meno netta la distinzione tra i due gruppi agli occhi di coloro che, al contrario, desideravano che tale distinzione fosse inequivocabile.
L’assicurazione marittima
L’assicurazione a premio scaturì da precedenti contratti di condivisione del rischio – in particolare il pres...