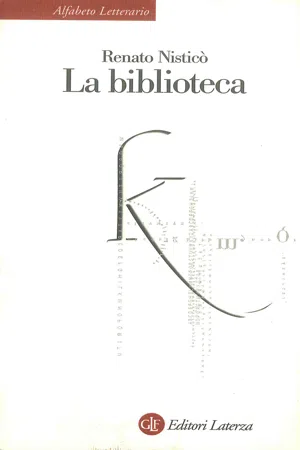
eBook - ePub
La biblioteca
Renato Nisticò
This is a test
- 112 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
La biblioteca
Renato Nisticò
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Dopo aver chiarito il tema dell'indagine in una breve, accessibile premessa di tipo teorico, nella seconda parte si passa ad un'esemplificazione su base storica, con opportune citazioni dalle opere degli autori più significativi, per intendere il rapporto fra la letteratura e il tema del libro e della biblioteca. Si va da Cervantes a Manzoni, da Jarry a Pirandello, da Musil a Borges ad Eco, ed altri. Chiude il volume un'esauriente ma agile bibliografia.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is La biblioteca an online PDF/ePUB?
Yes, you can access La biblioteca by Renato Nisticò in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Letteratura & Critica letteraria. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
LetteraturaSubtopic
Critica letteraria1.
Il tema della biblioteca
in letteratura
Un luogo comune
Ai lettori di opere letterarie capita abbastanza spesso di imbattersi in descrizioni di biblioteche e bibliotecari. Si tratta di un tema ricorrente, improntato il più delle volte anche a triti luoghi comuni; il cui rovesciamento, praticato sempre più spesso ai nostri giorni, al fine di spiazzare l’orizzonte d’attesa dei lettori, non fa che confermarne la secolare validità e, entro certi limiti, la fondatezza. Le biblioteche sono in genere rappresentate come luoghi bui, criptici e labirintici, difficilmente accessibili. Esse conservano quantità immani di libri, per la gran parte antichi e quasi mai consultati, dove si depositano archeologici strati di polvere. Sono invariabilmente frequentate da topi, nella doppia obbligatoria accezione di habitués incalliti e di animali roditori. I bibliotecari sono quasi sempre anziani, spesso deformi, comunque poco attraenti, coltissimi, o, viceversa, assai ignoranti, sadicamente inclini ad imporre assurde discipline regolamentari ai disorientati utenti.
Soprattutto nella produzione letteraria di genere o nella paraletteratura le biblioteche nascondono un accesso privilegiato ai territori inesplorati del mistero, trattengono nelle loro latebre esemplari proibiti su cui è gravata la messa all’indice, suggeriscono un erotismo allucinato e perverso. In letteratura, in particolare ai nostri giorni, si riscontrano anche dei veri e propri rovesciamenti di questi cliché: il grande diventa piccolo, il buio luce, il vecchio giovane, il deforme bellissimo, il disordine ordine, l’irrazionale razionale, e così via. Una cosa è certa: a scrittori e lettori non interessa una biblioteca normale, che funzioni regolarmente per i fini cui è preposta. Per il particolare tipo di oggetti che ospita essa mette in moto meccanismi consci e inconsci di elaborazione fantastica, che sono riconducibili tutti a un unico comun denominatore: la sacertà, o, in subordine, il valore simbolico – dunque non referenziale – del luogo in quanto proiezione del potere fascinatorio degli oggetti che racchiude. Ciò avviene sia perché non v’è luogo comune che non abbia qualche fondamento nella realtà effettuale (le biblioteche sono state e sono, anzitutto, enormi e caotici magazzini del sapere), sia perché, come suggeriscono due bibliotecarie francesi che si sono prese la briga di approntare un repertorio delle opere letterarie e cinematografiche di argomento bibliotecario, ogni autore è stato anzitutto un utente di biblioteca ed ha quindi elaborato particolari sentimenti sul campo, accumulando una svariata messe di osservazioni su quell’ambiente che ha cullato il suo ingresso nel mondo della cultura. Diversi fra loro sono stati anche in prima persona bibliotecari. Faccio i primi nomi che mi vengono in mente: Anatole France (1844-1924), Jorge Luis Borges (1899-1986), Robert Musil (1880-1942), in casa nostra Federico De Roberto (1861-1927), Luciano Bianciardi (1922-1971), e così via. Tutti loro, comunque, conoscono la doppia valenza, di attrazione e di repulsione, di fascino e di frustrazione, esercitati dall’ambiente-biblioteca, da sempre sospeso fra lo status positivo di tempio della conservazione, e quello negativo di cimitero della vita vera, di tutte quelle buone idee che, trasferite sulla carta, vi sono rimaste imbalsamate, lettera morta. Tuttavia, deve esistere una qualche ragione più profonda e significativa di queste, legate alla sfera psicologica e ai vissuti di autori e lettori, se il tema delle biblioteche e dei bibliotecari continua a riscuotere tanto successo nonostante essi siano intesi come depositari del brutto, del desueto, del deforme, e benché evochino, magari, la noia derivante da settennati di studi matti e disperatissimi. Ci riferiamo, ovviamente, al caso del contino Giacomo Leopardi (1798-1837). Si tratta certo di qualcosa che va al di là della mera resistenza del passato, del fascino esercitato da una memoria dovuta alla presenza muta di testimoni assenti, lontani, la maggior parte morti (gli autori dei libri e i personaggi che li abitano).
Libri nei libri: un ‘effetto di reale’
La ragione del successo del tema delle biblioteche, più che in caratteri estrinseci alla letteratura, di tipo psicologico o sociologico, deve essere cercata in ciò che fa di questo tema un argomento squisitamente letterario. Per avere una qualche validità generale essa dovrebbe rispondere al seguente quesito: che ruolo giocano le descrizioni di biblioteche, pubbliche o private, sotto la forma specifica dell’‘elenco di libri’, nell’economia del significato delle opere letterarie? Vorrei infatti prendere congedo dalla rappresentazione della biblioteca come ambiente e sfondo di eventi e personaggi, moltiplicatore delle possibilità combinatorie nella narrativa, se pure è ovvio che questi continuano ad essere aspetti quasi inevitabili della ricerca. Per fare un esempio della differenza ricorriamo al libro di Italo Calvino (1923-1985) Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979). In questo libro, il cui argomento è proprio la lettura e il rapporto che l’uomo intrattiene col mondo dei libri e con la produzione letteraria in questo ultimo scorcio del millennio, sono almeno tre i momenti in cui il lettore trova descritta una biblioteca. Un primo, quando all’inizio del romanzo Calvino racconta l’avventura del personaggio-lettore all’interno di una libreria, e fa un elenco delle varie tipologie di libri che egli si trova di fronte in questo frangente; il secondo, quando descrive la biblioteca domestica di Ludmilla, la lettrice, tentando di ricavarne alcuni tratti della personalità; il terzo, quando il lettore entra in una vera biblioteca a cercare i romanzi la cui lettura gli è stata resa fino a quel momento impossibile. Di queste tre descrizioni della biblioteca quella che cattura maggiormente la mia attenzione è la prima, perché l’elenco di libri che vi si trova dà un buon esempio di ciò che chiamerò biblioteca assente (libri cioè che è impossibile leggere, in quanto non appartenenti al reale patrimonio bibliografico dell’umanità); la seconda è pur sempre interessante perché costituisce un esempio di biblioteca funzionale alla ricostruzione del personaggio; la terza direi che non lo è quasi affatto, perché non fa che confermare, forse pretestuosamente, alcuni luoghi comuni sulle biblioteche, riducendo anzi la biblioteca stessa a luogo comune: prigione o labirinto dell’informazione. La nostra attenzione non deve dunque essere rivolta alla biblioteca come luogo fisico, ma come proiezione ideale di un’idea estetica o di uno spunto filosofico dell’autore.
Per rispondere al quesito che mi sono posto credo che occorra anzitutto valutare i caratteri specifici del tema e dell’oggetto ‘raccolta di libri’ tale che esso appartenga solo e soltanto all’ambito della letteratura. Dico ‘raccolta’, perché con questo termine è possibile sintetizzare due diversi aspetti del nostro oggetto d’indagine: a) la biblioteca come luogo, sia esso fisicamente inteso o sia esso luogo comune di tipo retorico; b) la forma letteraria ‘elenco di libri’. Un carattere sicuramente specifico di queste ‘raccolte’ o meglio: rappresentazioni, descrizioni di raccolte, è relativo a quell’artificio retorico detto della mise en abîme, o messa all’infinito. Questa si ha quando, ad esempio, un racconto di dimensioni più ridotte viene inserito nel contesto della narrazione principale, spesso con la funzione di rispecchiare il rapporto fra scrittore (narratore) e pubblico (ascoltatore): un po’ come quando dentro una grande scatola cinese o una matrioska, ne troviamo una più piccola, e poi ancora una più piccola, e così via. Si hanno esempi di mise en abîme in vaste e complesse architetture del racconto, come nel Decameron di Giovanni Boccaccio (1313-1375), ovvero anche in singoli, brevi racconti come Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). Nel nostro caso, la mise en abîme è data dal fatto che si trova descritto dentro un certo libro un insieme di libri riuniti in un punto: questo punto è il luogo del libro dove li vediamo elencati – il XXVII capitolo dei Promessi sposi (1840) di Alessandro Manzoni (1785-1873), ad esempio – e, insieme, il luogo nel quale si trovano raccolti all’interno della finzione letteraria (in quello stesso capitolo, lo studio di don Ferrante). Si sa che normalmente queste ‘messe all’infinito’ hanno la funzione di moltiplicare il rapporto fra narratore e ascoltatore, intesi come funzioni dell’opera, conferendo maggiore peso anche al rapporto fra autore e destinatario dell’opera. In particolar modo, come è stato detto da un nostro studioso, Cesare Segre (n. 1928), la citazione di un’opera d’invenzione dentro un’altra opera di invenzione, che è l’argomento del quale ci stiamo occupando, determina un effetto di realtà. Nel momento in cui un libro è descritto come appartenente a un mondo reale con caratteri di verisimiglianza e si trova al centro di abitudini e interessi di un certo ambiente umano, anche il libro che il lettore ha davanti, e il suo autore, sono ‘reali’ e sono degni dell’interesse e dell’attenzione di altri esseri umani. Una prima risposta alla nostra domanda potrebbe, dunque, essere la seguente: tramite gli elenchi di raccolte di libri, l’autore vuole conferire una consistenza reale prima di tutto al libro che egli ha scritto, quindi a se stesso come autore. Conferire realtà al testo sortisce l’effetto secondario, ma non meno importante, di esaltare la funzione e la dignità del lettore. Esibendo questa risorsa l’autore rassicura il lettore che quello che sta facendo – leggere un libro – è un atto reale, moralmente giustificato, e socialmente plausibile. Si comprenderà meglio quanto abbiamo detto se svolgiamo un elementare esercizio di logica simmetrica. In base a questa logica, che è quella che presiede più di ogni altra alla finzione letteraria, se la parte (in questo caso, il libro) conterrà il tutto (la raccolta di libri), allora il tutto, la biblioteca, conterrà il libro, questo libro, dell’ipotetico autore di cui stiamo trattando. Ogni autore, ogni poeta, ogni scrittore tende a far parte della biblioteca, di quella porzione limitata, cioè, dell’universo dei libri, che individui o collettività hanno eletto per una conservazione e un accrescimento del sapere; di ‘un certo’ sapere che risponde anzitutto all’esigenza di definire, in quanto tale, una identità culturale. Le biblioteche letterarie corrisponderanno allora a un insieme di oggetti, i libri, investiti di un particolare valore nel campo della comunicazione simbolica e della ritualità culturale. Ognuna di esse esprime una tendenziosità etico-culturale, sostenuta da un certo ordine estetico-filosofico.
Biblioteca Universale e biblioteca parziale
Luciano Canfora (n. 1942) ha scritto che «ci sono romanzi nella cui vicenda la biblioteca è un luogo determinante». C’è tuttavia biblioteca e biblioteca; e vedremo in che senso. Una raccolta di libri conservati in un luogo secondo un certo ordine costituisce, appunto, una biblioteca anche per la biblioteconomia, la disciplina cioè che si occupa della teoria e dell’organizzazione delle raccolte librarie. Questo è un primo, più generale significato del termine. Nel corso del tempo, esso ha assunto anche un altro significato: quello di elenco ragionato di libri. E ciò avvenne agli albori dell’epoca moderna (sec. XVII), soprattutto a partire dalla diffusione dell’opera del patriarca costantinopolitano Fozio (primo quarto del IX secolo d.C.-892 ca.), il quale redasse un Myrobiblion, titolo reso nella tradizione volgare, a partire dalle traduzioni secentesche, con il termine Bibliotheca; che raccoglieva i sommari (oggi si direbbe, forse, le ‘recensioni’) di quasi trecento libri. Essa era destinata al fratello Tarasio, che, non avendo potuto leggere direttamente quelle opere, bramava averne una pur sommaria informazione: la conoscenza di quei libri era ritenuta necessaria a un uomo della sua condizione. La biblioteca di Fozio inaugura la tradizione del libro-di-libri o libro-biblioteca, e sposta dunque l’accezione del termine da un luogo fisico a un luogo solo simbolico – anche se ristretto nello spazio concreto del libro. Tuttavia l’opera di Fozio non è, o non è soltanto, un puro inventario, un elenco di titoli (in questo caso ci troveremmo di fronte a un catalogo); ma è una vera e propria biblioteca, in quanto quel catalogo, cioè quell’elenco di libri di cui è pure costituito, è reso significativo nella sua unità da una ragione di ordine culturale, da alcuni determinati valori.
Come una biblioteca, per essere tale, presuppone un ordine, un principio di ordinamento e uno strumento fondato su basi logiche e spaziali per reperire i libri (quelli che nel linguaggio della biblioteconomia, sono l’ordinamento – in ispecie la classificazione –, e la collocazione dei libri sugli scaffali), ciò che fa della descrizione di un insieme di libri una biblioteca letteraria, è quella particolare forma estetica che rispecchia un principio culturale, metafisico o pragmatico, di ordinamento. Le biblioteche non esistono in letteratura come oggetti inerti; nel momento in cui un libro viene identificato e nominato e posto in rapporto con altri, assume un valore simbolico preciso: espone un’idea del mondo, suggerisce un modo di vivere. Rispetto alla biblioteca che descrive, perciò, l’autore potrà esprimere (semplifico) della simpatia – e allora egli tenderà a farne parte, anche in maniera del tutto esplicita, mettendo in quella biblioteca qualcuno dei suoi libri, come fa Alfred Jarry (1873-1907) nelle Gesta ed opinioni del dottor Faustroll, patafisico (Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, 1898) –; o della antipatia, o comunque una distanza, un non ...
Table of contents
Citation styles for La biblioteca
APA 6 Citation
Nisticò, R. (2015). La biblioteca ([edition unavailable]). Editori Laterza. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3459828/la-biblioteca-pdf (Original work published 2015)
Chicago Citation
Nisticò, Renato. (2015) 2015. La Biblioteca. [Edition unavailable]. Editori Laterza. https://www.perlego.com/book/3459828/la-biblioteca-pdf.
Harvard Citation
Nisticò, R. (2015) La biblioteca. [edition unavailable]. Editori Laterza. Available at: https://www.perlego.com/book/3459828/la-biblioteca-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Nisticò, Renato. La Biblioteca. [edition unavailable]. Editori Laterza, 2015. Web. 15 Oct. 2022.