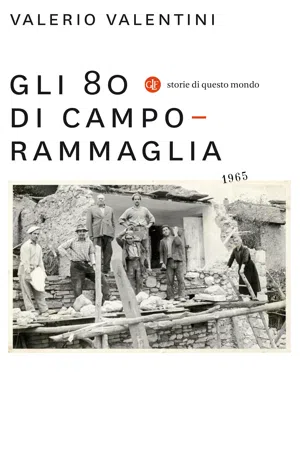Intermezzo
Arrivo con colpevole ritardo ad una precisazione che – solo ora me ne rendo conto – assai prima avrei dovuto fare. Ma un po’ l’ansia di evitare troppi incisi, troppe divagazioni (lo so, lo so che in verità di scantonamenti ce ne sono stati già parecchi: e altri ne seguiranno), un po’ il fatto che ciò che a molti sarà subito saltato agli occhi come una stranezza a me bizzarro si è rivelato solo dopo una prima revisione, quando ho provato a riconsiderare il tutto con l’occhio ignaro del lettore.
Ebbene, sì: Marinelli, De Marco e Michelini sono effettivamente gli unici tre cognomi presenti a Camporammaglia. Le eccezioni, di cui a breve dirò, si contano sulle dita di una mano sola. E anzi: a voler essere rigorosi, già i De Marco sono un’intromissione piuttosto recente, di quando – una trentina d’anni fa, grosso modo – un paio di piacenti figliole di Camporammaglia si andarono a far scegliere, una appresso all’altra, da due ragazzotti, tra loro cugini, di Foce di Sassa. Dove appunto i De Marco, insieme ai Vincenzi, sono stati a loro volta le due genie a lungo prevalenti, altrettanto refrattarie a qualsiasi intromissione.
Liquidati dunque i nuovi arrivati – incistatisi in un contesto di relazioni e intrecci geneticamente pericolosi che s’aggrovigliano da circa quattro secoli (così, almeno, dicono quelli che vantano come letture serali censimenti e registri parrocchiali antichissimi, rinvenuti chissà come in qualche archivio) –, liquidati i De Marco, non restano che Michelini e Marinelli. Che tra loro da sempre si parlano, si sopportano, si sposano, ma che pure restano divisi da un indefinibile sospetto reciproco, un sentimento animalesco che ciascun camporammagliese inconsciamente metabolizza negli anni dell’infanzia: una pretesa di superiorità dell’una sull’altra stirpe. Dinamica simile, magari, a quelle che altrove generano faide e regolamenti di conti, guerre che si protraggono per decenni con più o meno clamore: ma qui, a Camporammaglia e dintorni, le divisioni sono soprattutto questione di goliardia e di folclore, una diffidenza più ostentata che sentita e che – salvo alcuni, mai del tutto chiariti incidenti – erompe principalmente il giorno delle feste patronali, quando capita che, durante i giochi in piazza, nel momento dell’organizzazione del tiro alla fune o della corsa coi sacchi, il diverso cognome agisca come richiamo per compattare le due opposte fazioni, o quantomeno come facile discrimine con cui sbrigare la rogna di dover fare le squadre. A San Luca, se ci si fida dell’aneddotica sulla ’ndrangheta rintracciabile in internet, si è cominciato con un lancio inopportuno di uova marce durante una festa di carnevale: e si è finito, sedici anni dopo (sedici anni di agguati ed esecuzioni), con sei morti ammazzati a duemila e rotti chilometri di distanza. Qui invece tutto resta sotto il livello di guardia, e al limite le divisioni, laddove s’esasperano, assumono connotati grotteschi più che feroci (a Civitatomassa, per dire, le famiglie dei Santarelli e quelle degli Zuccarella hanno da sempre abitato, a seconda del loro cognome, sull’una o sull’altra delle due vie lungo le quali si sviluppa il paese, e che s’incrociano solo all’altezza della piazza centrale: e il vicolo dei Santarelli era lastricato di selci rigorosamente bianchi, quello degli Zuccarella di pietre nere, finché non è arrivato il bitume ad appianare strade e dissidi).
A Camporammaglia, comunque, la rivalità da qualche anno a questa parte è soprattutto legata alla disputa su quale tra le due famiglie sia stata la prima ad abitare il paese. I Marinelli rivendicano l’iscrizione in cima all’arco d’ingresso del palazzone che stava, prima che il terremoto lo buttasse giù, di fronte alla casa di Gioacchino: sulla targa – risalente, sembra, al diciassettesimo secolo – ci sarebbe stato riportato il solo cognome «Marianellis», all’interno di una frase, perlopiù illeggibile, il cui significato non è mai stato dato sapere. I Michelini, dal canto loro, s’aggrappano invece ad una prova più banale, e da quella evidenza empirica arditamente muovono alla conclusione che volge a loro favore la contesa. Ripetono, i Michelini, che mentre di Marinelli se ne trovano, senza neppure gran fatica, in molti paesi vicini e persino nel centro dell’Aquila (dove peraltro vantano anche l’intestazione di un palazzo nobiliare lungo il Vicolaccio), di Michelini non se ne ha traccia se non a Camporammaglia – a parte qualche raro caso a Poggio Santa Maria, che comunque può essere agevolmente ricondotto a traslochi o matrimoni avvenuti negli ultimi lustri. E se questo è vero, come in effetti pare, allora – ecco la tesi – è evidente che solo a Camporammaglia i Michelini risiedono perché proprio loro di quel paese sono stati i primi colonizzatori. Difficile, ahimè, sperare che la questione venga risolta, a meno che non si voglia dar fiducia, come al solito, a Gioacchino: il quale da un paio d’anni passa buona parte dei suoi fine settimana su myheritage.it, nel tentativo di ricostruire gli alberi genealogici delle varie famiglie e risalire, una volta per tutte, alla verità.
Per quel che mi riguarda, anche questa dei due cognomi dominanti, come tante altre stranezze del vivere a Camporammaglia, a me si è fatta chiara nel momento – un momento in verità assai dilatato e difficilmente collocabile – in cui i confini del mio paese hanno smesso di coincidere con quelli del mio mondo di riferimento. Vado a memoria, rinunciando a stabilire una esatta gerarchia temporale tra i vari episodi.
Primo: sto camminando lungo la Provinciale con mia nonna e un’auto rallentando ci affianca, dal finestrino sul lato del passeggero s’affaccia un viso sconosciuto di donna che, con molto garbo, ci chiede se sappiamo indicargli «casa Marinelli», e mia nonna aggrottando la fronte risponde: «Eh, signò: va’ a cercà Maria pe’ Roma».
Secondo: la maestra di matematica valuta a lungo, con aria assorta, se accettare o meno la giustificazione che le presento, poche righe su una pagina del mio diario, per non aver fatto i compiti a casa, e alla fine mi invita a segnalare a mia madre il motivo della sua perplessità: io non capisco, ma comunque riporto il messaggio («Mamma, dice la maestra Rosetta che non devi firmare le giustificazioni col cognome da signora, ma con quello da signorina»), e mia madre sorride un po’ stizzita, e subito mi richiede il diario per precisare «alla gentile docente» che lei Marinelli fa di cognome, come suo marito: Marinelli tanto da signorina quanto da signora.
Terzo: mio cugino Domenico, sei anni più grande di me, cresciuto all’Aquila e avendo sempre in odio la rozzezza del paese da cui mia zia era voluta scappare subito dopo il matrimonio, durante una partita a dama mi spiega, con assoluta serenità, che lui non intende affatto offendermi quando mi definisce «mongospastico», che io «letteralmente» sono handicappato, perché pronipote di due scellerati che si sono sposati nonostante un legame di parentela diretto: io scoppio in lacrime e chiedo a papà se davvero i miei bisnonni fossero cugini di primo grado, e al suo cenno di conferma domando ancora se ciò mi renda per forza un bambino mentalmente menomato.
In ogni caso – e date simili premesse verrebbe da dire: finalmente – da qualche tempo questa monotonia genetica si è venuta attenuando. Merito di chi a Camporammaglia è nato intorno alla metà dei Settanta e la moglie se l’è trovata – il discorso vale anche per le donne, ma in questo caso bisogna posticipare tutto di una decina d’anni – nelle aule dell’università, durante le vacanze estive o il sabato sera in qualche locale: tutte circostanze che, è evidente, riducono di molto la possibilità di restare all’interno di quell’intrico di legami che fino all’altro ieri ha stretto tra loro, in un modo o nell’altro, tutte le famiglie dei camporammagliesi. Se poi si sia trattato di una ribellione consapevole nei confronti di questa atavica forma di endogamia paesana, o non piuttosto di un naturale accadere delle cose, sarebbe difficile stabilirlo.
Certo è che, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, queste irruzioni di forestieri non sono state viste con eccessivo malcontento. Ovvio: soprattutto all’inizio, certe stravaganze dei nuovi arrivati fecero storcere qualche naso – tipo, che so?, uomini che non pagavano la quota d’iscrizione al Circolo («Ma come? E che cazzo fai tutti i pomeriggi?»), o donne che confessavano, senza apparentemente percepire la gravità di simili affermazioni, che loro sì, andavano in palestra con le amiche tutti i giovedì, lasciando persino, in quei casi, l’incombenza di fare la spesa ai loro mariti. E però, se è vero che nella quotidianità le giovani coppie meticce si distaccavano assai dalle usanze locali («Ma mo’ che me rappresenta ’ssa moda de ji’ a pijà le pizze e magnassele a casa? Ma a ’ssu punto cucina tu, no?»), va però considerato come, negli eventi particolari, nelle ricorrenze di cui l’intero paese è testimone e che pertanto molto più contano rispetto alle abitudini private di tutti i giorni, gli stranieri mostrassero una partecipazione talvolta sorprendente. E vuoi per uno zelo figlio del desiderio di sentirsi accettati fino in fondo, vuoi per quella posticcia adesione ai riti contadini che certi insegnanti, certi medici, avvertono come un dovere per ribadire il loro spregio verso lo squallore di questo presente metropolitano così meschino, accadeva spesso che fossero proprio le nuove mogli ad appendere al collo della Madonna in processione – tradizione caduta in disuso da qualche decennio – la collana più costosa ricevuta il giorno del matrimonio, oppure che i giovani padri dell’Aquila trapiantati in paese si dicessero orgogliosi di far crescere i propri figli al fianco dei nonni semianalfabeti, così che apprendessero i rudimenti dell’agricoltura e le dure leggi del sacrificio e del rigore (oltreché, in molti casi, la necessità della bestemmia all’interno di una frase che ambisse ad avere efficacia, e non solo banale senso compiuto).
E al contempo, per una sorta di bizzarra compensazione, i comportamenti dei camporammagliesi si sono sempre più avvicinati a quelli dei forestieri, da questi assorbendo i gusti, le ansie, le smanie. E ciò che un tempo era stato visto come una pericolosa corruzione dei costumi, un inaccettabile svilimento di certi valori secolari, si è rapidamente fatto motivo di vanto.
È stato così che le anziane camporammagliesi hanno cominciato a sfoggiare un volto fiero nel tornarsene a casa con in mano le camicie dei loro figli da stirare («Eh, che vuoi?, mia nuora lavora tutto il giorno, esce la mattina e torna la sera, pòra cristiana»). È stato così che tutto un patrimonio di sentenze, di sacramenti, lo si è liquidato con assurda leggerezza; ed echi lontani di strani miti si sono fatti chiacchiera ricorrente, argomento da caffè. E insomma meglio smantellarla, la vigna, e insomma meglio smetterla con questa fissa del maiale allevato in casa: non tanto per risparmiare a se stessi la fatica, ma perché non sembrasse naturale ai propri figli dover restare avvinti a quella catena disperante. Il feticcio del bel voto sul libretto sostituitosi a quello dei calli sulle mani, dell’orto tenuto in ordine perfetto. L’università, questo miraggio finalmente accessibile, elevata a santuario: indipendentemente dagli esami superati, indipendentemente dai sacrifici per pagare la retta, indipendentemente da tutto («Sì, è la terza facoltà che cambia: ma comunque studia»; «Sì, sta un po’ ritardo, due o tre anni fuori corso, ma che gli fa?»). Da sempre vista come un orpello tutto sommato rinunciabile, da accantonare senza dubbio di fronte all’urgenza di trovare il lavoro, di metter su famiglia e fare prole, ora la laurea diventava l’imperativo assoluto: non solo passaggio necessario verso una sistemazione migliore, uno stipendio più alto, ma lavacro di redenzione di un passato fatto di miserie e iatture.
Frantumatasi la cappa, tutto poi filtra: e alla scoperta di ciò che si è ripudiato senza mai vedere, capita che ogni cosa si capovolga. Persino i vezzi un tempo additati al pubblico ludibrio – persino le statue della Madonna fatte arrivare da Medjugorje e installate in finte nicchie di pietra illuminate da lucette colorate, persino quelle pacchiane targhe in marmo con le iniziali dei vari componenti della famiglia fissate alla colonna del cancello – rapidamente si sono diffusi e si sono sedimentati.
Tutto successo in maniera assai repentina: a partire, credo, dalla metà dei Novanta. In notevole ritardo rispetto al resto d’Italia, certo: ma come in fondo era normale che fosse. Dei cambiamenti che silenziosamente scuotevano il Paese ai tempi di Canzonissima, delle utilitarie prese a cambiali e del primo insignorirsi dei mezzadri, a Camporammaglia poco o nulla è arrivato: giusto i flebili riverberi di un’onda d’urto generatasi chissà dove, ma ormai senza alcuna forza residua se non quella in grado di produrre appena un’oscillazione, di dar prova che forse era proprio vero che da qualche parte neanche troppo lontana, qualcosa di grosso stava accadendo.
Per almeno dieci anni dalla sua prima affermazione come bene di massa, a Camporammaglia la televisione – ma si tratta solo di un esempio tra i tanti possibili, e forse del meno originale di tutti – è rimasta un prodigio spaventoso, avvicinabile solo per il tramite di Francuccio: il quale un giorno imprecisato dell’autunno del ’67 posizionò quello scatolone grigio di cui tanto a lungo si era favoleggiato sul tavolo centrale della sua cantina, in modo che anche dalla strada fosse possibile vedere, o quantomeno intravedere tra il garbuglio delle teste curiose, o anche solo ascoltare: insomma partecipare tutti i giovedì a quell’evento meraviglioso che erano le puntate di Rischiatutto, quando ogni camporammagliese, finita la cena, prendeva la sua sedia e cercava un posto tra le prime file davanti al portone d’ingresso di quella sottospecie d’osteria che stava proprio al centro del paese vecchio. Perché il televisore cominciasse a comparire nelle cucine della case private – all’inizio grazie soprattutto ad acquisti fatti in società tra fratelli e cugini, che per la prima volta da quando erano ragazzini si ritrovavano ora a mangiare tutti insieme per poter guardare le tribune elettorali o gli incontri di boxe di Arcari e Traversaro – ci volle almeno la metà degli anni Settanta. Qualcuno, addirittura, ricorda di essersi deciso al grande passo giusto in tempo per seguire l’epopea spagnola della nazionale di Bearzot.
Ma insomma tutto ciò che, specialmente attraverso la mediazione del tubo catodico, ha reso milioni di italiani insoddisfatti delle loro vite, a Camporammaglia è arrivato almeno un paio di decenni dopo, presentandosi già nella sua versione alterata, commercialmente più raffinata e più cafona. Non il sorriso paziente del maestro Manzi, quella sua rassicurante robustezza, ma l’ineffabile decoro di Enrica Bonaccorti; la composta spavalderia di Corrado, sì, ma accanto l’inappuntabilmente spregiudicato candore di Ambra. E siccome per metabolizzare non c’era più tempo, a Camporammaglia ci si è affrettati a proiettare sulle proprie figure, sui propri atteggiamenti quotidiani, affanni e compulsioni solo confusamente – se pure – vissuti nel profondo. Malesseri esibiti per senso del dovere, imparati a memoria come i testi delle prime canzoni inglesi ascoltate dalle cuffie dei walkman.
È stato in quel giro d’anni, insomma, che l’avere un figlio che presentasse al paese una fidanzata di Avezzano o di Rieti, ma pure di Cansatessa o di Aragno, è diventato una fortuna da ostentare: ché quasi sempre le madri dei giovani camporammagliesi lodavano come somme virtù tutte le abitudini della famiglia della promessa sposa che ne attestassero l’alterità dalle logiche della vita rurale. E allora ecco le prime gare a chi faceva il ricevimento di matrimonio più sfarzoso, le bomboniere più ricercate, la crociera più lunga per la luna di miele, col solo obiettivo di testimoniare l’affrancamento dei figli dai retaggi della miseria sopportata dai padri, di quando dopo il bacio davanti all’altare ci si riuniva in casa coi soli parenti stretti dello sposo e i testimoni e si ammazzava il pollo migliore, o di quando – ma qui già arriviamo ai tempi del primo scialo – si partiva per viaggi di nozze di una settimana, in macchina o in treno verso Venezia o Firenze, col quadernetto in tasca dove annotare le spese della vacanza per poi giustificarle ai genitori al ritorno.
È qui che s’è rotto il rapporto tra essenziale e capriccio. Da sempre, a Camporammaglia come altrove, l’analisi dell’apparenza più immediata di una persona è stata un indice affidabile del suo grado di ricchezza. Prima che fossero le etichette in bella mostra a fornire indizi sin troppo scontati, si indovinava a prima vista – l’occhio allenato più dalla privazione e dal desiderio che dalla consuetudine – il pregio della tessitura della giacca, la morbidezza del cuoio delle scarpe: e a quel punto ti bastava estendere quel livello di benessere a tutti gli ambiti della vita di quella persona. Un’equazione a suo modo banale, per misurare la distanza tra te e chi ti stava di fronte. È stato grosso modo così dappertutto, e dappertutto questo sistema di misurazione a un certo punto si è rivelato fallace, perché il definitivo trionfo dell’apparenza ha di colpo falsato il rapporto che esisteva tra le variabili.
Ecco, a Camporammaglia questo cortocircuito deve essere avvenuto proprio negli anni di cui vi parlo, appena prima del mio approdo alla fase della ragione: altrimenti non si spiegherebbe il ricordo, così vivido in me e nei miei coetanei, di quel biasimo tanto rancoroso col quale i nostri nonni inveivano contro lo sfoggio di automobili e vestiti, contro la scellerata, narcisistica malaccortezza di chi al Circolo passava in rassegna tutti i ristoranti più raffinati della costa adriatica, trovandoli tutti manchevoli di quel non so che, e poi però abbassava la testa per non farsi riconoscere quando lo si incontrava con le buste piene all’uscita del Lidl a Quaianni.
L’orgoglio montanaro della rinuncia – quella rudezza, quell’austerità tanto a lungo rivendicate dalla gente di questi paesini come un proprio nobile modo di stare al mondo – al momento della prova del confronto ravvicinato col dolce superfluo della modernità, semplicemente non ha retto. Quegli agi così vituperati, divenuti appena meno irraggiungibili, appena più alla portata delle tasche dei camporammagliesi e dei loro simili, si sono rivelati delle tentazioni irresistibili. E siccome troppo a lungo era durata l’astinenza, l’illusione dell’idillio protratta oltre ogni ragionevole limite, la rottura era inevitabile che fosse, come in effetti è stata, fragorosa. L’insensatezza di certe privazioni, la falsità della retorica che le...