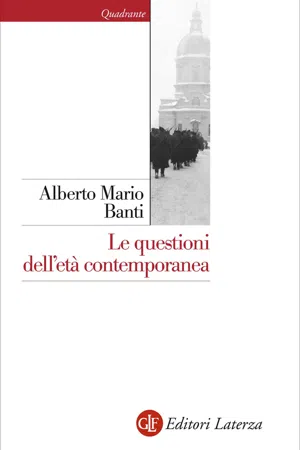
eBook - ePub
Le questioni dell'età contemporanea
Alberto Mario Banti
This is a test
Share book
- 366 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Le questioni dell'età contemporanea
Alberto Mario Banti
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
La Rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, le nazioni e i nazionalismi, il Risorgimento, lo studio storico delle classi sociali, la Grande Guerra, la rivoluzione bolscevica e l'Unione Sovietica, il fascismo, la seconda guerra mondiale, il totalitarismo, fino alla storia delle donne e alla globalizzazione. Sono quindici gli itinerari che Alberto Mario Banti ha selezionato per introdurci alla storia contemporanea, guidati con mani sicure dagli autori e dalle opere che ne hanno proposto le interpretazioni più significative.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Le questioni dell'età contemporanea an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Le questioni dell'età contemporanea by Alberto Mario Banti in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Storia & Storia del XXI secolo. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
StoriaSubtopic
Storia del XXI secolo1. La Rivoluzione francese
1. Dalla «Rivoluzione borghese» alla «Rivoluzione del popolo» (Thierry, Guizot, Thiers, Mignet, Michelet)
L’Ottocento francese ha inventato il lavoro storiografico moderno. Ha inventato l’immersione negli archivi, dove si va a studiare le fonti e i documenti originali. Ma ha inventato anche la storiografia ideologica, quella che ha un messaggio politico più o meno esplicito, un’interpretazione generale da spendere subito nel dibattito pubblico che circonda l’autore.
Se questa è la tonalità dominante del lavoro storico nella Francia di primo Ottocento, essa connota con grande evidenza anche le opere dedicate alla Rivoluzione francese. Se si tralasciano le opere scritte immediatamente a ridosso degli eventi rivoluzionari da persone che vi avevano direttamente preso parte, i primi lavori veramente importanti si incontrano solo a partire dagli anni Venti dell’Ottocento. Gli autori sono un gruppo di intellettuali e politici francesi, spesso in contatto fra loro e in generale di vario orientamento liberale, che guardano alla Rivoluzione con simpatia, come a un momento che – a loro modo di vedere – ha segnato una svolta profonda nella storia della Francia e di tutta l’Europa.
Di questo gruppo, sono Augustin Thierry e François Guizot i primi a proporre un quadro generale, ambiziosissimo, che considera la Rivoluzione come il culmine di un processo storico di lunghissima durata, che trae origine addirittura dall’epoca delle invasioni barbariche. Influenzati dal romanziere scozzese Walter Scott, vedono un parallelismo stretto tra ciò che era accaduto in Inghilterra e Francia non solo nello svolgimento delle rispettive rivoluzioni ma anche nelle loro cause più lontane: le rivoluzioni inglesi del XVII secolo per loro sono la definitiva ribellione degli eredi degli Anglosassoni, oppressi dai nobili discendenti degli invasori normanni che nel 1066 li avevano sconfitti nella battaglia di Hastings; analogamente, ritengono che la Rivoluzione francese sia l’esito di un contrasto tra «razze» che ha avuto origine in epoca medievale, e che ha contrapposto per secoli gli eredi delle popolazioni gallo-romane – diventati in epoca moderna i membri del Terzo stato – ai discendenti degli invasori franchi – divenuti col tempo i membri della nobiltà francese. Un contrasto originario di gruppi etnicamente distinti si trasforma così – nella loro ricostruzione – in un conflitto tra due gruppi socialmente distinti. L’importanza epocale della Rivoluzione sta nell’aver posto fine all’oppressione secolare cui la nobiltà di lontana origine franca aveva sottoposto il Terzo stato di remota origine gallo-romana.
Lo schema è evidentemente semplice e affascinante; le grandi risorse di erudizione di cui Thierry e Guizot sicuramente dispongono permettono loro di renderlo plausibile; ma soprattutto, essi propongono una esplicita lettura della Rivoluzione come lotta tra gruppi sociali o, come si comincia a dire all’epoca, di «classi sociali».
Lo schema viene ripreso e meglio contestualizzato dalle prime opere storiche di rilievo interamente dedicate alla Rivoluzione, come la Storia della Rivoluzione francese, di Adolphe Thiers, pubblicata a partire dal 1823, o la Storia della Rivoluzione francese pubblicata nel 1824 da François Mignet. Nell’ancien régime – sostengono questi autori – la contrapposizione sociale fondamentale era quella che opponeva nobili e Terzo stato, «il cui potere, ricchezza, stabilità e intelligenza crescevano giorno dopo giorno» (Mignet). È proprio quel contrasto sociale che porta alla Rivoluzione, il cui frutto più maturo è la Costituzione del 1791, che istituisce una monarchia costituzionale. Thiers e Mignet la considerano come l’espressione più avanzata di un Terzo stato (che essi identificano con la «borghesia»), trasformatosi ormai in consapevole classe dirigente del paese. Sfortunatamente, però, la borghesia si è trovata schiacciata nella morsa costituita da un lato dal re e dai controrivoluzionari, e dall’altro dalle moltitudini popolari; dovendo scegliere, e volendo mantenere le acquisizioni rivoluzionarie, la borghesia – secondo Thiers e Mignet – ha dovuto giocoforza appoggiarsi sulla folla, alla quale ha chiesto di offrire le proprie braccia per difendere la Rivoluzione, minacciata dalle armate delle potenze straniere. Ma non si fa niente per niente: e la folla, a sua volta, ha chiesto che il contributo di braccia e di vite fosse compensato con una sua diretta partecipazione al potere; così essa ha spinto verso un’ulteriore Rivoluzione, quella dominata dai giacobini e da Robespierre, più pericolosamente radicale di quella compiuta dalla classe media moderata.
Nonostante l’accelerazione drammatica del 1793-1794 la Rivoluzione resta, per questi storici, una felice rottura attraverso la quale si è imposta una nuova classe dirigente, la borghesia. Ma può questa classe sociale conservare da sola le conquiste rivoluzionarie?
Gli intellettuali liberali – tra cui Thierry, Guizot, Thiers e Mignet – sono convinti di sì. Ma altri intellettuali, di sentimenti democratici, danno una risposta diversa a questo interrogativo e con essa offrono un’altra lettura della vicenda rivoluzionaria. Tra le numerose opere che possono essere ricondotte a quest’ambito una ha particolare rilievo: la Storia della Rivoluzione francese (1847-1853) di Jules Michelet.
La partecipazione delle classi popolari all’azione politica, che gli storici liberali degli anni Venti considerano una sorta di terribile necessità, è invece ciò che per Michelet costituisce la vera, appassionata forza propulsiva della Rivoluzione. Anche più che nelle opere degli storici liberali, nella ricostruzione di Michelet il rigore analitico si perde a favore di una rievocazione emotivamente partecipe. Il quadro è segnato da un semplice scontro di forze sociali: da un lato il Terzo stato coadiuvato dal «popolo», un soggetto che Michelet non definisce mai in modo preciso, ma a cui attribuisce una generosa e sincera sete di giustizia; dall’altro la corte, la nobiltà, la Chiesa, corrotte e pronte a vendersi ai nemici della nazione.
Chiaro che un simile trattamento della Rivoluzione, tutto costruito intorno a contrasti netti di luci e di ombre, ha un valore storiografico piuttosto modesto; serve però a spostare l’attenzione analitica e l’accento etico-politico su un altro soggetto collettivo: attraverso Michelet la Rivoluzione non è più solo un affare della borghesia e non ha come suo compimento la costruzione di una moderata monarchia costituzionale (com’era per Thierry, Guizot, Thiers e Mignet); ma diventa invece una sorta di grandioso e doloroso laboratorio di democrazia, premessa per la costruzione di una società patriottica e democratica, nella quale le classi attive (la borghesia e il popolo) potranno trovare solidi motivi di unità.
2. «L’Antico regime e la Rivoluzione» (Tocqueville)
Tutta questa produzione storiografica mostra piuttosto chiaramente la sua scoperta tendenziosità politica quando si trova posta di fronte alla più serena e raffinata ricostruzione storica che abbia visto la luce nel XIX secolo: L’Antico regime e la Rivoluzione, un libro pubblicato nel giugno del 1856 da Alexis de Tocqueville, un intellettuale di nobili origini. Si tratta di un lavoro che non ha la consueta struttura cronachistica; non narra in dettaglio gli avvenimenti, ma osserva le strutture istituzionali, sociali e culturali; si basa inoltre su un esame ampio e diretto dei documenti e delle fonti d’archivio: tutte caratteristiche che danno all’opera un taglio, per l’epoca, decisamente inconsueto.
La tesi fondamentale del libro di Tocqueville è che, nonostante ogni apparenza in contrario, molte sono le linee di continuità che riconducono la Francia post-rivoluzionaria alle forme istituzionali dell’ancien régime. Il processo di accentramento, la costruzione di apparati amministrativi e giudiziari dipendenti dal potere centrale, l’omogeneità normativa e amministrativa, che sono dei tratti essenziali della società francese emersa dalla tempesta rivoluzionaria, potevano già essere agevolmente rintracciati nelle strutture amministrative della monarchia di ancien régime.
Ma se è così, che cosa spiega l’esplosione rivoluzionaria? E in che cosa consiste l’effetto della Rivoluzione?
Una risposta alla prima domanda va cercata nelle specifiche modalità che hanno connotato il processo di formazione della moderna monarchia assolutista. Questa è una dinamica che – sul lungo periodo – ha portato a un ridimensionamento molto netto dei poteri giurisdizionali dei nobili titolari di signorie feudali: alla vigilia della Rivoluzione i nobili feudatari francesi non hanno più poteri politici o amministrativi e hanno scarsi poteri giudiziari; gli uni e gli altri sono stati da tempo trasferiti a magistrati o amministratori nominati dal sovrano, dagli intendenti o dalle assemblee locali:
Nel diciottesimo secolo dirigevano tutti gli affari della parrocchia un certo numero di funzionari che non erano più gli agenti del feudo e non erano più scelti dal feudatario; gli uni venivano nominati dall’intendente della provincia; gli altri erano eletti dai contadini stessi. Toccava a queste autorità ripartire le imposte, restaurare le chiese, costruire le scuole, radunare e presiedere l’assemblea della parrocchia. Vegliavano sui beni comunali, ne regolavano l’uso, e intentavano e sostenevano i processi in nome della comunità. Non soltanto il feudatario non dirigeva più l’amministrazione di questi piccoli interessi, ma non la sorvegliava. Tutti i funzionari della parrocchia erano sotto il governo, o sotto il controllo del potere centrale [...]. Inoltre, non si vede quasi più il feudatario agire come rappresentante del re nella parrocchia, come intermediario fra lui e gli abitanti. Egli non è più incaricato di applicarvi le leggi generali dello Stato, di raccogliervi le milizie, di imporre le tasse, di rendere noti gli ordini del principe, di distribuire i suoi soccorsi: tutti doveri e diritti che spettano ad altri. Il feudatario è ormai solo un abitante che alcune immunità e alcuni privilegi separano ed isolano da tutti gli altri; la sua condizione è diversa, ma non il suo potere. Il feudatario non è che il primo abitante, hanno cura di specificare gli intendenti nelle lettere ai loro sottodelegati.
Ma se i feudatari, in quanto tali, non hanno più poteri politici o amministrativi, ne hanno invece ancora parecchi di tipo economico: i censi, i diritti e i dazi sono ancora numerosissimi; e proprio qui sta una profonda contraddizione sociale: le comunità contadine pagano ai signori dei contributi originariamente pensati come compensi per dei servizi (l’amministrazione locale, la pubblica sicurezza, la giustizia) che ormai i signori non offrono più; e tale discrasia è vissuta come una profonda ingiustizia, che è proprio ciò che può spiegare la furia antifeudale della Rivoluzione manifestatasi sin dalle prime settimane dell’estate del 1789.
Inoltre, contraddizione non meno grave, il processo di accentramento assolutista non ha cancellato le esenzioni fiscali riconosciute ai nobili e anzi, nel corso dell’edificazione di una struttura amministrativa moderna, sono stati creati ulteriori gruppi privilegiati, per esempio attraverso la costituzione della noblesse de robe (la nobiltà di toga), composta da borghesi che hanno comprato cariche amministrative ereditarie. Tutta la serie di barriere, distinzioni sociali e privilegi, che caratterizza la Francia del XVIII secolo, inasprisce i rapporti tra i gruppi sociali privilegiati e quelli esclusi dall’area del privilegio, mentre la mancanza di libertà politica li ha disabituati alla mediazione, al compromesso, alla pacifica discussione.
Ciò fa sì che, quando la crisi della monarchia francese si apre, la direzione del processo politico venga presa – direttamente o indirettamente – dagli unici individui che non hanno smesso di riflettere sulle questioni politiche, ovvero i «filosofi»; e ciò spiega il carattere astratto delle misure e delle discussioni nell’Assemblea nazionale e poi nella legislativa e, ancor più, nella Convenzione; e ne spiega anche la radicalizzazione progressiva. Tuttavia Tocqueville legge questo scivolamento verso la radicalizzazione alla luce di un’altra considerazione, che mostra molto chiaramente la sua concezione elitaria dell’agire politico:
Il contrasto fra la benignità delle teorie e la violenza degli atti, che è stato uno dei caratteri più strani della Rivoluzione francese, non sorprenderà nessuno se si osserva che questa Rivoluzione fu preparata dalle classi più civili della nazione ed attuata dalle più rozze ed ignoranti.
Il sovrappiù di violenza che la connota nasce, dunque, da questa miscela terribile tra astratto intellettualismo dei «filosofi» (giornalisti, avvocati, intellettuali borghesi) che guidano la Rivoluzione al suo inizio, e l’irrompere delle masse popolari – contadine e urbane – che la spingono verso i suoi esiti più radicali e brutali.
Alla fine, l’effetto dell’esplosione rivoluzionaria è quello di distruggere la nobiltà come ceto separato, dotato di privilegi feudali, e di indebolire potentemente la monarchia; ma, al tempo stesso, essa completa quel processo di costruzione di uno Stato accentrato, normativamente e istituzionalmente uniforme, che già era stato avviato dalla monarchia assoluta: per questo – scrive Tocqueville – si deve riconoscere che, alla fine, «per quanto sia stata radicale, la Rivoluzione ha [...] innovato meno di quanto in genere non si supponga».
3. La Rivoluzione nella Terza Repubblica (Taine, Aulard, Jaurès)
La tendenza inaugurata da Tocqueville trova numerosi seguaci in ragione del notevole successo riscosso dal suo libro. L’analisi rigorosa, e perfino pedante, delle fonti, accompagnata da un’interpretazione molto esplicita del senso da attribuire all’intero processo rivoluzionario, che caratterizzano il suo lavoro, sono un modello al quale cerca di uniformarsi fra gli altri Hippolyte Taine, nella sua opera sulle Origini della Francia contemporanea.
Taine non è uno storico: è un docente di Storia dell’arte ed estetica ed è autore di opere all’epoca importanti, come la Storia della letteratura inglese (1863), che non sono in effetti ricostruzioni storiche in senso proprio. Tuttavia si fa storico in senso stretto, e storico della Rivoluzione in particolare, sulla spinta dello shock che egli – come moltissimi altri francesi – subisce per la grave sconfitta patita dalla Francia nella guerra contro la Prussia (1870-1871). A Taine questo sembra il culmine di un grave processo di decadenza che ha cominciato ad attraversare la Francia sin dallo scoppio della Rivoluzione. Seguendo, per questo aspetto, Tocqueville, e come lui sviluppando il suo ragionamento sul filo di una comparazione con la storia dell’Inghilterra, Taine arriva a sostenere che la Rivoluzione ha interrotto bruscamente un processo di trasformazione che già aveva portato a una notevole modernizzazione delle istituzioni e che forse avrebbe potuto essere proseguito senza che necessariamente si dovesse ricorrere alla violenza e ai conflitti dell’epoca rivoluzionaria.
Costruito sulla base di uno studio delle fonti accurato ma selettivo, il lavoro di Taine ha un’inclinazione valutativa molto netta: a lui interessa manifestare un giudizio assolutamente negativo sugli aspetti più brutali dell’esperienza rivoluzionaria, il cui abisso più profondo era rappresentato, senza alcuna ombra di dubbio, dalla Repubblica del Terrore, dalla direzione politica dei capi giacobini (Robespierre e Saint-Just in primo luogo) e dall’azione della «plebaglia» che ne aveva sostenuto – almeno inizialmente – il progetto politico.
Nonostante la passione etica che anima le Origini di Taine, non è il suo libro a segnare...