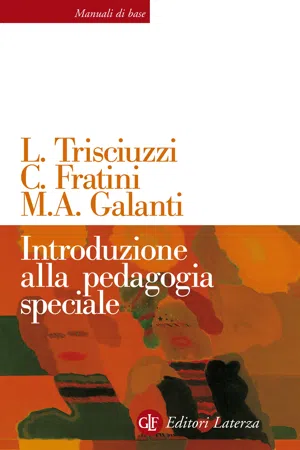
eBook - ePub
Introduzione alla pedagogia speciale
Carlo Fratini, Maria Antonella Galanti, Leonardo Trisciuzzi
This is a test
Share book
- 188 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Introduzione alla pedagogia speciale
Carlo Fratini, Maria Antonella Galanti, Leonardo Trisciuzzi
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Attualmente la pedagogia speciale, sia sul versante teorico sia nella formazione degli insegnanti – e non solo di quelli di sostegno più direttamente interessati – ha assunto una posizione rilevante nell'ambito delle Scienze della formazione. La presenza in classe di alunni diversamente abili – da quelli che venivano definiti super, alle più diversificate sfumature di alunni difficili – sollecita e socialmente impone un intervento educativo.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Introduzione alla pedagogia speciale an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Introduzione alla pedagogia speciale by Carlo Fratini, Maria Antonella Galanti, Leonardo Trisciuzzi in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Didattica & Psicologia dell'educazione. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
DidatticaSubtopic
Psicologia dell'educazione1. Nuove prospettive psicologiche
nell’approccio ai problemi dell’handicap
1. La tradizione
Negli ultimi vent’anni le iniziative e gli interventi di carattere legislativo, sociale e pedagogico in favore delle persone handicappate hanno acquisito un’importanza sempre maggiore. La cultura stessa ha subito profonde trasformazioni che, tra l’altro, hanno contribuito a produrre una maturazione critica nella pedagogia speciale la quale, dallo studio delle tecniche e dei metodi speciali, nel giro di pochi anni è passata allo studio dei bisogni specifici e alla progettazione di risposte che si collocano nella prospettiva dell’integrazione sociale1. Gli anni in cui discipline pedagogiche di ottocentesca memoria, quali la «Ortopedagogia» e la «Pedagogia emendativa» sopravvivevano ancora (e non solo a livello di insegnamenti accademici), appaiono molto lontani in rapporto alle strategie e alle concezioni attuali. Certamente la tendenza a risolvere all’interno di una logica «tecnicistica» gli interventi di carattere riabilitativo, facendoli coincidere «tout court» con la Didattica speciale o comunque con forme circoscritte di insegnamento speciale, è ancora viva e tutt’altro che superata. Ovviamente ci si richiama a una mentalità scientista, chiusa alle influenze di tipo sociale e culturale2. Tuttavia, l’obiettivo dell’integrazione sociale delle persone handicappate e svantaggiate sta lentamente modificando la mentalità corrente e quindi anche l’assetto disciplinare della Pedagogia speciale, provocando sia una dilatazione e una maggiore articolazione del campo di indagine sia una revisione critica delle metodologie e delle procedure adottate.
Il problema dell’handicap fino a pochi anni fa veniva considerato in modo diametralmente opposto. Gli handicappati fisici e i «sub-normali» (come allora i soggetti con disturbi cognitivi venivano definiti) erano dei «malati» e come tali venivano affidati ai medici che avevano il compito di prenderli in carico allo scopo di prestare le cure necessarie alla loro «guarigione». In questo modo le persone handicappate venivano sottoposte ad una raffinata quanto disumana deprivazione dei caratteri più squisitamente personali e considerate esclusivamente in funzione della loro «malattia». I grandi raggruppamenti nosografici (i ciechi, i sordi, i sub-normali, i mongoloidi, i caratteriali, gli schizofrenici), a cui la scienza medica fa abbondantemente ricorso per evidenziare sintomi e patologie comuni, finivano per svolgere il ruolo di una camicia di forza all’interno della quale alla persona deficitaria veniva a mancare la possibilità di acquisire una forma legittima di identità al di là di quella, assolutamente anonima e massificante, strettamente legata alla propria minorazione. L’handicappato, a livello scientifico e nell’immaginario collettivo, veniva così a perdere ogni parvenza di persona per diventare sostanzialmente l’espressione macroscopica di un «difetto» che, proprio perché ingigantito e generalizzato a scapito di altri aspetti della personalità, finiva inevitabilmente per essere vissuto e interiorizzato come una «colpa» da tutti quei soggetti che, loro malgrado, erano impossibilitati a realizzare un livello di «performance» nell’ambito della «normalità»3. Ciò spiega ampiamente la logica dell’emarginazione e della segregazione in base alla quale, in tempi a noi vicini, moltissimi bambini handicappati venivano «concentrati nelle scuole speciali, negli istituti, nei manicomi, collocati in luoghi protetti, lontani dallo sguardo del mondo e esclusi dai circuiti normali della vita. Nessuno richiedeva loro di assumere ruoli sociali attivi. Non esisteva nell’immaginario familiare e sociale uno spazio che prevedesse per loro un futuro diverso da quello dell’emarginazione. Piccoli “Cenerentoli”, relegati ad una vita “minore”»4.
2. Una nuova prospettiva
Oggi la situazione si presenta in modo assai diverso. La cultura nel nostro Paese (compreso quella pedagogica) è profondamente cambiata, così come gli atteggiamenti, gli stili di vita e la mentalità cosiddetta comune. Conseguentemente è profondamente cambiato il concetto stesso di handicap e quindi anche il modo di percepire le persone in condizioni di difficoltà. In altre parole, ormai appare chiaro che gli handicaps (che in ogni caso non vanno confusi con i deficit o le malattie) sono prevalentemente il prodotto di una serie di barriere di carattere architettonico, sociale, psicologico e educativo che possono ostacolare in forma permanente o transitoria chiunque, anche se in genere risultano più facilmente colpite le persone più deboli (bambini, soggetti disabili, anziani ecc.).
Il concetto di handicap dunque appare molto complesso e si innesta da un lato su una o più forme di minorazione e, dall’altro, sul modo in cui tali minorazioni vengono socialmente percepite e sulla difficoltà, o impossibilità, da parte del soggetto di accedere e integrarsi nelle comuni situazioni di vita quotidiana (scuola, lavoro, tempo libero ecc.). L’handicap è quindi una minorazione che non dipende strettamente e direttamente dal danno organico, ma piuttosto dagli atteggiamenti emarginanti con cui la società stigmatizza le persone deficitarie. Il concetto di integrazione sociale pertanto va molto al di là di quello del puro e semplice inserimento (anche se questo ovviamente costituisce uno dei prerequisiti fondamentali) e si lega con quello, assolutamente decisivo, di «qualità della vita».
A questo proposito, nell’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 1045 si afferma che «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». La protezione dallo stato di emarginazione viene ampiamente ribadita anche nell’art. 1 in cui si sottolinea che:
La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività [...] c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni [...] d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
La legge 104 recepisce tutti gli orientamenti più attuali delle discipline mediche e psicopedagogiche e ne sostiene gli aspetti più innovativi, insistendo sul fatto che la società deve assicurare a tutti uno sviluppo completo, la massima autonomia possibile e una piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale. Gli svantaggiati e i disabili non sono più relegati ai margini e condannati ad assumere uno stato di assoluta passività, ma anzi vengono sollecitati a svolgere un ruolo attivo e responsabile (almeno nei limiti delle loro possibilità).
3. Problematiche irrisolte
Questa prospettiva tuttavia, nonostante la sua piena validità, se male intesa può dar luogo ad una serie di inconvenienti piuttosto gravi. Infatti, l’aspirazione all’uguaglianza presuppone, per essere adeguatamente realizzata, una gamma di interventi terapeutico-educativi necessari tanto al processo di integrazione sociale quanto alla qualità della vita del soggetto disabile. Qui si profila un duplice rischio: la sopravvalutazione dell’efficacia terapeutica delle interazioni sociali (la cosiddetta socializzazione) a prescindere dagli interventi educativi e riabilitativi effettuati sul soggetto, oppure la sopravvalutazione degli interventi tecnici a scapito di quelli sociali, secondo una concezione che vede soprattutto nella compensazione del deficit (spesso irreversibile) la condizione primaria del reinserimento sociale. In altre parole, genitori e insegnanti, ma a volte anche medici, psicologi e tecnici della riabilitazione, entrano spesso in conflitto in una corsa alla «appropriazione» dell’handicappato, che è costretto a diventare quello che gli altri si aspettano che sia e mai ciò che realmente vorrebbe essere.
La «medicalizzazione» spesso ha lasciato il posto alla «psicologizzazione» e perfino alla «pedagogizzazione»6. Che poi significa mettere in risalto il lato nascosto del rifiuto e della pseudoaccettazione. L’handicappato non di rado viene fatto oggetto (passivo) di un impegno terapeutico-riabilitativo che vede come protagonisti soprattutto i tecnici e gli operatori, spesso in concorrenza tra loro nel rivendicare la superiorità e la priorità del proprio settore di competenza. In questo modo le antiche stigmate e i sensi di colpa vengono sostituiti da forme fittizie di pseudoidentità, un «falso sé» per dirla con Winnicott, che corrisponde agli infiniti travestimenti che il disabile è costretto ad assumere per soddisfare le aspettative delle figure salvifiche che gli ruotano attorno e lo proteggono (amorevolmente?) con ogni tipo di «cura»7. In altre parole, l’handicappato diventa oggetto di attenzioni non del tutto disinteressate da parte di operatori il cui scopo non è sempre e soltanto quello terapeutico.
Vi sono essenzialmente tre modi di instaurare un rapporto con la persona handicappata. Il primo è quello svalutativo che tende a identificare il soggetto con la parte malata e quindi a rifiutarlo. Il secondo è quello che enfatizza le problematiche sociali e nega i bisogni legati al deficit specifico. Il terzo, a mio avviso l’unico corretto, consiste nel formulare risposte tecniche sempre più adeguate ai bisogni specifici, accettando sostanzialmente la persona per quello che è e cercando al tempo stesso di eliminare le barriere culturali e sociali che costituiscono la causa principale delle situazioni di emarginazione e di svantaggio. Contribuire a migliorare la qualità della vita significa quindi aiutare a uscire dallo stato di passività e di dipendenza. E ciò richiede in primo luogo una rottura e una svolta nel modo di percepire l’handicap e di convivere con esso. Per le persone handicappate, scrive Gérard Lutte, lo stato di emarginazione significa soprattutto «l’accettazione passiva del senso che la società attribuisce all’handicap mentre la liberazione personale inizia attribuendo un altro senso, un altro significato alla propria condizione [annullare la dipendenza quindi significa] aver preso coscienza dell’emarginazione sociale [ma anche tentare di superarla] con tentativi indirizzati non a integrarsi semplicemente nella società ma a cambiarla»8.
Considerato da questa prospettiva, il problema dell’integrazione sociale non appare suscettibile di soluzione al solo livello pedagogico, sia pure attraverso interventi mirati a sviluppare le capacità di adattamento sociale (le cosiddette social skills, tanto enfat...