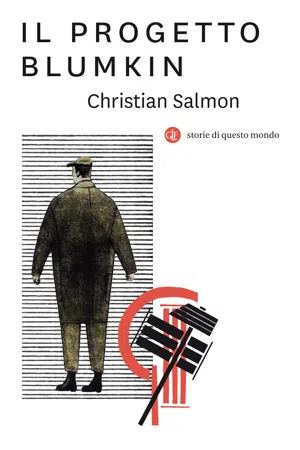Un tempo sono stato un bolscevico.
Un bolscevico per modo di dire, certo, ma pur sempre un bolscevico in carne e ossa. Con giubbotto di pelle, fazzoletto rosso al collo, sguardo scintillante. A quell’epoca le pareti del mio monolocale erano tappezzate di manifesti della Rivoluzione d’Ottobre. Su quei manifesti c’erano fucili incrociati con martelli, cerchi trafitti da triangoli, pugni alzati e slogan che suonavano come allegorie: «Spezza i Bianchi col cuneo rosso». Le locomotive sfrecciavano verso il cielo e gli operai in casacca rossa additavano il nemico di classe o il disertore. Dalla cima di un mappamondo, Lenin munito di ramazza ripuliva la superficie della terra dagli ultimi sfruttatori. E nei miei sogni scorrevano onomatopee in lettere giganti che si riproponevano come nei film di Ejzenštejn:
HO, HO, HO.
Masse accorse da ogni luogo si trasformavano in forza materiale a contatto con la teoria marxista del plusvalore. Sin dal risveglio l’immagine appesa al muro di un uomo con una benda macchiata di sangue sulla fronte mi infondeva la sua implacabile energia. La fata elettricità illuminava il mondo, i soviet facevano il resto.
Le masse irrompevano sul palcoscenico della Storia. Dietro le quinte, gli attori aspettavano il segnale per precipitarsi in scena e dire alla folla parole attese da sempre. Gli slogan sgorgavano nelle bocche fumanti. Non erano semplici oratori che si rivolgevano al popolo, era la Storia in persona che dettava le sue parole. Come se lo scopo di quei bolscevichi dai nervi d’acciaio fosse di colarsi in essa e fondervisi. «Si dice che durante le rivoluzioni gli uomini non subiscano più il fascino delle donne: la Storia ruba loro la scena. È la Storia che popola i loro sogni». E in quel sogno Lenin, berretto in mano, arringa dal palco la folla di Pietrogrado. Il treno di Trockij si lancia all’inseguimento delle armate di Kolčak e di Denikin, attraversa spazi immensi, distese desolate.
Un ragazzo di diciassette anni spara a bruciapelo a un ambasciatore. «La Rivoluzione si prende amanti giovani», aveva dichiarato Trockij ai generali tedeschi, sorpresi di dover negoziare la pace con degli adolescenti. Il motivo è presto detto: i ragazzi uccidono con più facilità.
*
A quei tempi ero capace di recitare interi passaggi dell’Armata a cavallo di Isaak Babel’ e avevo fatto mio il manifesto di Dziga Vertov «Io sono un occhio meccanico!» («via, dall’abbraccio dolciastro del romanzesco, dal veleno del romanzo psicologico, dalle grinfie del teatro d’amore»), sicuramente alla base del mio successivo rigetto della narrazione psicologica e del romanzo detto «borghese».
Ma il mio vangelo, la mia bibbia, era Il tallone di ferro di Jack London, un romanzo di cui ho dimenticato trama ed episodi principali. Mi ricordo solo di una scena nella quale Ernest Everhart, il protagonista, dimostrava a un’assemblea di saggi come il capitalismo sarebbe inevitabilmente crollato! «Voi mi dite che sogno», faceva lo spaccone il giovane sindacalista; «Benissimo. Vi esporrò i dati matematici del mio sogno». Ernest Everhart era il mio super-io politico-letterario: aveva una risposta per tutto.
Furono gli anni più ricchi, più folli, più appassionanti della mia vita. Ero innamorato di Aleksandra Kollontaj, la prima donna ambasciatrice nella storia. Isadora Duncan e Sergej Esenin, il Rimbaud russo, erano la coppia più stravagante di Mosca. Lei aveva abbandonato i teatri d’Europa per un palazzo senza riscaldamento a Mosca dove «faceva danzare i proletari». Del bolscevismo mi piaceva soprattutto il suo periodo geniale, la prima ma forse anche l’ultima rivoluzione proletaria della Storia. Il mio orologio storico era fermo al 1923, al momento in cui la Nuova politica economica (NEP) subentrava agli anni eroici del comunismo di guerra. Quello che era successo dopo, i processi, lo stalinismo, non mi riguardava. Era un’altra storia. Termidoro o la Restaurazione. Quello che m’interessava era il periodo di transizione.
Ero un bolscevico degli anni Ottanta, più a sinistra sulle questioni sociali e culturali che sul ruolo del partito d’avanguardia o la collettivizzazione delle campagne. Molto aperto per quel che riguardava i costumi e l’istituzione matrimoniale ma inflessibile sui principi della vita comunitaria e la divisione delle faccende domestiche. Con bolscevichi come me, lo zar poteva dormire sonni tranquilli...
Una volta alla settimana, in rue de Varenne, tutti noi bolscevichi di Parigi ci riunivamo in una grande aula dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales. In una spessa coltre di fumo di sigarette, il nostro professore di bolscevismo spiegava, statistiche alla mano, come la crisi della raccolta di cereali avesse provocato, in un preciso momento, la fatale rottura dell’alleanza fra operai e contadini da cui tutto derivava. Cercavamo di capire le condizioni concrete dei processi di trasformazione, i blocchi, gli errori storici, per non ripeterli nel periodo rivoluzionario che ci si sarebbe sicuramente aperto di lì in avanti. Qualche volta il seminario si prolungava fino a sera nel retro del bistrot della stazione Arts-et-Métiers della metropolitana, dove, in preda alla malinconia, mi capitava di citare il famoso testamento di Nikolaj Bucharin – condannato a morte da Stalin – che la giovane sposa Anna Larina aveva imparato a memoria e tenuto bene a mente nei suoi anni da deportata: «Ricordatevi, compagni, che sulla bandiera rossa che brandite nella vostra marcia vittoriosa per il comunismo c’è una goccia del mio sangue». Di fronte ai crimini di Stalin, volevamo rifondare il marxismo sulla salda roccia dell’esperienza vissuta. E per far questo privilegiavamo l’inchiesta sul campo: gli «anni bolscevichi» volgevano alla fine, stavamo per diventare sociologi...
*
Il mio passato bolscevico si è rifatto vivo in occasione di un trasloco. Erano passati trent’anni. Mi ero appena trasferito in una casa lungo la Marna. Non avevano ancora attaccato l’elettricità, la casa era immersa nella semioscurità e io mi spostavo alla luce del mio smartphone fra sedie accatastate le une sulle altre e fodere di materassi, cavalletti per tavoli, scatoloni di libri impilati fino al soffitto...
Per la prima volta nella vita avevo la possibilità di sistemare la mia biblioteca, dispersa fino a quel momento in diversi depositi. Da uno scatolone all’altro erano trascorsi anni e, muovendomici in mezzo, avevo l’impressione di percorrere interi decenni, risvegliare periodi in sonno. Sfiancato, finii per sedermi su un baule abbandonato dai traslocatori in mezzo al soggiorno. Era una di quelle vecchie casse di latta, verde, ammaccata di lato e agli angoli e ricoperta di timbri postali. Sul coperchio, c’era un’etichetta incollata con lo scotch sulla quale, nella penombra, decifrai un’iscrizione mezza cancellata. «BL KIN JET 79». Senza dubbio un codice di consegna.
Incuriosito, avevo sfilato il listello che teneva unite le due linguette metalliche della serratura e avevo aperto il coperchio che si era sollevato con un gemito. Il baule era pieno di libri, piazzati uno accanto all’altro a formare una specie di patchwork. Avevano soggiornato per anni nell’oscurità, rannicchiati uno contro l’altro come passeggeri clandestini, migrando da una cantina all’altra senza mai vedere la luce del sole.
Presi un primo tomo e ne illuminai la copertina con lo smartphone. Era un libro pubblicato da Gallimard nella collana «Letterature sovietiche»: Cronaca di una vita volume terzo di Konstantin Paustovskij. Sulla quarta di copertina si leggeva questa frase preceduta da una data: «1917, nella storia di un Paese si inscrive la storia di un uomo». Lo riposi delicatamente per terra, poi afferrai un secondo volume il cui titolo composto in lettere maiuscole rosse occupava tutta la pagina: UOMINI ANNI VITA di Il’ja Erenburg. Sul retro: «Un patriota che dice di venire dal più grande Paese del mondo, il Paese che porta avanti l’esperienza sociale più affascinante».
Sulla copertina di un vecchio tascabile campeggiava il disegno di un viso selvaggio, ombreggiato dai baffi, che da dietro le sbarre della sua cella guardava dei prigionieri a passeggio in un cortile innevato. Era il famoso romanzo di Arthur Koestler Buio a mezzogiorno. Lo aprii. Sul risguardo c’erano un nome e cognome scritti con una grafia tondeggiante da adolescente sedicenne. Il libro, in un’epoca lontana, era appartenuto a colei che era poi diventata la madre di mia figlia. Sfogliai un volume delle Opere complete di V.I. Lenin pubblicate dalle Éditions sociales, c’era della sabbia fra le pagine: avevo letto Lenin in spiaggia! L’autobiografia di Lev Trockij, La mia vita, giaceva accanto a una raccolta di prose di Osip Mandel’štam, Il rumore del tempo. Trockij e Mandel’štam. La Guerra e la Poesia.
Con lo smartphone feci luce sulla cassa. Mi fermai su Lo sterro di Platonov delle Editions L’Âge d’Homme, che aveva pubblicato i pilastri della letteratura russa nella collana «Classici slavi». Sotto la stessa copertina ocra, sovrastata dal logo C K, di cui non ricordavo il significato, c’erano Pietroburgo di Andrej Belyj, Vita e destino di Vasilij Grossman, Invidia di Jurij Oleša, Il ladro di Leonid Leonov, Non c’è via d’uscita di Nikolaj Leskov, Il francobollo egiziano di Mandel’stam, Il racconto del più importante di Zamjatin, Confessioni di un teppista di Sergej Esenin... Ognuno di questi titoli mi era stato caro in una vita precedente e ora ne avevo dimenticato il contenuto. Alcuni avevano orecchie agli angoli delle pagine, altri erano pieni di post-it colorati, le copertine strappate, macchiate di umidità; la patina brillante della brossura era sbiadita, lasciando affiorare la trama della carta come la pelle traslucida d’un vecchio.
Sui margini decifravo delle annotazioni a matita ormai sfumate; tracce di antiche letture divenute a tratti illeggibili, come glosse cancellate dal tempo. I paragrafi sottolineati o cassati con un tratto di matita tradivano gusti, stati d’animo, opinioni che sembravano appartenere a un’altra persona. Fra le pagine di un saggio sulla Ghepeù era scivolato un disegno fatto da mia figlia all’età di tre anni. Indicava, con la precisione del carbonio 14, la vera datazione nel mio ricordo di quell’epoca lontana.
Sotto il primo strato di libri c’erano scatole d’archivio sfondate, taccuini di diversi formati, cartoncini bristol coperti d’inchiostro blu che a tratti virava al viola, e anche un nastro rosso e nero per macchina da scrivere. In mezzo, articoli di giornale, carta da lucido con mappe geografiche, piante di città, quaderni a spirale, e delle cassette per il registratore dalle quali pendevano nastri magnetici srotolati, con le custodie di plastica spaccate, scatole di foto, fogli divisori coi buchi, pagine manoscritte, articoli di storia, testimonianze di agenti della Ghepeù passati all’Occidente, biografie di bolscevichi finiti nel dimenticatoio, fotocopie di rapporti di polizia, di interrogatori, la mappa della prigione della Lubjanka. Il découpage inquadratura per inquadratura del film di Ejzenštejn La corazzata Potëmkin... Dai Racconti di Odessa di Isaak Babel’ scivolò fuori una cartolina che era servita da segnalibro. Nella parte destra della cartolina un indirizzo: «Quinta La Rivera Prolongación av. Principal de Santa Inés Caracas. Venezuela». Quell’indirizzo era senza dubbio stato il mio, ma non ne avevo memoria. Dietro, lessi queste parole scritte a inchiostro rosso:
«Ciao Sparito! La tua lettera di febbraio l’ho ricevuta adesso perché anche io sono sparito. Bella la vita in clandestinità! Scrivimi. Saluti cari, Milan».
Mi rimisi in piedi, mi si erano addormentate le gambe. Richiusi il baule. Sul coperchio, l’iscrizione mezza cancellata «BL KIN JET 79» che avevo scambiato per il codice di uno spedizioniere mi tornò allora in mente: Blumkin PROJECT 1979. Il progetto Blumkin.
Il baule conteneva l’archivio che avevo messo insieme anni prima su un personaggio leggendario della Rivoluzione d’Ottobre: Jakov Blumkin. Era stato lui ad assassinare, su ordine del suo partito, i socialisti rivoluzionari di sinistra, l’ambasciatore tedesco a Mosca nel 1918. Era un gesto di protesta contro la pace «ignominiosa» che era stata firmata da Lenin e Trockij con la Germania a Brest-Litovsk. Poi, per tenere buoni i tedeschi, era stata annunciata l’esecuzione di Blumkin. Che rimase un annuncio, perché Trockij, che l’aveva preso sotto la sua protezione, l’aveva mandato in Ucraina a compiere missioni di sabotaggio contro le armate bianche. Un anno dopo, quando tutti lo credevano morto, Blumkin era ricomparso a Mosca. Invece di nascondersi, faceva vita mondana e di sera frequentava i caffè letterari alla moda. Una sera aveva incontrato Majakovskij che, prendendolo sottobraccio, aveva gridato «Živoj!», che significa il Vivo: un soprannome che gli è poi rimasto.
Mi sedetti sul baule e cercai il suo nome in rete, con il telefono. Comparve una galleria di foto. Cliccai sulla prima: un uomo barbuto dallo sguardo torvo circondato da un gruppo di mercanti ebrei. La didascalia diceva «Blumkin a Giaffa, 1928». In un’altra, vestito come Lawrence d’Arabia, posava in groppa a un cammello davanti alle piramidi egizie. In un’altra foto marciava sull’altopiano del Tibet. La didascalia rievocava la spedizione del pittore Roerich «alla ricerca di Shambhala, 1925». Su quest’altra foto riconobbi il viso paffuto del poeta Sergej Esenin con i suoi ciuffi biondi un po’ femminei. Accanto a lui, Blumkin vestito di pelle sembrava proteggerlo. Là, c’era il treno di Trockij: sul binario, il «Vecchio» salutava la folla agitando il berretto davanti a un’enorme bandiera rossa che, sulla sinistra, occupava un terzo della foto. Blumkin, fasciato nell’uniforme dell’Armata rossa, in piedi sul marciapiedi scrutava i visi di chi gli stava intorno. L’ultima foto era del 1920, in Persia, sulle montagne del Gilan, a quanto diceva la didascalia: un gruppo di combattenti circondava quello che sembrava essere il loro capo, la testa fasciata in una benda insanguinata.
Era lo stesso uomo su tutte le foto. Ma era difficile da credere, tanto cambiava d’aspetto da uno scatto all’altro. In una aveva il viso spigoloso, in un’altra era appesantito; in alcune sembrava avere vent’anni, in altre ne dimostrava quaranta. Eppure le date delle foto non lasciavano dubbi: c’erano solo dieci anni fra le più vecchie e le più recenti, 1918-1928. Era sicuramente lo stesso uomo, Jakov Blumkin, alias «Živoj», alias «Il Lama», alias «Sultano Zade»...
Google riportava 3300 risultati (un numero che arrivava a 16.700 se facevo la ricerca in russo, risultati che mi erano in parte comprensibili grazie ai software di traduzione). Era un database ben più ricco di quello che avevo avuto a disposizione quando avevo cominciato la mia ricerca alla BDIC – Bibliothèque de documentation internationale contemporaine – di Nanterre, dove avevo passato, all’inizio degli anni Ottanta, intere giornate a raccogliere qualche riga, a volte una semplice nota a piè di pagina, che spesso riguardava lo stesso episodio, il più famoso della vita di Blumkin: l’assassinio dell’ambasciatore tedesco nel 1918.
In cima ai risultati, la sua scheda Wikipedia in russo «Яков Григорьевич Блюмкин (ucraino: 1898 - 3 novembre 1929)» (la versione francese forniva solo brevi cenni). Feci un copia e incolla del testo su Google traduttore. Sullo schermo apparve un avviso: «Questo articolo viola la lingua russa». A leggere la traduzione si poteva dire che il software non fosse tanto tenero neanche con la lingua francese. Senza badare all’avviso, continuai nella mia lettura. Secondo alcuni Blumkin era «magro», «virile», con un viso incorniciato da una spessa barba bruna «assira», occhi cupi, sguardo torvo. Per altri era «tarchiato», il viso glabro, capelli neri e «labbra umide». «Occ...