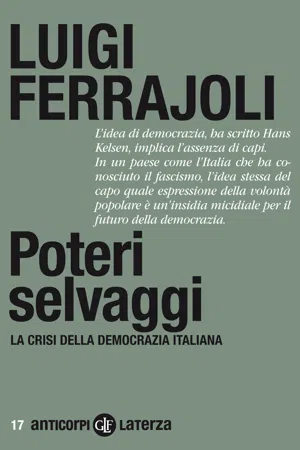1. Il paradigma della democrazia costituzionale
1.1. Le aporie della concezione puramente formale o politica della democrazia. La rigidità costituzionale
Nel senso comune la democrazia viene di solito concepita, secondo il significato etimologico della parola, come il potere del popolo di assumere, direttamente o tramite rappresentanti, le decisioni pubbliche. Questa nozione di democrazia può essere chiamata formale o procedurale, dato che identifica la democrazia sulla sola base delle forme e delle procedure idonee appunto a legittimare le decisioni come espressione, diretta o indiretta, della volontà popolare: perché la identifica, in altre parole, sulla base del chi (il popolo o i suoi rappresentanti) e del come (il suffragio universale e la regola della maggioranza) delle decisioni, indipendentemente dai loro contenuti, cioè dal che cosa viene deciso. È questa, del resto, la tesi condivisa anche dalla maggior parte dei teorici della democrazia.
La tesi che qui sosterrò è che questa nozione formale di democrazia esprime un connotato certamente necessario – una condicio sine qua non – in assenza del quale non può parlarsi di democrazia, ma non anche una condizione sufficiente a identificare tutte le condizioni in presenza delle quali un sistema politico è qualificabile come «democratico» e, specificamente, come una «democrazia costituzionale». Per due ragioni, corrispondenti ad altrettante aporie, che richiedono che i connotati formali della democrazia siano integrati da limiti e vincoli sostanziali o di contenuto, cioè relativi al che cosa non è lecito decidere o non decidere, come sono quelli imposti, nelle odierne costituzioni, dai diritti fondamentali in esse stabiliti.
In primo luogo una simile nozione, se può valere a definire la dimensione politica o formale della democrazia, non è in grado di dar conto delle attuali democrazie costituzionali, le quali non rientrerebbero, sulla sua base, nel concetto di democrazia dato che in esse la legittimazione popolare non è più sufficiente a legittimare qualunque decisione. Essa difetta, perciò, di portata empirica e di capacità esplicativa. In forza del mutamento di paradigma generato dal costituzionalismo rigido nella struttura delle democrazie, infatti, anche il potere legislativo e quello di governo sono giuridicamente limitati e vincolati con riguardo non più soltanto alle forme, ma anche alla sostanza del loro esercizio. Questi limiti e questi vincoli sono imposti a tali poteri dai diritti costituzionalmente stabiliti, i quali identificano quella che possiamo chiamare la sfera dell’indecidibile: la sfera del non decidibile che, disegnata dai diritti di libertà, i quali vietano come invalide le decisioni con essi in contrasto, e la sfera del non decidibile che non, disegnata dai diritti sociali i quali impongono come dovute le decisioni dirette a soddisfarli. Conseguentemente, poiché questi limiti e vincoli di contenuto contraddicono la nozione puramente politica della democrazia, basata su regole solo formali che consentono la virtuale onnipotenza delle maggioranze, dovremmo ammettere che le odierne democrazie costituzionali non sono, alla stregua di tale nozione, democrazie.
In secondo luogo quella nozione puramente formale ignora il nesso concettuale che lega la democrazia politica e tutti quei diritti costituzionalmente stipulati che operano come limiti o vincoli di contenuto alla volontà altrimenti assoluta delle maggioranze. Tali diritti disegnano perciò la dimensione costituzionale della democrazia che, con un’espressione logorata dai suoi usi ideologici, ben possiamo chiamare sostanziale perché riferita alla sostanza, cioè al che cosa dalle costituzioni è vietato o è obbligatorio decidere. Si tratta di un duplice nesso. Da un lato l’esercizio consapevole e informato dei diritti politici suppone la garanzia dei classici diritti di libertà – di parola, stampa, di associazione e di riunione – nonché dei diritti sociali, come i diritti alla salute e all’istruzione. Dall’altro, in assenza di qualunque limite sostanziale relativo ai contenuti delle decisioni legittime, una democrazia non può – o, quanto meno, può non – sopravvivere essendo sempre possibile, in via di principio, che con metodi democratici si sopprimano, a maggioranza, gli stessi metodi democratici: non solo i diritti di libertà e i diritti sociali, ma anche gli stessi diritti politici, il pluralismo politico, la separazione dei poteri, la rappresentanza, in breve l’intero sistema di regole nel quale consiste la democrazia politica. Non è un’ipotesi di scuola: fascismo e nazismo, nel secolo scorso, si impadronirono del potere in forme legali e poi lo consegnarono «democraticamente» e tragicamente a un capo che soppresse la democrazia.
Fu proprio sulla base di quelle tragiche esperienze che si è prodotto in Europa, all’indomani della seconda guerra mondiale, un mutamento di paradigma sia del diritto che della democrazia, attraverso la costituzionalizzazione dell’uno e dell’altra. Questo mutamento è consistito nella soggezione dell’intera produzione del diritto, inclusa la legislazione, a norme costituzionali rigidamente sopraordinate a tutti i poteri normativi e perciò nel completamento del modello paleopositivistico dello stato di diritto. Nel vecchio stato legale di diritto il potere legislativo delle maggioranze parlamentari era un potere virtualmente assoluto, non essendo stata neppure concepita la possibilità di una legge che limitasse la legge. Esistevano, è vero, costituzioni e diritti fondamentali stipulati in carte costituzionali. Tuttavia, almeno nel continente europeo, queste carte erano costituzioni flessibili: leggi solenni, ma pur sempre leggi, che il legislatore ordinario ben poteva validamente modificare con leggi successive. I principi e i diritti in esse stabiliti operavano perciò, di fatto, come limiti e vincoli soltanto politici, privi di una forza giuridica in grado di vincolare la legislazione.
È così accaduto, in un paese di deboli tradizioni liberal-democratiche come l’Italia, che il fascismo poté stracciare con le sue leggi lo Statuto albertino e affossare la democrazia e le libertà fondamentali senza un formale colpo di Stato: si trattò infatti di un colpo di Stato nella sostanza, ma non anche nelle forme, dato che le leggi fasciste, incluse quelle che fecero a pezzi lo stato di diritto e la rappresentanza parlamentare, erano ritenute formalmente valide perché votate da maggioranze di deputati secondo i canoni della democrazia politica o formale. Per questo possiamo ben dire che l’antifascismo è un connotato genetico non solo della democrazia italiana, che lo ha sancito esplicitamente nella sua Costituzione, ma in generale della democrazia costituzionale nata dalle rovine della seconda guerra mondiale e dei fascismi: perché la democrazia, dopo quelle catastrofi, si è ridefinita ed ha preso nuova coscienza di sé, stipulando in norme di diritto positivo rigidamente sopraordinate alla legislazione ordinaria quei limiti e quei vincoli fino ad allora soltanto politici – la separazione dei poteri, la pace, l’uguaglianza e la garanzia dei diritti fondamentali – che il fascismo aveva rinnegato.
La rigidità delle costituzioni approvate in Italia e in Germania dopo la guerra, e poi in Spagna e in Portogallo dopo la caduta delle dittature, ha così cambiato, radicalmente e simultaneamente, sia le condizioni di validità delle leggi che la struttura della democrazia. Collocando al vertice della gerarchia delle fonti le norme costituzionali, essa ha reso vincolanti, nei confronti della legislazione, le aspettative universali nelle quali consistono i diritti da esse stabiliti: quali aspettative negative della non lesione dei diritti di libertà e quali aspettative positive della soddisfazione dei diritti sociali. Ne risultano due mutamenti di paradigma, tra loro connessi e paralleli: in primo luogo del diritto e delle condizioni, non più solo formali ma anche sostanziali, della validità delle leggi; in secondo luogo della struttura della democrazia, caratterizzata a sua volta non più dalla sola dimensione politica o formale, ma anche da una dimensione sostanziale, relativa ai contenuti delle decisioni.
1.2. I limiti e i vincoli costituzionali alla validità sostanziale delle leggi. Il diritto illegittimo
Il primo cambiamento riguarda le condizioni di validità delle leggi. Nel paradigma paleopositivistico dello Stato liberale, la legge, qualunque ne fosse il contenuto, era la fonte suprema e illimitata del diritto. Non esisteva infatti, nell’immaginario dei giuristi e tanto meno nel senso comune, l’idea di una legge sopraordinata alla legge in grado di vincolare i contenuti dell’attività legislativa. Questa onnipotenza della legge viene meno con l’affermazione della Costituzione come norma suprema alla quale tutte le altre sono rigidamente subordinate. Grazie a questa innovazione la legalità cambia natura: non è più solo condizionante e disciplinante, ma è essa stessa condizionata e disciplinata da vincoli giuridici non più solo formali ma anche sostanziali; non è più semplicemente un prodotto del legislatore ma è anche progettazione giuridica della qualità della stessa produzione legislativa, e quindi un limite e un vincolo al legislatore. Sicché del diritto risulta positivizzato non più solo l’essere, ossia la sua «esistenza», ma anche il suo dover essere, ossia le sue condizioni di «validità»; non più solo il chi e il come delle decisioni, ma anche il che cosa non deve essere deciso, ossia la lesione dei diritti di libertà, o al contrario deve essere deciso, ossia la soddisfazione dei diritti sociali.
Questo diritto sul diritto, questo sistema di norme metalegali nel quale consistono le odierne costituzioni rigide non si limita dunque a regolare le forme di produzione del diritto mediante norme procedurali sulla formazione delle leggi, ma ne vincola altresì i contenuti mediante norme sostanziali sulla produzione quali sono, in particolare, quelle che enunciano diritti fondamentali. Li vincola al rispetto e all’attuazione di tali diritti, la cui violazione genera antinomie, consistenti nell’indebita presenza di norme sostanzialmente invalide perché con essi in contrasto, oppure lacune, consistenti nell’assenza, parimenti indebita, delle norme che ne stabiliscano le necessarie garanzie. Ne consegue che la validità delle leggi dipende dall’osservanza non più soltanto delle norme procedurali sulla loro formazione, ma anche delle norme sostanziali sul loro contenuto. Grazie alle costituzioni rigide fa così la sua comparsa, nelle democrazie costituzionali, il diritto illegittimo, stranamente negato come «contraddizione in termini» da Hans Kelsen, che pure ha teorizzato la struttura a gradi dell’ordinamento e il controllo di costituzionalità delle leggi. Perché una legge sia valida è oggi necessario che non solo le sue forme, cioè i procedimenti di formazione degli atti legislativi, siano conformi, ma anche che la sua sostanza, cioè i suoi significati o contenuti, siano coerenti con le norme costituzionali che ne disciplinano la produzione.
1.3. La dimensione sostanziale, oltre che formale, della democrazia
Questo mutamento delle condizioni di validità delle norme retroagisce, per l’isomorfismo che sempre sussiste tra diritto e sistema politico, sulle condizioni della democrazia, anch’esse non più soltanto formali, ma anche sostanziali. La costituzionalizzazione rigida dei diritti fondamentali, imponendo divieti e obblighi ai pubblici poteri, ha infatti innestato anche nella democrazia una dimensione sostanziale relativa a ciò che non può essere o deve essere deciso da qualunque maggioranza, in aggiunta alla tradizionale dimensione politica, meramente formale o ...