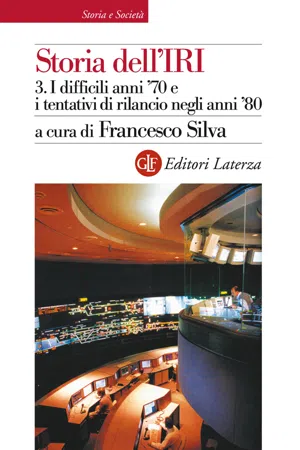1. Gli anni Settanta: una frattura nel processo di crescita
di Innocenzo Cipolletta
1. Introduzione
Gli anni Settanta hanno costituito una frattura nel processo di crescita non solo dell’economia italiana, ma di tutta l’economia mondiale. Con il senno del poi, possiamo dire che il passaggio dagli anni Sessanta agli anni Settanta ha rappresentato un cambio epocale, che ci ha introdotto in nuove problematiche che caratterizzeranno i decenni successivi.
Ricordiamo, solo per enumerazione, i fatti salienti. La guerra del Vietnam con la prima sconfitta degli Usa. Lo scoppio della contestazione giovanile. La fine del sistema di Bretton Woods e l’avvio della fluttuazione generalizzata dei cambi. La crisi del petrolio e la moltiplicazione del prezzo del greggio. L’impennarsi dell’inflazione. La frattura nei ritmi di crescita delle economie occidentali. L’avvento della stagflazione. Le riconversioni produttive e i nuovi modelli di gestione aziendale. La finanziarizzazione dell’economia derivante dai forti squilibri nelle bilance dei pagamenti. L’emergere di una questione palestinese e le guerre in Medio Oriente. L’espandersi del fondamentalismo religioso e la rivoluzione in Iran.
Di colpo l’attenzione internazionale si spostò dall’Estremo Oriente (Cina e Vietnam, dopo che la guerra di Corea si era conclusa) al Medio Oriente e dalle questioni politico-militari a quelle di carattere eminentemente economico. Il tasso di crescita dei paesi industriali si interruppe bruscamente ed emersero nuove aree di sviluppo: i paesi produttori di petrolio e di materie prime. L’inflazione cambiò tutti i rapporti reciproci tra i valori. Le bilance dei pagamenti dei principali paesi si squilibrarono in modo strutturale. Emersero una nuova finanza (i petrodollari) e nuovi strumenti finanziari che fecero crescere il rapporto finanza/Pil mondiale a livelli mai immaginati prima. Nacquero le grandi banche d’affari, che si sostituirono alle «sette sorelle» dell’energia nel dominare l’economia mondiale. È quindi lecito dire che, con gli anni Settanta, il mondo superò le problematiche che erano derivate dal secondo conflitto mondiale e affrontò i temi che saranno dominanti almeno nei cinquant’anni successivi.
In un certo senso, gli anni Settanta hanno dunque rappresentato il passaggio alla modernità, senza che a questo termine si debba attribuire un colore positivo o negativo. Per descrivere sommariamente questi eventi alla luce di quelle che saranno le ripercussioni sul sistema delle imprese italiane, e in particolare con riferimento all’IRI, appare utile iniziare con gli eventi internazionali, senza i quali è difficile capire le vicende della nostra economia. Si passerà poi a parlare più specificamente dei fatti italiani, a partire, appunto, dall’«autunno caldo» del 1969, che ha rappresentato una frattura per il nostro paese in ragione dei sommovimenti sociali, economici e politici che ha prodotto. Si affronteranno l’entrata dell’Italia nella stagflazione e i riflessi che essa ha avuto sul tessuto produttivo nazionale. Si farà menzione delle politiche industriali avviate o tentate in quegli anni, per poi analizzare il capitolo della finanza pubblica italiana che, a partire dagli anni Settanta, inizia a squilibrarsi.
Gli squilibri di finanza pubblica del nostro paese si evidenziano con l’entrata nel nuovo decennio (gli anni Ottanta). Essi vengono messi prepotentemente in luce dal cosiddetto «divorzio» tra Banca d’Italia e Tesoro, che sancisce la fine della monetarizzazione del disavanzo pubblico. Anche questo evento, però, è strettamente legato al cambio di indirizzo internazionale, posto che dagli Usa si dà il via a una politica di rialzo del costo del denaro per stoppare l’inflazione. Gli anni Ottanta saranno segnati da una ristrutturazione microeconomica che porterà molte imprese italiane a recuperare un migliore assetto. Ma a questa ristrutturazione micro farà da contrappeso un persistere o aggravarsi degli squilibri macroeconomici, in termini di finanza pubblica, di inflazione, di bilancia dei pagamenti. In un certo senso i due fenomeni sono legati, posto che il recupero di efficienza del sistema produttivo italiano si è giovato del ricorso alla finanza pubblica e della svalutazione della lira, entrambi fattori che hanno contribuito alla crescita del disavanzo pubblico. Infatti le continue svalutazioni della lira hanno comportato un consistente rialzo dei tassi di interesse, che a loro volta hanno determinato una crescente spesa per il servizio del debito pubblico. È così che la svalutazione della lira ha finito per aggravare gli squilibri di finanza pubblica. Bisognerà attendere gli anni Novanta per vedere avviata una decisa manovra di riequilibrio di tipo macroeconomico. Ma, quasi a contrappasso di tale riequilibrio, da quel momento l’apparato produttivo del paese perde colpi e inizia una stagione di crescita molto bassa, che perdurerà anche nel decennio successivo.
2. La fine di Bretton Woods e la nuova geografia economica e politica
L’impegno americano nel Vietnam può essere considerato come l’ultimo prodotto della seconda guerra mondiale. La fine dell’epoca coloniale in Africa e in Asia vedeva la nascita di nuove nazioni, che facilmente cadevano sotto l’influenza dei paesi comunisti o, al meglio, davano luogo ad espressioni di terzomondismo. Così era successo con la Corea dopo la dominazione giapponese (dal 1910 al 1945), ed era stata necessaria una sanguinosa guerra per arginare al Nord l’influenza sovietica e cinese. Lo stesso stava accadendo con il Vietnam, dopo che l’esercito francese era stato sconfitto e la Francia si apprestava a lasciare la regione. L’entrata in guerra degli Usa al fine di sostenere il Vietnam del Sud contro quello del Nord, ormai alleato della Cina comunista, comportò un ingente esborso di denari, oltre che, purtroppo, moltissime vittime.
Il costo complessivo della guerra del Vietnam è stato valutato in più di 500 miliardi di dollari, che all’epoca costituivano una cifra consistente, posto che nel 1970 il Pil degli Usa era di poco superiore ai 1.000 miliardi di dollari. Questa spesa fu in larga parte sostenuta dagli Usa e comportò un forte disavanzo pubblico per quel paese. A sua volta il disavanzo pubblico finanziò spese all’estero e mantenne elevata la domanda interna, contribuendo così a generare un forte debito estero. Ma i costi non furono solo di natura finanziaria. La guerra provocò circa dieci milioni di morti, in larghissima parte vietnamiti, sia tra i civili (quattro milioni) che tra i militari (oltre cinque milioni).
Il numero delle vittime in campo avverso fu nettamente inferiore: morirono 58.000 soldati e ne furono feriti 153.000. Tuttavia le reazioni all’intervento militare e alle perdite di vita furono rilevanti negli Usa e anche nel mondo occidentale. Negli Stati Uniti scoppiò la rivolta studentesca, che si diffuse poi anche in Europa a partire dal 1968. In tutte le capitali europee ci furono movimenti di rivolta a carattere studentesco e operaio, che si estesero anche oltre la cortina di ferro, nel mondo comunista. Il 1968 rappresentò simbolicamente una frattura e con esso finì di fatto il dopoguerra. La guerra fredda, che aveva fin lì dominato le relazioni internazionali, sembrava non avere più senso. In realtà tutti gli anni Sessanta hanno covato reazioni e movimenti che finirono per incidere fortemente sugli sviluppi dei decenni successivi.
È dalla fine di quel decennio che gli Usa cominciarono ad accusare crescenti squilibri nella bilancia dei pagamenti, oltre che nei conti pubblici. Fino allora essi avevano potuto finanziare il loro deficit sui mercati internazionali grazie alle regole sancite a Bretton Woods. Infatti, secondo quegli accordi, presi alla vigilia della fine della seconda guerra mondiale, ogni moneta fissava la sua parità con il dollaro Usa e quest’ultimo garantiva un cambio stabile con l’oro (35 dollari l’oncia di oro fino). Qualsiasi paese che avesse avuto un avanzo nei conti con l’estero poteva scegliere di detenere dollari oppure oro, che erano equivalenti per le loro riserve. Ma, con l’aggravarsi dello squilibrio dei conti con l’estero degli Usa, le riserve degli altri paesi cominciarono a crescere notevolmente, assorbendo sempre più dollari, ciò che aumentava il debito esterno americano, a fronte del quale le riserve in oro statunitensi cominciavano a risultare insufficienti.
In queste condizioni, il mercato dell’oro cominciò a mostrare tensioni, anche perché alcuni paesi (in particolare la Francia, con il presidente Charles De Gaulle) decisero di convertire in oro parte dei dollari accumulati nelle loro riserve. Poiché non sarebbe stato possibile soddisfare tutta la potenziale domanda di oro, si decise di sdoppiarne il mercato in due: quello privato, dove l’oro avrebbe segnato un prezzo equivalente al rapporto tra domanda e offerta, e quello pubblico delle Banche centrali, dove l’oro fino sarebbe stato scambiato sempre al prezzo di 35 dollari l’oncia.
Questo espediente servì a calmare le acque per poco tempo. Tuttavia, le tensioni continuarono, fino a che, nell’agosto del 1971, gli Usa decisero il blocco della convertibilità del dollaro e successivamente venne decretata una svalutazione della moneta statunitense (circa il 10% in media nei confronti delle altre principali valute). Con questa decisione prendeva fine l’accordo di Bretton Woods. A partire da tale data, le monete presero a fluttuare sul mercato dei cambi senza che alcun paese fosse costretto a sostenere il corso della propria moneta. Ne derivò una forte instabilità che si riversò presto sulle materie prime, diventate rifugio per molti investitori contro l’incertezza delle monete. Si determinò così una bolla speculativa sulle materie prime che favorì una qualche ripresa economica, ma generò anche una forte instabilità.
Nacque in questo contesto la crisi del petrolio, la cui produzione era concentrata in pochi paesi del Medio Oriente. La scintilla che la fece scoppiare fu la guerra del Kippur (iniziata il 6 ottobre 1973), vinta dagli israeliani contro l’Egitto e la Siria (24 ottobre 1973). I paesi arabi non accettarono le nuove acquisizioni di territori da parte del vincitore e dichiararono un embargo totale di petrolio contro tutti i paesi che avevano sostenuto Israele.
Se la scintilla della crisi del petrolio fu politica, la sua esplosione fu essenzialmente economica. In effetti, i paesi aderenti all’Opec (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) colsero questa occasione per recuperare potere d’acquisto nei confronti dei paesi consumatori. E ci riuscirono. Alla scadenza dell’embargo, il prezzo del petrolio fu quadruplicato e questo evento squilibrò in modo permanente tutto il sistema dei pagamenti internazionali. Nacquero da lì i petrodollari e la finanziarizzazione dell’economia mondiale, come pure l’ondata d’inflazione mondiale, la riduzione delle capacità di crescita dei paesi industriali e la necessità di riformare tutta la struttura di produzione e di consumo. In altre parole, nacque da lì la stagflazione.
Di colpo cambiò la geografia economica e politica mondiale. Le tensioni militari non furono più in Estremo Oriente ma nel Medio Oriente. Il vecchio sistema dei pagamenti internazionali venne abolito e ne nacque uno nuovo. Nuovi soggetti economici emersero: i paesi esportatori di petrolio, che iniziarono un loro processo di sviluppo. Il commercio internazionale vide cambiare radicalmente i suoi flussi. Prese il via una vera e propria ondata di innovazioni tecnologiche per rispondere ai problemi del caro petrolio. Iniziò una nuova era.
3. L’Italia nella tormenta internazionale e interna
Per l’Italia gli anni Sessanta erano stati veramente l’apice del miracolo economico. Un termine ambiguo, quest’ultimo, che sta ad indicare come gli italiani non seppero spiegarsi il perché del loro successo, tanto da chiamarlo «miracolo». E questa incapacità di comprensione non fu certamente estranea al successivo fallimento del miracolo, posto che la politica agì in modo da contrastare o eliminare quei fattori che avevano consentito una forte crescita economica attraverso l’imposizione di regole e di normative che contribuirono a spegnere il dinamismo imprenditoriale. Ma non lo capirono neanche gli stessi imprenditori, che, invece di capitalizzare i risultati della crescita ed avviare nuove iniziative industriali, preferirono esportare all’estero i loro capitali o investirli prevalentemente nella proprietà immobiliare.
Sulla scia del maggio francese del 1968 e sotto la pressione per gli aumenti salariali e per la modernizzazione nelle relazioni industriali, scoppiò, nell’autunno del 1969, una serie di scioperi volti a far crescere i salari, che erano stati compressi negli anni precedenti. La tornata sindacale si concluse con incrementi salariali consistenti (l’aumento dei minimi contrattuali dell’industria fu del 22,4% tra il dicembre del 1969 e il dicembre del 1970, secondo i dati Istat dell’epoca), ma questo non riportò la pace nelle aziende. Al contrario, si avviò una fase di nuove e più pressanti richieste. I governi di centro-sinistra di quegli anni non se la sentivano di negare concessioni e diedero il via a una stagione di profonde riforme sociali.
La stagione delle riforme sociali caratterizzò tutti gli anni Settanta. Venne adottato lo Statuto dei lavoratori (1970), che sanciva molti diritti e tutelava in particolare l’attività sindacale nelle aziende. Si abolirono le gabbie salariali, con la conseguenza di un aumento dei costi nelle regioni meridionali (1972). Successivamente, si avviò e si concluse una trattativa per l’equiparazione del punto di contingenza (1975) che fece esplodere i salari specie nei settori a più elevato lavoro femminile, che era pagato meno. Nella seconda metà degli anni Settanta si avviò la riforma sanitaria per estendere la copertura in modo universale senza generalizzare la contribuzione. Lo stesso avvenne per le pensioni, che vennero estese a tutta la popolazione concedendo un minimo a chi fosse scoperto da contributi. Si arrivò a definire come «indipendente» la variabile del salario, ad intendere che il salario sarebbe stato fissato secondo i bisogni dei lavoratori e che le imprese avrebbero dovuto adattare tutto il resto al nuovo livello salariale.
In effetti, l’Italia tentò di recuperare il ritardo in campo sociale che si era accumulato nel tempo rispetto agli altri paesi industriali. A tal fine, il nostro paese copiò i modelli sociali più avanzati esistenti nelle esperienze degli altri paesi sviluppati. Ne derivò un carico di costi e di rigidità che venne introdotto essenzialmente nel corso della prima metà degli anni Settanta, ossia in un periodo turbolento dal punto di vista economico per gli eventi internazionali di cui abbiamo detto. Di fatto, l’Italia introdusse forti rigidità proprio negli anni in cui emergeva la crisi del petrolio, che invece avrebbe richiesto maggiori gradi di flessibilità proprio per adattare i sistemi di produzione e di consumo alle nuove condizioni emergenti sui mercati. E così, mentre altri paesi cominciavano a domandarsi come poter alleggerire i loro sistemi per consentire un migliore adattamento alle nuove condizioni del mercato, in Italia si andavano irrigidendo le condizioni di lavoro e di produzione.
La crisi del petrolio precipitò l’Italia in una profonda recessione mentre essa era scossa da forti tensioni interne e da trame eversive. Il paese stentava a ritrovare un sentiero di crescita. Il clima di sfiducia era forte. Infatti, l’Italia usciva dal suo «miracolo economico» con una forte domanda di riforme sociali...