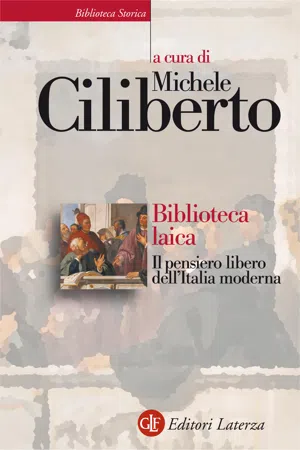1. Sulla condizione umana
Leon Battista Alberti
Leon Battista Alberti (Genova 1404-Roma 1472), spesso presentato come ‘uomo universale del Rinascimento’ per i suoi molteplici interessi e la varietà dei suoi scritti e delle sue attività, trascorre molti anni presso la Curia pontificia (1432-1464), come abbreviatore apostolico; in contatto con le cerchie umanistiche di Roma e Firenze, lavora come architetto per Ludovico Gonzaga, Sigismondo Malatesta e la famiglia Rucellai, progettando tra l’altro la facciata di Santa Maria Novella a Firenze. Oltre che architetto, Alberti è anche autore di importanti testi letterari: in questo ambito, specie negli ultimi decenni, particolare attenzione è stata dedicata dagli studiosi a quegli scritti, sia volgari che latini, nei quali è più marcata la riflessione sulla follia e la miseria dell’uomo: tra questi vi è il Theogenius (1441), dedicato a Leonello d’Este in obitu parentis, che si presenta esplicitamente come una ‘consolatoria’, sul modello di Seneca e Plutarco, ovvero una riflessione sulla caducità delle cose umane che dovrebbe attutire il dolore e indurre ad una maggiore serenità d’animo. La stesura stessa del testo, da parte di Alberti, assolve una funzione ‘terapeutica’: «io scrissi questi libretti non ad altri che a me per consolare me stessi in mie avverse fortune». La riflessione di Teogenio, l’omonimo protagonista dell’opera, si incardina su alcuni motivi topici della trattazione de homine: il confronto tra animali e uomini, risolto a tutto svantaggio dei secondi; il potere nefasto della Fortuna, che illude coloro che le si sono affidati solo per travolgerli in modo più rovinoso; la morte come porto sicuro nel tempestoso mare della vita; l’opera sovvertitrice dell’uomo che sconvolge e mistifica l’ordine naturale. L’amarezza del tono e il profluvio di testimonianze addotte da Alberti a tratti oscurano l’intento consolatorio del dialogo e ne fanno una denuncia amara e irrevocabile della miseria umana. Sarebbe semplicistico ridurre l’atteggiamento albertiano al pessimismo moderno; sta di fatto, però, che Alberti non è neppure assimilabile all’‘altra’ tradizione incentrata sul contemptus mundi, quella di teologi e predicatori, in cui la critica dell’uomo e dei beni mondani costituiva una tappa nel cammino spirituale di avvicinamento a Dio; la novità umanistica (e di Alberti in particolare che, a differenza di autori come Poggio Bracciolini, non fa neppure menzione di un supposto stato di peccato originale dell’uomo) risiede, da un lato, nel sostituire alle fonti bibliche e religiose le autorità classiche e, dall’altro, nel circoscrivere – più o meno rigorosamente – l’ambito della discussione alla vita terrena.
Altri testi in cui la meditazione albertiana sull’uomo si fa più ironica e pungente sono il Momus e le Intercenales (sui quali cfr. i passi riportati ai punti successivi); ma il vasto corpus delle opere albertiane comprende anche dialoghi sul reggimento della famiglia (Libri della famiglia, 1433-1441; De iciarchia, 1470), sulla natura umana e sulle avversità della sorte (Profugiorum ab aerumna libri III, 1441-1442) e una serie di scritti morali e satirici in latino (Apologi, Musca, Pontifex). All’attività di architetto Alberti affianca inoltre la composizione di trattati artistici (De pictura, 1435 ca.; De statua; De re aedificatoria) e di topografia (Descriptio urbis Romae); difensore del valore letterario del volgare, organizza a Firenze un Certame coronario sul tema dell’amicizia (1441) e scrive una Grammatichetta (1438-1441 ca.). Tra i suoi scritti minori si possono infine ricordare una commedia giovanile, la Philodoxeos fabula, e un opuscolo sulla crittografia (De componendis cyfris, 1466-1467).
E. Garin, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, Laterza, Roma-Bari 1975; C. Grayson, Studi su Leon Battista Alberti, a cura di P. Claut, Olschki, Firenze 1998.
1.1. «Omo... quasi umbra d’un sogno»
Non adunque dobbiamo maravigliarci, omicciuoli mortali e sopra tutti gli altri animali infermissimi, se mai quando che sia riceviamo qualche calamità, poiché noi vediamo le terre e provincie intere suggette ad ultimi estermini e ruine. E quale stolto non aperto conosce l’uomo, come dicea Omero, sopra tutti gli altri animanti in terra vivere debolissimo. Sentenza di Pindaro, poeta lirico, l’omo essere quasi umbra d’un sogno1. Nacque l’uomo fra tanto numero d’animanti, quanto vediamo, solo per effundere lacrime, poiché subito uscito in vita a nulla prima se adatta che a piangere, sì come che instrutto dalla natura presentisca le miserie a quali venne in vita, o come gli dolga vedere che agli altri tutti animali sia dato dalla natura vario e utile vestire, lana, setole, spine, piuma, penne, squame, cuorio2 e lapidoso scorzo, e persino agli albori stieno sue veste duplicate l’una sopra all’altra contro el freddo e non disutile a diffendersi dal caldo, l’uomo solo stia languido giacendo nudo e in cosa niuna non disutile e grave a sé stessi. Agiugni che dal primo dì vedesi collegato in fascie e dedicato a perpetua servitù, in quale poi el cresce e vive. Non dunque iniuria3, subito che nasce, piange la sua infelicità, né stracco di dolersi prima prende refrigerio a’ suoi mali, né prima ride se non quando se stessi contenne in tristezza interi almeno quaranta dì. Di poi cresce in più ferma età quasi continuo concertando contra alla debolezza, sempre in qual vuoi cosa desiderando e aspettando l’aito d’altrui. Nulla può senza precettore, senza disciplina, o al tutto sanza grandissima fatica, in quale sé stessi per tutta la sua età esserciti. In puerizia vive mesto sotto el pedagogo; e seguenli suoi giorni in gioventù solliciti e pieni di cure ad imparare leggi e instituiti della patria sua; e poi sotto la censura del vulgo in più età ferma posto soffre infiniti dispiaceri. E quando el ben sia compiuto e offirmato in sue forza e membra, e ornato d’ogni virtù e dottrina, non però ardisce non temere ogni minima bestiuola, e nato per imperare a tutti gli animanti conosce quasi a tutti gl’animali sua vita e salute essere sottoposta. Un verminuccio el molesta; ogni minima puntura l’uccide. Scriveno e’ poeti che a Orione, figliuolo di Iove, compagno di Diana, gloriandosi d’essere sopra degli altri fortissimo e potere uccidere qualunque fera a lui si opponesse, gli dii comossi4 dierono che un picciolo scorpione lo atterrò in morte. Affermano e’ medici una moscolina pasciuta d’un cadavere venenoso potere essere mortifera. E raccontano e’ fisici trovarsi uno animale chiamato salamandra quale solo salendo avenena tutti e’ pomi in su quello albero dove e’ salse, di veneno simile all’acconito, ed esserne già periti e’ populi. Potrei estendermi in quante erbe, in quanti frutti, in quanti animali, in quante cose la natura vi ponesse contro di noi veneno e morte, e quasi possiamo affermare nulla trovarsi fra e’ mortali in quale non sia forza di darci a morte. Un pelo beuto fra el latte strangolò Fabbio senatore. Uno acino d’uva strozzò Anacreonte filosofo. [...] E non solo queste cose materiali, ma e in qualunque vòi altra cosa troverai morte. L’agitazion dell’animo ci sta mortale. [...] Agiugni le altre infermità quale già tante passate età con tante vigilie, tante investigazioni, tanta industria, tanta copia di scrittori e volumi, tanta varietà di rimedi possono né vietarle né ben distorle. E insieme aggiugni e’ nuovi e vari morbi quali di dì in dì surgono a’ mortali. [...] Né truovasi animale alcuno tanto da tutti li altri odiato quanto l’uomo. Agiugni ancora quanto a sé stessi l’uomo sia dannoso con sua ambizione e avarizia e troppa cupidità del vivere in delizie e ozio pieno di vizi; qual cose non meno che gli altri suoi infortuni premono e’ mortali. Agiugni la somma stoltizia quale continuo abita in le menti degli uomini, poiché di cosa niuna contento né sazio sempre sé stessi molesta e stimola. Gli altri animali contenti d’un cibo quanto la natura richiede, e così dare opra a’ figliuoli servano certa legge in sé e certo tempo: all’uomo mai ben fastidia la sua incontinenza5. Gli altri animali contenti di quello che li si condice: l’omo solo sempre investigando cose nuove sé stessi infesta. Non contento di tanto ambito della terra, volle solcare el mare e tragettarsi, credo, fuori del mondo; volle sotto acqua, sotto terra, entro a’ monti ogni cosa razzolare, e sforzossi andare di sopra e’ nuvoli. [...] O animale irrequieto e impazientissimo di suo alcuno stato e condizione6, tale che io credo che qualche volta la natura, quando li fastidii tanta nostra arroganza che vogliamo sapere ogni secreto suo ed emendarla e contrafarla, ella truova nove calamità per trarsi giuoco di noi e insieme essercitarci a riconoscerla. Che stoltizia de’ mortali, che vogliamo sapere e quando e come e per qual consiglio e a che fine sia ogni instituto e opera di Dio, e vogliamo sapere che materia, che figura, che natura, che forza sia quella del cielo, de’ pianeti, delle intelligenze, e mille secreti vogliamo essere noti a noi più che alla natura. Che se un tuo figliuolo, non voglio dire un simile a te, verso chi governa el cielo, volesse riconoscere ogni tua o...