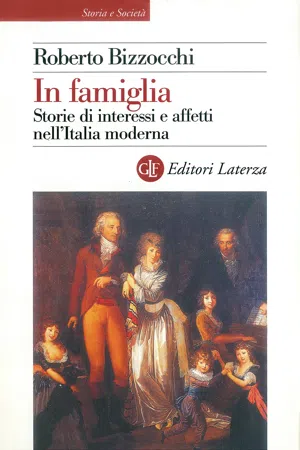III.
Antonio: la primogenitura.
Atanasio: l’identità
L’ultimo secolo non ha portato via, nel 1799, tutti gli uomini; così, per lo stato sociale, il diritto di primogenitura è un costume soltanto interrotto. Un uomo di quarant’anni è stato allevato in queste idee. Venticinque anni non sono nulla quando si tratta di distruggere i costumi di una nazione, e il diritto di primogenitura è ancora un’espressione familiare a tutte le orecchie [...] Col diritto di primogenitura, le fortune restano sempre in piedi nell’ordine sociale. La sola obiezione che si possa muovere alla sua attuazione è che lede gli interessi naturali dei fratelli e delle sorelle minori [...] Col diritto di primogenitura, le grandi famiglie conservano la proprietà territoriale per il bene di tutti; la coltura delle terre resta nelle stesse mani che devono raccoglierne i frutti in ogni specie di situazione politica; lo Stato ha i suoi amministratori, i suoi soldati, le sue garanzie sociali, politiche, i suoi notabilati commerciali fissi; è meno soggetto alle oscillazioni [...] La partizione uguale dei beni fra i figli di uno stesso padre presenta al primo colpo d’occhio un’immagine seducente di equità; siamo lontani dal contestarlo; ma questa partizione non offre che dei vantaggi momentanei; trascina poi con sé le più funeste conseguenze; semina le rivoluzioni.
Queste frasi si trovano in un opuscolo del 1824, Du droit d’aînesse, attribuito con certezza a Honoré de Balzac. Redazione, scopo, contenuti dell’opuscolo appartengono a un complesso, e non del tutto chiarito, momento giovanile dell’attività dello scrittore nel contesto di una precisa vicenda della politica francese; ma le idee su primogenitura, partizione dei beni e rivoluzione sono un buon avvio alla storia di Antonio, un uomo che non sfigurerebbe come personaggio balzacchiano, e del suo comportamento verso il figlio Atanasio. Abbiamo già incontrato due volte Antonio: la prima da ragazzino maltrattato da una madre incapace d’affetto, Anna; la seconda, trent’anni più tardi, nella polemica con uno zio, Lussorio, irritato dai modi con cui il nipote sta tentando di ricostituire un patrimonio e una posizione compromessi dalla catastrofe del rispettivo fratello e padre. Poiché nel corso di tale tentativo Antonio mostrerà spesso anche a noi un volto poco attraente, è giusto cominciare a vederlo sotto un aspetto più simpatico, quello del giovane uomo che si affaccia alla maturità e alla vita familiare.
Antonio
Marito e padre di famiglia
Al momento dell’incidente mortale di suo padre Filippo, nel maggio 1804, Antonio ha ventott’anni; ha studiato, senza laurearsi, filosofia, diritto e medicina; e ha cominciato a curarsi degli affari di casa, cercando – se è vero quello che confiderà più tardi a un corrispondente – di contrastare le dissipazioni e gli errori paterni. Certo, fra 1804 e 1805, di fronte alla prospettiva della rovina, dà subito prova di una forte capacità di reazione. Mentre i creditori incalzano, lo zio Lussorio non presta l’aiuto desiderato, e il fratello minore Carlo, dimostrandosi «senza reflessione», non pensa che a ballare, il giovane capofamiglia prende una decisione realistica e radicale insieme. Rinuncia alla dispendiosa mondanità della vita del patrizio cittadino per ritirarsi nelle proprietà di campagna; e non nella signorile villa di Caprona, ma nella più modesta e lontana casa di Buti, più precisamente: nella casa – un tozzo palazzotto tuttora in piedi – sul poggio che sovrasta la collina di Buti, Castel di Nocco.
È un rifiuto della ‘conversazione’ di tipo diverso da quello di Leonardo, pur sempre rimasto, da buon mercante di tradizione comunale, un uomo di città. Il suo pronipote si trasforma invece in un signore di campagna, con una scelta di ben più forte isolamento. «Queste montagne», o addirittura «queste erme montagne»: è un’espressione che torna spesso sotto la penna di Antonio nei primi tempi del suo volontario e definitivo allontanamento da Pisa. Un’esagerazione che può far oggi sorridere chi conosca l’accogliente bellezza del paesaggio collinare di Buti; ma che va commisurata a strade e trasporti dei primi anni dell’Ottocento, e soprattutto all’impatto psicologico di un cambiamento repentino di stile di vita.
Il trasferimento comporta infatti da parte del giovane anche un distacco non valutabile solo in chilometri dal resto della famiglia e delle altre relazioni, per stabilirsi, come scrive appunto una volta, «in queste erme montagne ove le ristrette mie circostanze isolato da tutti i parenti mi hanno costretto di relegarmi». Il passo è da soppesare in tutta la sua gravità. La madre, il fratello, e presto le sorelle di Antonio affrontano le difficoltà del momento più o meno solidalmente, sistemandosi fra l’altro ad abitare insieme anche dopo il matrimonio di Carlo. Invece Antonio, per giunta tuttora celibe, fa parte per se stesso: sia economicamente, perché in coincidenza col trasferimento di residenza, il 14 aprile 1805, divide l’indebitato patrimonio comune con Carlo, dandogli i beni di Caprona e tenendo, oltre a una rendita a conguaglio, quelli di Buti; sia moralmente, standosene tutto solo a curare i suoi interessi nella casa di Castel di Nocco.
È una scelta coraggiosa, che per un verso presenta un importante elemento di innovazione: la volontà e capacità di pianificare un’esistenza non solo fuori dalla cappa protettiva e limitante insieme del gruppo familiare e della rete parentale, ma anche lontano dalla comunità patrizia cittadina con le sue associazioni e i suoi luoghi deputati. L’aspetto innovativo è stato poi soprattutto corroborato da una successiva e decisiva scelta di Antonio, quella matrimoniale, attuata nel corso dell’estate 1808, a trentadue anni, dopo tre di vita a Buti. Il giovane uomo, che lì ha avuto agio di diventare un accanito epistolografo, ha lasciato nel suo copialettere ampia traccia delle comunicazioni inviatene ai parenti. Possiamo leggere quella del 20 agosto al cugino Adamo Portigiani di Colle di Valdelsa: una buona prova della sopravvivenza e rilievo di una rete familiare in senso lato, ma insieme anche dell’autonomia e perfino della relativa spregiudicatezza con cui si è mosso per una volta Antonio sullo sfondo delle nuove idee e leggi francesi ora estese alla Toscana:
Profitto di tale riscontro per notiziare, prevj i miei saluti, la zia, voi, ed i vostri fratelli, che sono per accasarmi con una signorina delle prime famiglie di questo paese. Soppressa la vecchia nobiltà ereditaria dalle leggi attuali, ed aboliti i fidecommessi, non credo di dover ulteriormente aspettare il modo di aver da mantenere da per me una dama, e ad ogni altro reflesso mi lusingo che vi soddisfarò sufficientemente. Mia madre, il mio zio Gio. Battista, ed altri mi hanno dato il loro consenso; dal zio Lussorio, dalla zia Teresa ho parola, che un tal mio passo non le sarebbe stato di dispiacere, che sempre averei ricevuta la stessa buona accoglienza per me, ed egualmente per la mia sposa. Gli altri parenti che ne ho fatto intesi non mi hanno né contradetto a parole né posto con dei fatti in caso di agir diversamente. Abbiate dunque anche tutti voi altri la compiacenza di non dissentire.
La sposa butese e plebea si chiama Carolina Banti. Porta ad Antonio – come lui stesso scrive più tardi, il 17 febbraio 1809, al cugino Portigiani – «effetti sì, ma non contanti»; gli porta soprattutto, per quanto si potrà capire di quest’altra donna che ha avuto assai poco la penna in mano, un buon carattere e un atteggiamento remissivo. Tutto l’insieme deve aver preparato una situazione coniugale molto differente da quella sperimentata da Antonio fra i propri genitori.
Due bigliettini nel copialettere, di Antonio a Carolina, aprono un piccolo spiraglio su di un quadro di confidenza non priva di affettuosità. Durante il fidanzamento, lui si è assentato per qualche giorno per affari a Livorno – si tratta dell’eredità Pigliù di suo padre –, e di lì può rispondere alla fidanzata, il 12 maggio 1809, con buone scusanti di fronte a una vezzosa accusa di trascuratezza:
Ricevei la cara tua per la posta di Pisa, e vi detti premurosissima risposta jeri colà, conforme si concertò, onde fanne ricerca con ogni caldezza. Avendo sentito dalla procaccina che te non mi avevi scritto, ma soltanto mi mandavi a reverire, dubitai che o te non ti fidassi di carteggiare per di lei mezzo a foglio aperto, o essa non si volesse compromettere, onde sebbene la facessi venir da me, mi limitai a mandarti tanti cari saluti, che mi lusingo avrai ricevuto. Il rimprovero dunque delle occupazioni è un torto per me, che al reflesso di ogni immaginabile riprova di trasporto per te, non mi sarei mai aspettato.
Tre anni più tardi, il 12 marzo 1812, quando Antonio e Carolina sono una giovane coppia di sposi e genitori di una piccola Diamante, capita che sia lui, sempre in occasione di un viaggio a Livorno, a rimproverare alla moglie poca attenzione: «Le scuse che mi adduci di avermi tardato tanto le nuove tue e della bimba, che Dio benedica, ti fanno torto, perché ti danno l’apparenza di più interessata per gli estranei che per me».
Non abbiamo le lettere corrispondenti a queste, ma solo un’altra di Carolina inviata ad Antonio a Livorno sei anni più tardi, il 6 gennaio 1818. In una grafia grossolana e in uno stile un po’ impacciato la donna aggiorna il marito su vari affari, e specialmente su di un’occasione d’acquisto di terra da cogliere al volo: «mi ero dimenticata di dirvi che quello affare del Acconci Giuseppe mi anno detto che prende tutto Pietro del fu Paolo Parenti, voi mi intenderete, ma procurate di non lasciarvela scapare di mano, che è un bocconcino buono: risorvete». Parole da brava e subordinata economa, che per giunta pur firmandosi col nome tratta rispettosamente il marito da «caro consorte» dandogli del voi; ma accompagnate da altre che esprimono con semplicità la consuetudine di un ambiente domestico: «State bene, e cosi è di noi, la bimba Paola chiede sempre il Chicco e il Babbo».
Si tratta, certo, di testimonianze scarne, ma forse sufficienti a confermare il profilo moderno della vita privata di Antonio: moderno nel senso della complessiva adesione al modello affettuoso di matrimonio proposto con immenso successo europeo da Rousseau: il modello di babbo e mamma legati fra loro a doppio filo e tutti casa e famiglia. Del resto è proprio mentre Antonio è cresciuto, verso la fine del Settecento, che tale modello si è affermato presso i ceti dirigenti anche in Italia, con la forza di un costume morale diffuso. In ogni modo, prove meno dirette, ma molto più numerose, dell’attitudine maritale e paterna di Antonio, della sua partecipazione attenta alle grandi e piccole vicende di moglie e figli, si trovano nelle sue lettere ai parenti, che nelle sezioni più intime sono il registro eloquente di un tutto ottocentesco trionfo della domesticità sulla ‘conversazione’.
Solo qualche esempio. Alla sorella Luisa Margherita, 11 giugno 1811: «La cognata e nipote sono ora, la Dio grazie, guarite salvo per questa un poco di scioglimento di ventre, che si attribuisce alla dentizione». Al cugino e compare Portigiani, 22 dicembre 1812: «La vostra comare vuol riprovarsi a sostener la famiglia. Iddio l’ajuti a ben riuscire, intanto grata ai vostri saluti ve li restituisce di cuore. La vostra figlioccia poi qui presente mi stimpana il cervello col chiasso, giudicate da ciò del suo stato, grazie al Signore vivacissimo». Alla sorella Laura Teresa, 13 giugno 1817: «La Diamante seguita a vegetare magretta magretta, ma quasi più impertinente di voi, che non è poco. La Paola è stata felicemente vaccinata». Per finire, il 21 agosto 1817, uno dei resoconti, chi sa con che interesse accolti, indirizzati a un’antica conversatrice, madre distratta, la sua: «La Carolina la reverisce; è tornata, ma non mi pare che abbia molto guadagnato nel Bagno: forse dependerà da un’altra causa non per anche sicura, checché molto probabile, ma il fatto sta che è molto dimagrata. Delle mie bambine la Paola pure è smagrita per il patimento di denti, e la Diamante li scrive da sé sotto però la direzione del maestro, ma in modo che avuto riguardo alla sua tenera età parmi possa ben contentare. Se ne ricordi: gliela raccomando».
Si potrebbero moltiplicare le citazioni. Basti per adesso avvertire che questa diffusa espressione della familiarità domestica accompagna in tutta naturalezza le azioni spesso sostanzialmente prevaricatrici con cui Antonio ha cercato – sarà evidente fra poco – di ricostituire a Castel di Nocco un solido e prospero casato nobiliare. Un motivo di addolcimento, dunque, in una storia di affermazione di ricchezza e potere; ma anche una prova della compatibilità fra un’affettuosità meno riservata che in passato e un perdurante se non crescente comando paternalistico su giovani e donne. Serve ricorrere anche in questo senso al confronto fra la vita coniugale di Antonio e quella dei suoi genitori: si potrà vedere – purtroppo – solo indirettamente la sostanziale emarginazione di Carolina anche da scelte decisive per la famiglia e i figli; si può comunque fin d’ora tranquillamente escludere che ella abbia goduto delle stesse libertà concesse un tempo da giovane sposa a sua suocera.
Rifondatore del casato. Le sorelle
Gli scontri che hanno costellato la lunga opera di Antonio per salvare un considerevole patrimonio e una posizione di privilegio dipendono senza dubbio anche da alcuni tratti sgradevoli della sua personalità; ma questi bisogna intenderli alle prese con la storia, e cioè come frutto non di tendenza generica alla prevaricazione, ma di precisa volontà di riaffermare e mantenere, pur attraverso i grandi cambiamenti della fine dell’Antico Regime, l’autorità e le prerogative del maschio primogenito a capo di un casato. È diventata un’impresa difficile: l’«idolo vano del bene di famiglia» non è più condannato solo dai grandi spiriti come Muratori e Beccaria; e coi Francesi che occupano l’Italia le vecchie leggi a tutela dei patrimoni nobiliari stanno per ricevere uno scossone. C’è dunque molta materia di conflitto.
La prima delle sue guerre Antonio l’ha fatta contro le sorelle. Sono quattro: Amalia, Eleonora, Laura Teresa, Luisa Margherita. Per la verità Eleonora, nata nel 1780, resta fuori dalla mischia; forse perché il suo destino è già stato deciso e preparato dal padre, o piuttosto dal padre e dalla madre, prima dell’incidente del 1804; anche se è solo del 25 giugno 1805 il contratto del suo prestigioso matrimonio con Giacomo Speroni, un patrizio genovese imparentato coi Doria, i quali hanno avuto un loro ruolo nelle trattative. Il pagamento della cospicua dote – oltre 3.600 scudi – tocca ad Antonio e a Carlo come figli maschi ed eredi del pur indebitato patrimonio; e se Carlo ha mostrato addirittura, a giudizio del fratello, «un puntiglio radicato nella collocazione di questa sorella», Antonio stesso si trova nella condizione di dover fare con ragionevole rapidità la sua parte: versa più della metà della sua quota all’atto del contratto, e il resto il 14 luglio 1806, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio in chiesa, dopo essersi fatto nel frattempo appena un poco pregare per saldare anche gli interessi. L’impressione è che questa di Eleonora, non la maggiore delle sorelle e dunque forse la più attraente, sia stata una sistemazione preordinata in una pianificazione familiare, cui Carlo, il maschio minore di «testa mediocrissima» ma «cuore ottimo» – secondo un più volte ribadito giudizio del fratello – e rimasto a Pisa con la madre, si è prestato con zelo, ma che comunque anche Antonio dal suo ritiro di Castel di Nocco non ha potuto neppure provare a ostacolare.
Con le altre sorelle, non altrettanto favorevolmente predestinate, le cose vanno in maniera assai diversa. Il primo tentativo del loro domestico e familista fratello maggiore è infatti di chiuderle in monastero, come se nel 1804, sotto il Regno d’Etruria, e poi addirittura, di lì a poco, sotto il diretto dominio di quei Francesi che hanno – Antonio lo sa bene – «soppressa la vecchia nobiltà ereditaria» e «aboliti i fidecommessi», sia possibile continuare tranquillamente ad angariare le femmine e i cadetti. Di fatto, il colpo gli riesce solo con la povera Laura Teresa, che in monastero c’è già, e per un tristissimo motivo, che impariamo per caso solo molti anni più tardi...