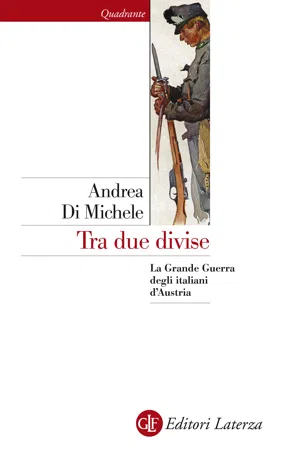
eBook - ePub
Tra due divise
La Grande Guerra degli italiani d'Austria
Andrea Di Michele
This is a test
Share book
- 256 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Tra due divise
La Grande Guerra degli italiani d'Austria
Andrea Di Michele
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Furono oltre centomila i sudditi dell'Impero asburgico appartenenti alla minoranza italiana che durante la Grande Guerra combatterono 'dall'altra parte'. Parlavano la lingua del nemico e per questo furono considerati inaffidabili e sospetti. Inviati soprattutto sul lontano fronte russo, in migliaia caddero prigionieri. Contesi tra Austria e Italia, da entrambi i paesi vennero visti con diffidenza e nei campi di prigionia russi subirono pressioni contrastanti e tentativi di rieducazione nazionale. Il libro ricostruisce i loro trascorsi avventurosi, vissuti in lunghi anni passati tra guerra, prigionia e complicati ritorni, e restituisce un capitolo importante della complessa questione dei nazionalismi novecenteschi.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Tra due divise an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Tra due divise by Andrea Di Michele in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & 21st Century History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
III.
In Russia, tra Austria e Italia
1. Prigionia e politica delle nazionalità
La prigionia è stata un’esperienza caratterizzante la Grande Guerra. Un fenomeno europeo, che interessò tutti gli eserciti e i paesi in guerra e che per la prima volta nella storia assunse caratteri di massa. Circa 8,5 milioni di uomini, quasi un settimo di tutti i soldati mobilitati, vissero la cattura e l’internamento, che per molti durò ben oltre la fine del conflitto. Un numero gigantesco, di poco inferiore ai 9-10 milioni di soldati morti durante il conflitto1. Le condizioni di vita in prigionia furono le più diverse, spesso contrassegnate da forti privazioni e da maltrattamenti, da una fame disperata e dall’assenza di vestiti e medicinali, da epidemie di tifo e altre malattie infettive capaci di falcidiare in tempi rapidissimi le sovraffollate popolazioni dei campi. Un’esperienza dura, molte volte drammatica, segnata da un doppio esilio, che vedeva i prigionieri distanti dal proprio paese ma anche allontanati dalla comunità di guerra alla quale, nonostante tutto, continuavano ad appartenere, divenendo spesso vittime di rappresaglie da parte del paese che li teneva in custodia2. A tutto ciò si aggiungeva un sentimento di vergogna e umiliazione, unito alla sensazione di essere stati dimenticati in patria.
Nonostante l’importanza del fenomeno, il tema della prigionia durante la prima guerra mondiale ha sofferto a lungo di un’evidente marginalizzazione, nella memoria come nella storiografia3. A guerra finita gli ex prigionieri non avevano nulla di eroico da raccontare. Anche qualora avessero militato dalla parte dei vincitori, la loro personale vicenda appariva sotto il segno della sconfitta. Spesso fecero ritorno anni dopo la fine della guerra, tornando in realtà profondamente mutate, magari nelle vesti di cittadini dei nuovi Stati nati dal disfacimento dei grandi imperi multietnici. Spaesati e disillusi, raramente trovarono la riconoscente accoglienza che si attendevano. Assai più spesso percepirono il distaccato fastidio di chi voleva lasciarsi definitivamente alle spalle il ricordo della guerra e che controvoglia veniva catapultato all’indietro da questi tardivi ritorni. Nei decenni successivi la memoria pubblica diede ampio spazio all’esaltazione dei caduti, non certo al riconoscimento delle sofferenze di chi aveva vissuto lontano dal fronte e che da molti veniva visto come una sorta di imboscato o traditore. Il marchio del vile o del possibile disertore si era impresso all’immagine del prigioniero già durante la guerra. I prigionieri italiani in Austria e Germania non avevano ricevuto alcun sostegno dalle autorità militari e politiche di Roma, che si erano rifiutate di inviare loro gli aiuti alimentari necessari per sopperire alle disastrose condizioni economiche degli Imperi centrali. Era un modo per punire chi, forse volontariamente, si era sottratto al fronte, ma soprattutto per scoraggiare future diserzioni, per mostrare ai combattenti che l’alternativa al sacrificio in battaglia era la morte per stenti in un campo di prigionia4. Una condotta indicativa del sospetto e dell’indifferenza con cui si guardava alle vicende dei prigionieri.
Per certi aspetti il fenomeno della prigionia di guerra racchiude in sé i tanti elementi della guerra totale. Lungi dall’esaurirsi nell’esperienza individuale degli uomini che la vissero sulla propria pelle, la prigionia acquisì rilevanti significati di carattere militare, economico, sociale, di sicurezza interna, di politica estera e delle nazionalità5. Per i paesi in lotta, primo tra tutti l’Austria-Ungheria, la cattura di propri soldati assunse dimensioni tali da rappresentare un serio problema di ordine militare. Quasi un terzo di tutti gli uomini mobilitati dall’Impero cadde in mani nemiche, per un totale di circa 2,77 milioni di soldati6. Soltanto la Russia soffrì un numero maggiore di prigionieri (3,4 milioni), ma che, dato l’enorme numero di uomini di cui disponeva, pesò «solo» per un quinto sul totale dei richiamati. In condizioni contrassegnate ovunque dalla drammatica carenza di uomini, i prigionieri vennero presto considerati come un prezioso bacino di manodopera da utilizzarsi in ogni settore dell’economia. Rappresentarono allo stesso tempo una sfida organizzativa e gestionale del tutto imprevista, che trovò impreparati i governi di entrambe le coalizioni, costretti a dar vita a un’estesa rete di campi in cui assicurare ai prigionieri il trattamento previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1907 sui diritti umanitari in tempo di guerra, alla quale avevano aderito pressoché tutti i paesi coinvolti nel conflitto.
Al sistema di mantenimento dei prigionieri si accompagnò una non meno impegnativa organizzazione di controllo e isolamento che li separasse dalla popolazione civile. Sul piano internazionale i prigionieri divennero ostaggi in mano nemica, utilizzati come arma di pressione e di ricatto. Spesso, quando una nazione riteneva inadeguato il trattamento dei propri soldati presi dal nemico, reagiva rivalendosi sui prigionieri di quel paese, dando avvio a un’escalation di rappresaglie e controrappresaglie che conduceva a un drammatico peggioramento delle condizioni di vita di tutti i prigionieri coinvolti. Un caso limite è quello dei prigionieri tedeschi e austro-ungarici utilizzati in gran numero dai russi nei lavori di costruzione della strategica linea ferroviaria in Murmania, che seguendo un percorso di 1.400 chilometri avrebbe collegato la regione di Pietrogrado al porto di Murmansk sull’Oceano Artico. In condizioni ambientali e di lavoro proibitive morirono 25.000 prigionieri, mentre il 70% dei 45.000 sopravvissuti contrasse gravi malattie. Anche alcune decine di italofoni trascorsero parte della propria prigionia adibiti ai lavori forzati in Murmania, lasciandoci di quell’esperienza descrizioni drammatiche7. La Germania reagì alle prime notizie riportate da testimoni oculari con dure rappresaglie sui prigionieri russi, innescando un botta e risposta che venne fermato grazie alla mediazione della Croce rossa svedese e danese8.
Ma ancor più significativo è il ruolo assegnato ai prigionieri quale strumento della politica delle nazionalità. Tutti i paesi in guerra cercarono di sfruttare a proprio vantaggio le tensioni interne al nemico, specie quelle determinate dalla presenza di diverse nazionalità, in primo luogo nei tre grandi imperi che si fronteggiavano ad est. La Russia fu particolarmente tempestiva nell’utilizzo dell’arma delle nazionalità per incrinare la solidità del nemico asburgico. Già nel luglio 1914, prima ancora che la Russia fosse coinvolta nella guerra, il ministro degli Esteri Sazonov fece predisporre un manifesto ai polacchi che prometteva l’unificazione di tutte le loro terre (comprese quelle in mano tedesca e austro-ungarica) all’interno dell’Impero zarista, con la contestuale concessione di un’ampia autonomia amministrativa. Pochi giorni dopo seguì un’analoga iniziativa che si rivolgeva ai ruteni dell’Austria-Ungheria e in settembre venne diffuso un manifesto in nove lingue e in 100.000 copie indirizzato a tutti i «Popoli dell’Austria-Ungheria». L’iniziativa coincideva con la vigorosa avanzata in territorio austriaco delle truppe zariste e invitava le popolazioni abitanti l’Impero asburgico ad accogliere con amicizia le truppe della Russia, la quale combatteva «perché le nazioni siano emancipate dal giogo straniero»9. Il manifesto si rivolgeva all’intera popolazione asburgica, con un occhio di riguardo per i soldati al fronte, invitati a guardare il nemico con occhio diverso. Qualora fatti prigionieri, i soldati di origine slava sapevano di poter godere di un trattamento più favorevole da parte delle autorità russe, che in seguito avrebbero promosso il loro reclutamento in formazioni militari volontarie da impiegare contro il nemico. Suddividere i prigionieri in base alla lingua e differenziarne il trattamento non era una prassi esclusiva dei russi. Qualcosa di simile fecero gli austriaci con ruteni e polacchi dell’esercito russo, anch’essi separati dagli altri prigionieri e destinatari di particolari attenzioni volte a influenzarli politicamente. I tedeschi agirono analogamente con i ruteni, ma anche con i musulmani degli eserciti francese e britannico, con i fiamminghi e soprattutto con i prigionieri russi di lingua tedesca10.
Le finalità di tali politiche erano chiare: esasperare le tensioni nazionali di cui il nemico soffriva sia sul fronte interno che nelle forze combattenti e invitare i soldati delle minoranze alla diserzione. Le vicende degli italiani d’Austria prigionieri in Russia rientrano perfettamente in queste dinamiche. Sul fronte orientale, dove furono catturati circa i due terzi di tutti i prigionieri della prima guerra mondiale, una massa consistente di uomini cadde in mani nemiche già nelle prime settimane di guerra, quando si ebbero le iniziali grandi avanzate seguite da altrettanto repentine ritirate. Durante tali azioni, centinaia di migliaia di uomini videro concludersi immediatamente la propria esperienza di combattenti e iniziare quella di reclusi. Per costoro la guerra al fronte non durò che qualche settimana, la prigionia diversi anni. Tra questi vi erano molti italiani d’Austria, anch’essi destinati a divenire oggetto della politica zar...