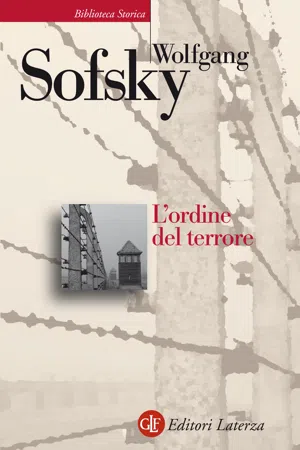
eBook - ePub
L'ordine del terrore
Il campo di concentramento
Wolfgang Sofsky, Nicola Antonacci, Francesco Saverio Nisio
This is a test
Share book
- 480 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
L'ordine del terrore
Il campo di concentramento
Wolfgang Sofsky, Nicola Antonacci, Francesco Saverio Nisio
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Wolfgang Sofsky riesce nell'impossibile: dare una spiegazione razionale dei campi di concentramento senza perdere di vista la sofferenza umana che l'uso del terrore implica.
La sua analisi sociologica della brutalità organizzata aggiunge un elemento importante alla nostra comprensione del potere totalitario. Sofsky espone il potenziale di immortalità che la modernità porta con sé, e che può portare l'?ordine' a trasformarsi in terrore.Ralf Dahrendorf
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is L'ordine del terrore an online PDF/ePUB?
Yes, you can access L'ordine del terrore by Wolfgang Sofsky, Nicola Antonacci, Francesco Saverio Nisio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Sciences sociales & Sociologie. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
Sciences socialesSubtopic
Sociologie1.
Prologo
I primi prigionieri entrano a Dachau il 22 marzo 19331. Il luogo, una fabbrica abbandonata di polvere da sparo, ha un aspetto sconfortante. Nell’area dell’impianto ci sono più di una ventina di costruzioni basse in muratura, e solo l’edificio una volta destinato all’amministrazione sembra ancora utilizzabile. Nei giorni appena precedenti, il complesso è stato cinto da un triplo reticolato di filo spinato. Nell’interrato i funzionari di polizia entrati in servizio la sera prima registrano in un elenco i nomi dei prigionieri, che non indossano ancora un’uniforme vera e propria. Tutto procede in ordine, senza urla e maltrattamenti. A nessuno viene in mente di tagliare i capelli ai nuovi arrivati. La sera viene distribuito il primo pasto: tè, pane e un salsicciotto di fegato a testa; nella concitazione della giornata non si è potuto trovare di più. Dopo cena si va nel dormitorio, al primo piano. Poiché mancano brande e pagliericci, i prigionieri sono costretti a coricarsi sul pavimento di cemento. A poco servono, contro il freddo, le coperte in dotazione alla polizia che ognuno ha ricevuto.
Il giorno seguente i detenuti cercano materiali da costruzione negli edifici vuoti e nei padiglioni della fabbrica. I primi letti vengono ricavati da assi di legno abbandonate qua e là. Un falegname ottiene il permesso di impiantare un laboratorio. Ognuno cerca di far da sé, nessuno viene costretto a lavorare se non ne ha voglia. Tuttavia mancano attrezzi e strumenti, e manca anche il filo spinato per recintare l’area. Le zappe e le vanghe che si accumulano col passare dei giorni vengono custodite in un magazzino amministrato insieme da un prigioniero e da un impiegato. La sorveglianza è corretta. Guardie e detenuti parlano gli uni con gli altri, commentano addirittura la situazione politica. Qualcuno riesce ad ottenere di nascosto delle sigarette, il vitto è buono e abbondante, i prigionieri mangiano le stesse cose degli addetti alla sorveglianza.
Questa situazione dura solo pochi giorni. Una notte i detenuti vengono svegliati di soprassalto dal rumore di armi e passi di marcia. Davanti all’edificio dell’amministrazione si è schierato un plotone di SS in camicia bruna e berretto nero. Il loro comandante pronuncia un discorso che suscita angoscia fra i prigionieri:
Camerati delle SS! Voi tutti sapete a cosa ci ha chiamati il Führer. Non siamo venuti qui per essere gentili con quei porci chiusi là dentro. Non sono uomini come noi, ma esseri inferiori. Per anni hanno potuto mettere in pratica i loro istinti criminali, ma adesso comandiamo noi. Se questi porci fossero arrivati al potere, ci avrebbero tagliato la testa a tutti. Perciò non ci sarà posto per i sentimentalismi. Se a qualcuno dei camerati qui presenti il sangue fa impressione, vuol dire che non è adatto al servizio e che se ne deve andare. Più maiali come questi abbatteremo con le nostre armi, meno ne avremo da sfamare!2
Dodici anni dopo, il pomeriggio del 29 aprile 1945, tre jeep della 42 a divisione «Rainbow» giungono nell’area del lager passando attraverso la porta sud. Per aprire il cancello un soldato deve prima scostare il cadavere di un prigioniero ucciso a fucilate. Dalle torrette di guardia crepitano le mitragliatrici. Nella zona settentrionale i liberatori combattono contro le ultime SS, e tuttavia l’ampia spianata dove si faceva l’appello dei prigionieri è vuota, al pari della strada principale. Fra i soldati c’è una donna, Marguerite Higgins, che scriverà un reportage sul «New York Herald Tribune»:
Eravamo appena entrati, e subito noi due fummo investiti da una sorta di fuoco di sbarramento di invocazioni provenienti dalle baracche distanti da lì 200 metri. Ci chiesero in quasi sedici lingue se fossimo americani. Quando facemmo segno di sì, si scatenò un pandemonio. Una massa di uomini vestiti di stracci e ridotti pelle e ossa si accalcò davanti al cancello. Chi piangeva, chi urlava, chi gridava «viva l’America!». Quelli che non potevano camminare si trascinavano per terra o zoppicavano [...] Accadde che fui la prima ad attraversare l’ingresso. La prima persona che mi si fece incontro era un sacerdote polacco, vicario dell’arcivescovo di Polonia, il cardinale August Hlond. Egli non si scompose minimamente quando scoprì che la persona in uniforme, elmetto d’acciaio e occhiali protettivi che lo abbracciò con così tanto calore non era un uomo, ma una donna. Nell’eccitazione del momento, per nulla attenuata dal tuono dell’artiglieria tedesca e dagli echi della battaglia che si stava svolgendo nella parte settentrionale del campo, non pochi prigionieri morirono tentando di scavalcare la recinzione elettrificata. Dopo che fu tolta la corrente alcuni riuscirono a passare per prendere parte ai combattimenti, ma divennero bersaglio del fuoco di un gruppetto scellerato di SS appostate su una torretta di guardia. I prigionieri allora assalirono la postazione, e poco dopo si videro cadere dalla torretta sei soldati tedeschi. Solo dopo un’ora e mezza di festeggiamenti, durante i quali i militari americani che avevano osato mischiarsi ai prigionieri erano stati quasi soffocati dalla calca, la folla si calmò e noi potemmo entrare nel lager [...]
Le baracche di Dachau erano impregnate dell’odore della morte e della malattia. In sei di esse erano coricati letteralmente l’uno sull’altro moribondi e malati d’inedia: 1.200 persone in spazi che ne potevano contenere 200. I morti – ieri sono deceduti 300 malati – giacevano sui camminamenti asfaltati all’esterno delle baracche, e altri ne venivano portati fuori proprio mentre stavano entrando i giornalisti. Sui cadaveri macilenti si potevano leggere i segni dell’inedia, e molti sopravvissuti erano troppo deboli perché si potesse sperare in una loro guarigione. I forni crematori e le camere di tortura si trovavano fuori dall’area destinata ai detenuti. In un bosco vicino, i reclusi, sotto la sorveglianza delle SS, avevano costruito un nuovo edificio, al cui interno, nelle due stanze usate per la tortura, erano accatastati circa 1.200 corpi senza vita.
Nel crematorio c’erano i ganci ai quali le SS appendevano le loro vittime per picchiarle o torturarle in altro modo. Sul carattere delle SS la diceva lunga un affresco dipinto sul muro dagli stessi aguzzini. In esso era ritratto un uomo senza testa, vestito con l’uniforme delle SS e con il loro stemma sul colletto. L’uomo sedeva a cavalcioni su un maiale dal corpo smisuratamente rigonfio, martoriandogli i fianchi con gli speroni [...] Ancora più discosti dal lager c’erano dei carri bestiame sui quali i deportati venivano trasferiti da Buchenwald a Dachau. Nei vagoni c’erano altre centinaia di cadaveri che i prigionieri del lager si erano rifiutati di portar via, disobbedendo agli ordini delle SS. Le persone fatte fucilare dai capi delle SS prima della loro fuga provenivano soprattutto da questi vagoni. In uno di essi fu trovato un uomo ancora vivo, che era riuscito con le proprie forze a farsi largo nel mucchio di cadaveri nel quale giaceva3.
A Dachau le forze di liberazione trovarono 32.000 prigionieri, di cui un terzo polacchi, diverse migliaia di russi, francesi, jugoslavi e italiani, un migliaio scarso di tedeschi, e altri ancora di 34 nazionalità diverse. Nelle loro sbrindellate casacche a righe, i sopravvissuti sembravano esseri provenienti da un altro mondo. I decessi continuarono anche dopo l’arrivo dei liberatori: nei trenta giorni successivi morirono per sfinimento e tifo petecchiale altri 2.226 prigionieri. I civili che saccheggiarono il vicino magazzino delle SS vedevano sfilare la macabra teoria senza farci caso. I bambini passavano con le biciclette davanti ai cadaveri. Sul manubrio erano appesi vestiti raccattati chissà dove.
Ciò che era cominciato come misura di terrore contro i nemici politici si concluse con la morte di milioni di persone. All’inizio c’era stata la sete di vendetta di un regime che, appena arrivato al potere, volle schiacciare tutti coloro che gli si erano opposti. Poi, però, una volta messi definitivamente a tacere tutti gli avversari, si scatenò una forma di potere assoluto che superò tutte le esperienze precedenti di arbitrio dispotico e sopruso dittatoriale: la distruzione sistematica per mezzo della violenza, della fame e del lavoro, l’annientamento dell’uomo condotto con freddo spirito contabile. Nello spazio di dodici anni il campo di concentramento si trasformò da luogo di terrore in universo di bestialità.
Alcuni sopravvissuti hanno raccontato la loro esperienza subito dopo la liberazione, altri soltanto a distanza di decenni. Le autorità incaricate di fare giustizia hanno raccolto una vasta messe di documenti e testimonianze oculari. Tuttavia i processi celebrati sono stati pochi e tardivi, e alcune sentenze pronunciate con notevole indulgenza, spia anche della riluttanza delle corti ad applicare le norme giuridiche ordinarie a una situazione così eccezionale. Pedagoghi incaricati ufficialmente di provvedere al «superamento del passato» hanno cercato faticosamente di creare nelle nuove generazioni una sorta di consapevolezza storica, presentando lo sterminio di massa come una lezione dalla quale i posteri potranno imparare qualcosa. La storia contemporanea come disciplina ha ricostruito le fasi e i contesti entro cui si è sviluppato il sistema dei lager, e ha documentato la vicenda di alcuni campi. Da qualche anno storici locali della generazione più giovane stanno passando al setaccio gli archivi periferici, raccogliendo le testimonianze di quanti hanno visto e facendo emergere le tracce dei molti lager ancora oggi sconosciuti, ma assai familiari, anche per la loro vicinanza fisica, a molti tedeschi di allora. Tuttavia l’acquisizione di nuove conoscenze non si è tradotta in una maggiore intelligenza del fenomeno: la realtà dei campi di sterminio sembra travalicare qualsiasi capacità di comprensione. Da sempre, poi, essa genera svariati meccanismi di difesa che liberano la coscienza e cancellano il ricordo.
È noto che gli individui non scelgono consapevolmente le loro strategie di difesa. Gli atteggiamenti possibili di fronte alla tragedia dei lager vanno dalla semplice negazione dei fatti al paragone minimizzante con altre esperienze, per giungere fino a tecniche intellettualmente più raffinate di interpretazione e razionalizzazione. Lo sforzo difensivo è in questi casi notevole, e spesso è difficile sbrogliare l’intreccio delle diverse strategie. C’è chi continua ad affermare con candore che i campi di sterminio non sono mai esistiti, e chi invece concorda con quel «revisionismo spicciolo» che mette sullo stesso piano Auschwitz e Dresda, Dachau e Katyn o i «campi speciali» allestiti dalle forze di occupazione sovietiche, lo sterminio di massa nazista e le nefandezze perpetrate in occasione dell’esodo forzato dei tedeschi, innescando l’osceno gioco di numeri di una falsa aritmetica e illudendosi di chiudere in pareggio i conti del passato. Altri affermano recisamente di essere rimasti all’oscuro di ogni cosa, anche se sappiamo che il nazismo usò in modo consapevole i campi di concentramento per intimorire tutta la popolazione. Molti, di fronte alla sparizione improvvisa del vicino di casa, avevano plaudito freneticamente al regime ed erano restati a guardare, e la gente contemplava a bocca aperta le colonne di prigionieri che attraversavano i paesi, indifferente, spaventata, forse spudoratamente soddisfatta. In queso caso la negazione è duplice, perché si dice di non sapere ciò che già allora si diceva di non sapere.
Se questi metodi di difesa falliscono, si può provare con delle strategie di rimozione incentrate sul linguaggio. I tedeschi, ma non solo loro, per drammatizzare maggiormente il concetto di «sterminio di massa» hanno fatto proprio con entusiasmo il titolo di uno sceneggiato televisivo. Così facendo, la parola «olocausto» si è ridotta a una semplice etichetta che rende possibile un rapido accordo ed esenta dall’analisi dei fatti. Nel linguaggio dei salmisti, però, olocausto significa «sacrificio totale per mezzo del fuoco»4, indicando il martirio rituale a cui gli ebrei si sottoponevano nel momento in cui rifiutavano di abiurare la loro fede. Così si crea un collegamento del tutto pretestuoso fra lo sterminio di massa e il destino dei martiri ebraici, facendo passare sotto silenzio il fatto che sotto il nazismo gli ebrei non furono uccisi per la fedeltà alla loro religione, ma per il semplice fatto di essere ebrei. Questa deformazione semantica suggerisce l’idea che lo sterminio di massa nasconda un più profondo significato religioso, come se in certa misura le vittime si siano sacrificate di propria volontà.
Ecco un altro esempio di operazione linguistica al servizio della rimozione del passato: gli innumerevoli lager presenti sul suolo tedesco e i distaccamenti dei campi-madre di cui era punteggiata la geografia dell’Europa centrale sono diventati all’improvviso semplici «campi di lavoro» o «stazioni esterne». Questi campi di concentramento erano situati nelle immediate vicinanze di strade di scorrimento dirette fuori città, in boschi comunali, in edifici scolastici sgomberati o in aree appartenenti a ditte private. Dopo che gli storici locali, nonostante la scarsezza dei mezzi a loro disposizione, hanno scoperto alcuni di questi lager dimenticati, zelanti consiglieri comunali hanno rassicurato la comunità che la faccenda non era poi stata così grave, sottolineando con puntiglio l’incontestabile differenza fra questi innocui campi di lavoro e i campi di sterminio dell’Europa orientale. Il termine «campi di lavoro» fa però dimenticare il fatto che spesso il lavoro conduceva alla morte, che i prigionieri sfruttati fino all’esaurimento venivano scartati e rispediti ai campi di provenienza o in un campo di sterminio, e che le camere a gas esistevano anche in Germania. L’effetto di simili argomentazioni è, dunque, quello di espungere il crimine dalla sfera dell’esperienza diretta e di confinarlo in una dimensione geografica extra-territoriale.
L’altra faccia di questa politica linguistica viene alla luce quando il discorso comune si alla...