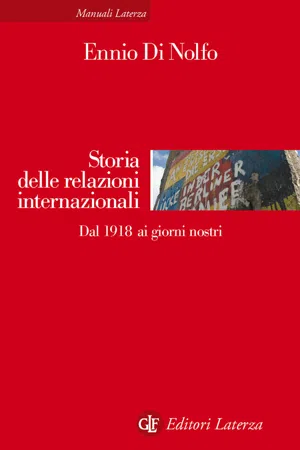Capitolo undicesimo. Il sistema internazionale dopo il 1956
1. La definizione delle regole della coesistenza competitiva
1.1. Considerazioni introduttive. È opinione dell’autore di queste pagine che compito dello storico sia di ricostruire, secondo un percorso logicamente compatibile con quanto le fonti suggeriscono, la trama del passato, indicando i momenti in cui il susseguirsi degli eventi acquista un ritmo più o meno celere e individuando le fasi nelle quali i diversi percorsi della storia si intrecciano in nodi problematici, rispetto ai quali è necessario elaborare un’esposizione che consenta di percepire ordinatamente il sovrapporsi delle linee di tendenza, la diversa importanza delle forze in gioco, le soluzioni progettate rispetto ai problemi esistenti, i risultati conseguiti dagli attori del processo politico. Così come gli anni fra il 1946 e il 1949 segnarono la nascita dei due blocchi che, imperniati sugli Stati Uniti e sull’Unione Sovietica, avrebbero vissuto i momenti più aspri della guerra fredda, gli anni fra il 1957 e il 1963 (intesi con una certa elasticità di confini cronologici) segnarono il passaggio dalla fase di conflitto acuto alla fase di mutuo riconoscimento delle posizioni acquisite e al tentativo di definire regole che rendessero possibile non già azioni convergenti ma almeno la percezione dei limiti entro i quali ciascuna delle superpotenze riconosceva all’altra una sorta di potestà ordinativa dominante rispetto alle diversità o ai conflitti interni ai blocchi rispettivi. Non si poteva certo parlare ancora di «distensione» nel senso che il termine acquistò qualche tempo dopo ma si può ora capire che proprio in quegli anni, che qualcuno definì dell’equilibrio del terrore, i capi delle superpotenze percepirono a fondo l’opportunità di definire in modo parallelo i confini dei propri interessi, le aspettative riguardo all’antagonista, l’attesa di comportamenti coerenti con il rispetto dei valori critici dell’avversario: in altri termini, gli elementi di un avvicinamento parallelo alla definizione delle regole di coesistenza di un sistema bipolare competitivo. L’apparente semplicità della dissezione bipolare consente un’organizzazione e un’analisi semplificata delle situazioni complesse. Non sempre ciò è esauriente e non sempre la semplificazione raccoglie la varietà degli elementi che confluiscono in una transizione. Questa infatti riguarda sia i temi delle relazioni dirette fra le superpotenze sia i temi correlati ai rapporti fra ciascuna di esse e i rispettivi satelliti, sino a indicare i limiti entro i quali le potenze minori potevano disporre di «influenza» all’interno del proprio blocco o, addirittura, condizionare i comportamenti della potenza guida; e sino a indicare le esigenze supreme rispetto alle quali le motivazioni nazionali minori dovevano accettare di subordinarsi. Le superpotenze vivevano un conflitto che non aveva più come posta in gioco la divisione dell’Europa o di parti dell’Asia in zone d’influenza. Questo processo era terminato nel 1956 e l’immobilità occidentale rispetto alla crisi ungherese del 1956 così come quella sovietica rispetto alla crisi di Suez dello stesso anno avevano mostrato la coerenza con la quale gli antagonisti seguivano regole non scritte. Dopo il 1956 il conflitto o, meglio, la competizione, aveva mutato natura: riguardava i paesi di recente indipendenza e la globalizzazione del bipolarismo; riguardava la contesa missilistica e spaziale, cioè la capacità di colpire direttamente l’avversario con armamenti propri; riguardava soprattutto la competizione nucleare, dalla quale dipendeva la capacità di minacciare l’avversario in modo variamente credibile ma così indeterminato (almeno sino al 1963) da diffondere l’impressione che l’ecatombe nucleare potesse improvvisamente esplodere, provocando danni incalcolabili. I responsabili di entrambe le superpotenze erano proiettati verso la conquista della supremazia nucleare ma sapevano, al tempo stesso, che questa sarebbe stata prevalentemente un armamento simbolico, poiché le distruzioni provocate da un conflitto nucleare non avrebbero mai retto a una pur superficiale analisi del rapporto costi/benefici. La posta in gioco era ed è chiaramente percettibile. Tuttavia questo aspetto del nodo problematico non esaurisce l’intreccio delle questioni. Infatti ciascuna delle superpotenze doveva affrontare motivi di disagio all’interno del proprio sistema senza lasciare, ma non sempre con successo, che questi compromettessero la loro capacità d’azione globale. La situazione degli Stati Uniti era complicata ma non drammatica. Essi dovevano rielaborare le proprie relazioni con l’Europa occidentale dopo che questa, fra il 1955 e il 1957, aveva dato vita al Mercato comune europeo. Dovevano anche affrontare i problemi derivanti dalla frattura verificatasi nel 1956 a Suez, il che poneva in campo le diverse concezioni del rapporto con il mondo coloniale: un fatto, questo, che la politica di decolonizzazione britannica avrebbe reso meno traumatico ma al quale la guerra d’Algeria dava un’importanza cruciale. L’ascesa al potere in Francia di de Gaulle, sebbene provocasse un temporaneo aggravamento dell’aspetto coloniale della tensione interna all’Alleanza atlantica, avrebbe posto agli Stati Uniti problemi di fondo ben più importanti, collegati ai progetti globali del Presidente francese e, più ancora, al suo intento di costruire davvero una forza nucleare autonoma, magari d’intesa con l’Italia e, più ancora, con la Repubblica federale di Germania. La questione tedesca riacquistava così una valenza centrale nella politica europea degli Stati Uniti, poiché la linea politica del cancelliere Adenauer, costruita sull’impegno atlantico ma anche fortemente critica verso l’egemonismo americano in Europa e orientata verso una stretta collaborazione con la Francia di de Gaulle, indicava scenari inquietanti che, da parte americana, dovevano essere integrati in una visione globale. Le ipotesi di accordo nucleare franco-tedesche si proiettavano infatti sul piano della strategia dei rapporti con l’Unione Sovietica e non potevano essere considerate come semplici turbolenze interne al blocco occidentale. Dal suo canto, l’Unione Sovietica doveva comporre esigenze ben più divergenti. In primo luogo i suoi dirigenti dovevano affrontare l’eco duratura della destalinizzazione e, più ancora, la spinta di Ulbricht, il leader della Repubblica democratica tedesca, a esigere una risposta sovietica molto meno morbida di quanto apparisse rispetto ai progetti nucleari di Adenauer e rispetto al problema dei rapporti intertedeschi, reso drammatico dal persistere del flusso di emigrazioni clandestine dalla Germania orientale verso quella occidentale. Ma per i Sovietici le difficoltà maggiori venivano dalla situazione asiatica dove il deterioramento dei rapporti con la Repubblica popolare cinese, già manifesto nel 1957-58, provocava un ridimensionamento dell’influenza sovietica che avrebbe di lì a poco aperto spazi importanti alla penetrazione americana, delimitando la portata degli sviluppi che nei primi anni Sessanta si profilarono nel Viet Nam. Infine l’ascesa al potere nell’America centrale di Fidel Castro a Cuba, se da un lato offriva ai Sovietici nuove possibilità di pressione sugli Stati Uniti dall’altro li esponeva a una verifica dei limiti entro i quali tale pressione avrebbe potuto essere esercitata. In tal senso, l’arco di tempo che va dal 1957, con il clamoroso esordio della gara spaziale, al 1958 con la seconda crisi di Berlino, al 1959-60, con i primi tentativi di dialogo diretto fra Sovietici e Americani, al 1960 ancora, come anno critico per il processo di decolonizzazione, al 1961, anno della costruzione del muro di Berlino, al 1962, anno della crisi di Cuba e al 1963, anno conclusivo della catena ininterrotta di esperimenti nucleari e della stipulazione del Trattato per la sospensione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, tutto questo arco di tempo, con i temi qui solo enunciati e molti altri che li accompagnarono, può davvero essere considerato come il periodo nel quale le due superpotenze, razionalizzando le situazioni interne alle rispettive zone d’influenza, si impegnarono nei fatti o mediante negoziati specifici a individuare le regole di convivenza in un sistema bipolare dominato dalla competizione ma impegnato a liberarsi dal complesso dell’inevitabilità dell’ecatombe nucleare.
1.2. I contenuti della «coesistenza competitiva». La lunga disamina dedicata, nel capitolo precedente, ai problemi della decolonizzazione, pur nella varietà dei casi e delle situazioni, non è esauriente per se stessa e tuttavia deve trovar posto in una ricostruzione storica dei mutamenti di fondo della situazione internazionale. Dal punto di vista che in generale ispira questa ricostruzione, un’esposizione sufficientemente ampia delle azioni che alterarono in profondità il quadro internazionale entro il quale si situava il conflitto bipolare, questa disamina è indispensabile proprio per cogliere uno degli aspetti della svolta che viene ora esaminata. Le superpotenze (e tutti gli altri soggetti del sistema internazionale) dovettero incominciare a guardare al sistema internazionale come a un insieme costituito da un numero di attori più che raddoppiato (e pochi anni dopo il 1960, più che triplicato) rispetto a quello prima esistente.
Di per sé questa trasformazione, pur così rilevante, non avrebbe forse avuto la portata che essa acquistò nel modificare le relazioni internazionali se tutti (o quasi) i paesi di recente indipendenza non avessero presentato una caratteristica e un problema comuni: la caratteristica di essere paesi economicamente arretrati e il problema di far coincidere, concretizzandola, l’indipendenza con l’inizio di una fase di crescita economica. Questa, riscattando i popoli subalterni dalla schiavitù dell’imperialismo, doveva mettere le nuove forze politiche, che in ciascun territorio si erano assunte (o avevano ricevuto mediante libere elezioni) il compito di governare, in grado di dimostrare che la fine del colonialismo aveva portato alla fine della subordinazione politica e dello sfruttamento economico e all’inizio di un’età nuova, di crescita e benessere. La decolonizzazione perciò modificava in più modi i termini della situazione, modi che non possono essere esaminati interamente in questa sede ma che si proiettavano inevitabilmente sul piano internazionale. Infatti l’aprirsi di un nuovo palcoscenico delle relazioni internazionali costringeva le superpotenze a modificare la forma del loro conflitto e ad ampliarne la portata. Per quanto riguarda la forma, dopo la stabilizzazione in Europa, il problema tendeva a presentarsi ora sotto aspetti diversi. Se per ora si tralasciano quelli riguardanti la competizione spaziale e nucleare che non investivano i paesi di recente indipendenza, affiorava invece il tema della cosiddetta «coesistenza competitiva», che in pratica potrebbe essere definita come capacità di dimostrare che ciascuno di tali paesi avrebbe meglio risolto i problemi del proprio consolidamento grazie all’aiuto di una delle superpotenze, sia mediante l’adozione di forme d’organizzazione politico-economica affini a quelle dell’economia di mercato sia, al contrario, mediante l’uniformazione ai metodi economici del cosiddetto «socialismo reale». Il conflitto bipolare diventava competizione quando affermava la necessità di una scelta fra modelli di sviluppo, nell’intento del tutto trasparente che tale scelta avrebbe poi avuto conseguenze dirette in termini di influenza mondiale. Perciò il confronto si spostava dall’Europa, invadeva il Mediterraneo, si estendeva a tutto il globo (non esclusa l’America Latina), coinvolgeva ogni aspetto della vita dei popoli e tendeva a integrare in un processo di interdipendenza tutti i paesi di recente autonomia, nonostante le vocazioni al non allineamento che al tempo stesso essi elaboravano come alternativa alla subordinazione e speranza di sviluppo indipendente.
Per gli Stati Uniti la decolonizzazione non poneva problemi di principio. Nati essi stessi dalla prima guerra anticoloniale dell’età moderna, avevano sempre combattuto l’imperialismo europeo. Il principio di self-government era stato proclamato da Wilson come uno dei cardini della nuova diplomazia americana e ribadito da Roosevelt durante la seconda guerra mondiale. Come ricorda Eisenhower nelle sue memorie, gli Stati Uniti avevano combattuto due guerre mondiali senza chiedere per sé alcun incremento territoriale. «Gli Stati Uniti», egli scrive, «senza nutrire progetti sulle terre e i tesori degli altri, sono stati tradizionalmente coerenti con la loro politica di anticolonialismo». Questi principi e queste formule erano tuttavia appannati dall’effettiva egemonia economico-finanziaria esercitata dagli Stati Uniti sull’America Latina e dall’interpretazione data alla politica globalistica di Roosevelt durante la seconda guerra mondiale. Il Grand Design rooseveltiano (cfr. p. 530) molto spesso veniva interpretato quale metodo per sostituire al colonialismo diretto un’influenza meno visibile ma più penetrante. Inoltre agli Stati Uniti veniva rimproverato l’appoggio o l’ambiguità che essi avevano mostrato rispetto alle lotte coloniali che coinvolgevano paesi alleati come la Gran Bretagna e la Francia. Un brano tratto da una dichiarazione di Dulles al National Security Council il 1° novembre 1956 giova a collocare in modo adeguato questo tema:
Per molti anni – diceva Dulles – gli Stati Uniti hanno camminato su una corda tesa tra l’impegno a mantenere da un lato il loro vecchio e valido rapporto con i loro alleati inglesi e francesi e dall’altro il tentativo di garantirsi l’amicizia e l’intesa dei paesi da poco indipendenti [...]. Non potremo camminare ancora su questa corda tesa. Se non riusciamo a affermare ora la nostra leadership su questi paesi, essi si volgeranno verso l’Unione Sovietica.
Difatti, l’Unione Sovietica, sebbene fosse rimasta nel 1960 alla testa di uno dei pochissimi sistemi di rapporti imperiali esistenti nel mondo, poteva vantare un elenco di benemerenze anticolonialistiche che risaliva ai teorici del comunismo e giungeva sino agli anni della decolonizzazione. Anche Chruščëv nel 1956, al XX Congresso del Pcus, aveva sottolineato le potenzialità della nuova situazione:
In contrasto con il periodo prebellico, la maggior parte dei paesi asiatici agiscono oggi nell’arena mondiale come Stati indipendenti o Stati che sostengono risolutamente il loro diritto di svolgere una politica estera indipendente. Le relazioni internazionali si sono estese al di là dei confini delle relazioni fra paesi abitati soprattutto da popolazioni di razza bianca e incominciano ad acquistare il carattere di relazioni effettivamente globali.
In effetti la rivoluzione anticoloniale riapriva mercati, riproponeva problemi di disponibilità e costi delle materie prime, creava nuovi spazi di dominio, imponeva i problemi dello sviluppo economico alle due superpotenze: nessuna delle quali era amministrativamente attrezzata per affrontare con reazioni rapide situazioni di emergenza nuove. Nonostante il vigore della propaganda e della tradizione marxista-leninista e nonostante l’attenta consapevolezza chruscioviana dell’importanza risolutiva del nuovo conflitto, il divario esistente dal punto di vista delle risorse economiche e finanziarie, della elasticità dei metodi di intervento e delle posizioni di forza già acquisite era però tale da precostituire, nonostante alcune illusioni della prima fase, l’esito della competizione. I Sovietici operavano sulla base di un sistema ideologico solo esternamente capace di esser tradotto in modo automatico in ideologia della liberazione. Nonostante il grande dispendio di risorse effettuato per offrire a Mosca scuole di formazione delle élite dei paesi di recente indipendenza, le posizioni sovietiche erano fragili per diverse ragioni.
I Sovietici muovevano anzitutto da basi geopolitiche abbastanza delimitate. Nell’Asia orientale la loro influenza era forte in Corea e nel Viet Nam ma era minata dal latente conflitto con la Repubblica popolare cinese. Negli Stati insulari dell’Asia sud-orientale essi erano ridotti in posizioni marginali (nonostante la presenza di guerriglieri filosovietici) dai legami delle Filippine con gli Stati Uniti e, in Indonesia, dalla polivalenza di Sukarno, che appoggiava il suo potere su un accorto insieme di forze del quale faceva parte anche il Partito comunista filo-cinese, cioè su una coalizione dichiaratamente neutralista, per quanto fortemente appoggiata dai Sovietici. Del resto, nel settembre 1965 un tentativo di colpo di Stato filocomunista effettuato da alcuni alti ufficiali dell’esercito fornì lo spunto per una sanguinosa reazione (con centinaia di migliaia di morti, il cui numero effettivo varia secondo il variare delle fonti) che portò alla guida dell’Indonesia il generale T.N.J. Suharto e annientò l’influenza sovietica. La Birmania che i fondatori, come U Nu, avevano voluto neutralista, era in bilico fra l’influenza cinese e l’autonomia. Dal 1962 il generale Ne Win, pur rassicurando i Cinesi della propria volontà di mantenere buoni rapporti con il governo di Pechino, si impadronì militarmente del potere che da allora tenne in modo esclusivo, come una tirannia poco benevola e impermeabile alle influenze esterne. Nel resto dell’Asia, l’Urss poteva contare su relazioni amichevoli con l’India, ma i problemi e la dimensione del subcontinente indiano erano tali da impedire che l’Urss potesse concepire l’accordo con gli Indiani alla stregua di un rapporto di dipendenza con un paese di recente autogoverno al quale proporre modelli organizzativi nuovi. Con l’India potevano essere intrattenute dunque solo relazioni di collaborazione tecnica e diplomatica, magari in funzione anticinese, integrate solo in pochi casi da qualche tentativo di infiltrazione in singole amministrazioni statali.
Quanto al mondo islamico e più in particolare al Medio Oriente, eccettuato il caso dell’Afghanistan, che fin dalla seconda metà del XIX secolo aveva relazioni importanti con l’impero zarista, tutto il resto poneva i Sovietici dinanzi a considerevoli occasioni dal punto di vista dei rapporti di potenza ma anche ad altrettanti impedimenti: da quello delle diversità religiose a quello delle lontananze culturali e delle diffidenze politiche. La presenza all’interno dell’Urss di Stati con una popolazione islamica, relativamente libera nell’esercizio dei culti, era a un tempo veicolo e ostacolo all’influenza nella parte restante della regione. La speranza di poter sostituire all’egemonia anglo-francese nel Medio Oriente quella sovietica venne frustrata non solo dalla rapidità dell’intervento americano o dalla presenza in Turchia di un regime strettamente vincolato all’Occidente per mezzo dell’Alleanza atlantica, ma anche dalla diffidenza iraniana rispetto alla pressione sovietica, e da quella dei paesi produttori di petrolio rispetto a un concorrente economico animato da progetti di mutamento politico. In pratica solo i paesi più densamente popolati o più direttamente toccati dall’acuirsi del conflitto israeliano-palestinese erano sensibili all’intervento sovietico. Egitto, Siria e Iraq erano i tre Stati rispetto ai quali l’Urss aveva sviluppato una tradizione di aiuti e collaborazione che, a meno di grossolani errori, avrebbe potuto dare frutti più consistenti. Qualche spiraglio si apriva invece alla penetrazione sovietica nell’America Latina: nel Centro-America mediante la guerriglia, nel Cile grazie alla dialettica delle forze democratiche liberamente esercitata sino al settembre 1973 e soprattutto a Cuba, divenuta, dopo il consolidamento della rivoluzione cas...