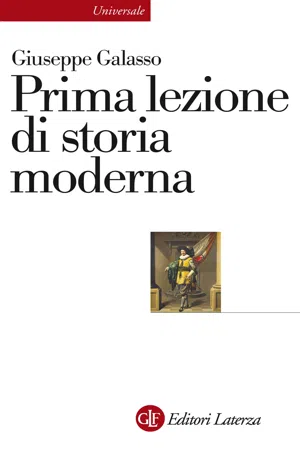
eBook - ePub
Prima lezione di storia moderna
Giuseppe Galasso
This is a test
- 204 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Prima lezione di storia moderna
Giuseppe Galasso
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Che cos'è la storia moderna? Quando comincia e quando finisce? E che vuol dire moderno? Siamo già in un mondo post-moderno? Galasso risponde: che moderna è tutta l'età dalla fine del Medioevo a oggi; che perciò la storia contemporanea è solo la più recente storia moderna; che la modernità ha segnato un salto di qualità nella condizione umana più radicale di quello dell'età neolitica; che il post-moderno è solo un nuovo moderno, ancora più moderno.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Prima lezione di storia moderna an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Prima lezione di storia moderna by Giuseppe Galasso in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Historia & Historiografía. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
HistoriaSubtopic
HistoriografíaDefinire la storia moderna
Moderno
Se si deve parlare di storia moderna, è bene chiedersi subito che cosa vogliano dire queste due parole.
Per storia ci si può intendere alquanto facilmente. Assumiamo come scontato che significhi due cose: 1. tutto ciò che è accaduto nel passato; 2. lo studio e la narrazione di ciò che è accaduto nel passato. Sono due definizioni alla buona, ma più che sufficienti qui.
Altrettanto facile dovrebbe essere il chiarimento di ciò che significa moderno. Si tratta, infatti, di un aggettivo che deriva da un avverbio latino, l’avverbio modo, che significa “ora”, “adesso”, e indica, quindi, il tempo presente. Nell’italiano antico la parola era ancora usata. Dante parla, ad esempio, delle «fogliette pur mo’ nate» (Purgatorio, VIII, 28), ossia delle piccole foglie spuntate appena ora. La parola è ancor oggi viva in alcune parlate italiane. In napoletano, ad esempio, è comune la locuzione mo’ mo’, per dire “subito ora”, ossia immediatamente adesso.
Storia moderna vorrà quindi dire, stando al significato letterale dei termini, la “storia di ora”, la “storia del presente”, del nostro tempo. La storia contemporanea, dunque. E, infatti, è così, e la coincidenza merita sia di essere sottolineata che di essere spiegata, e ciò tanto più in quanto il fatto che moderno e contemporaneo abbiano assolutamente lo stesso significato di riferimento all’attualità non è sempre tenuto presente come meriterebbe: anzi, per lo più, non è neppure avvertito.
A dire il vero, una differenza tra i due termini può anche essere ravvisata, ma sul piano etimologico più che sul piano semantico, ossia sul piano della rispettiva provenienza linguistica più che su quello del significato. Per il termine moderno il riferimento all’attualità è esclusivo sul piano del significato, essendo l’aggettivo derivato, come si è detto, dall’avverbio latino modo, mentre per contemporaneo il riferimento all’attualità non è altrettanto esclusivo, in quanto la proprietà del contempo, ossia dell’identità di tempo, dell’accadere o trovarsi nello stesso tempo, può essere riscontrata sia nel presente che nel passato. Possiamo dire perciò – con tutta legittimità lessicale e semantica – che Cesare, ad esempio, fu contemporaneo di Cicerone, così come, ventuno secoli dopo, sono contemporanei il papa Benedetto XVI e la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Invece, soltanto in senso traslato, metaforico, soltanto per modo di dire, possiamo affermare – se lo crediamo! – che Aristotele fu più moderno di Platone, o, naturalmente, viceversa; o che l’uso dei metalli introdusse un’economia più moderna di quella della pietra o di altri materiali di uso più antico; o che la strategia di Annibale era più (o meno) moderna di quella di altri grandi capitani dell’antichità.
Ciò induce a notare subito che l’uso del termine moderno appare alquanto meno innocente, meno anodino di quello del termine contemporaneo. Quest’ultimo presenta un significato che si esaurisce nell’affermazione o nella constatazione dell’identità del tempo in cui ci si trova nel presente o nel passato (Cesare e Cicerone, nell’esempio che abbiamo fatto). Il primo termine, invece, include un’affermazione sia di qualità che di valore (un pensiero, un’economia o altro sono moderni dal punto di vista della loro qualità, e tale qualità costituisce un loro pregio). In altre parole, l’attribuzione della qualifica di moderno impegna molto di più nelle sue idee chi dà una tale definizione. (La differenza può essere ancora meglio spiegata osservando come noi possiamo affermare che sentiamo Platone, o Aristotele, come un nostro contemporaneo o più nostro contemporaneo, ma non che Aristotele fosse più contemporaneo del suo contemporaneo Platone, mentre possiamo dire che Aristotele fosse più moderno di Platone, o viceversa).
Moderno, insomma, è un termine molto più valutativo, molto più carico di misure di valore rispetto a contemporaneo.
Ugualmente gioverà osservare che neppure viene sempre tenuta presente come sarebbe necessario la storia delle due parole e, in particolare, quella del loro uso storiografico: un uso relativamente recente per contemporaneo, e, invece, ben più remoto e sedimentato per moderno.
Intanto, nell’italiano tutti e due i termini sono attestati fin dal secolo XIV e con entrambe le accezioni di ciascuno di essi, alle quali abbiamo accennato. Ugualmente attestata è la precoce utilizzazione storiografica di “moderno”. Né si tratta di un uso soltanto italiano. Il Du Cange riporta la formula, frequente in carte del secolo XIII, noverint igitur tam moderni quam futuri, che cita tanto “gli uomini di ora, i contemporanei” quanto “gli uomini del futuro, i posteri”: formula che dimostra come già nel latino medievale si praticasse questo senso della parola (moderno = contemporaneo); e mostra, anzi, in vigore già anche l’antitesi antiquitas-modernitas. Lo stesso Du Cange registra contemporalis nel senso di aequaevus (dello stesso evo, cioè dello stesso periodo, dello stesso tempo), ma anche l’idea dello stesso tempo (contempo in italiano, contempe in francese, mentre contemporaneus è già nel latino tardoimperiale) non offre alcuna difficoltà di utilizzazione storiografica, come si è visto per secoli con i libri dedicati a temi trattati fino “ai nostri tempi” o “ai nostri giorni”.
Quanto alla richiamata precoce utilizzazione storiografica di moderno, non si può fare a meno di ricordare che il termine fa parte, in effetti, di un trittico, nato nell’ambito europeo, che scandisce il corso della storia nella successione di antico, medievale e, appunto, moderno, dove il primo e il terzo sono di più trasparente significato, sicché è il secondo a porre con maggiore pregnanza il problema del suo senso.
Antico, medievale, moderno
Medioevo, cioè “età di mezzo”, è, infatti, qualsiasi epoca o tempo della storia. Ogni epoca o tempo sta fra quel che viene prima e quel che viene dopo, sicché tutta la storia può essere egregiamente definita come un perenne medioevo, una continua transizione dal prima al poi. Quale senso può allora avere il termine “medioevo” nella ripartizione dei tempi storici, che nel mondo occidentale si insegna e si apprende fin dalle scuole elementari?
L’accenno al mondo occidentale contenuto in questa più che legittima domanda porta già in sé la risposta. Il Medioevo a cui ci si riferisce nella cronologia di cui stiamo parlando è, infatti, una definizione temporale elaborata nell’ambito dell’esperienza europea; e sappiamo abbastanza bene quando e dove, come e perché è nata.
Bisogna rifarsi, per questo, all’Italia del secolo XV. Fu allora, già nella prima metà di quel secolo, che innanzitutto in Toscana, e in specie a Firenze, si cominciò a parlare della rinascita o restauro o ripresa delle lettere e delle arti dopo un lungo sonno o eclisse o declino di dieci secoli. Ciò che rinasceva era la purezza, l’eccellenza, la luce, in una parola la perfezione delle lettere e delle arti dell’età antica. Questa perfezione si era oscurata nei secoli bui e barbari che erano seguiti alla caduta dell’Impero di Roma sotto l’urto delle invasioni barbariche e alla conseguente rovina della civiltà antica, la civiltà dei Romani e dei Greci. Ora rinasceva. Si tornava al terso ed elegante latino di Cicerone e di Cesare. Si leggeva e si scriveva di nuovo il greco di Omero e degli altri grandi scrittori ellenici, che da secoli erano spariti dall’orizzonte europeo. Una nuova arte figurativa (pittura, scultura, architettura: Botticelli, Donatello, Brunelleschi) metteva finalmente fuori causa la rozzezza romanica, i deliri gotici e rinnovava i fasti della bellezza perfetta, di cui l’arte antica aveva il segreto.
Il Medioevo era, dunque, il lungo interludio millenario fra l’antico e l’età moderna, ossia il periodo posto fra l’età antica e l’età che per gli umanisti e gli artisti del secolo XV era l’età presente, era l’adesso, l’ora, il mo’ del loro parlare italiano, era l’età moderna.
Come si vede e si intende, le determinazioni alle quali così si giungeva non erano affatto definizioni puramente cronologiche. Erano tutte definizioni che associavano alla determinazione cronologica una valutazione qualitativa. In questa valutazione l’antico e il moderno rappresentavano il positivo; il medievale rappresentava il negativo. Il che dimostra che il senso valutativo, la carica anche ideologica del termine moderno, di cui abbiamo parlato, si ritrova fin dall’inizio del suo uso storiografico, nella sua contrapposizione, come si è visto, al Medioevo, e nella qualificazione negativa che ne deriva per l’età medievale.
Infine, la prima concezione della modernità era di ordine estetico: artistico e letterario. È agli artisti e agli scrittori del secolo XV e del secolo XVI che ci si riferiva come ad artefici ed esponenti di quel ritorno delle lettere e delle arti al grado di eccellenza che si riteneva le avessero caratterizzate nell’età antica e per cui si parlava dell’“età di mezzo” nei termini negativi che si sono visti. È comprensibile che questo facesse sorgere la questione del perché gli antichi fossero così eccellenti da far pensare, come allora per lo più accadeva, che li si potesse imitare, non già superare o far altro. La risposta allora generalmente data (o, molto più correttamente, suggerita perché implicita nelle idee all’epoca prevalenti) era che gli antichi imitavano la natura; che la natura era il regno insuperabile dell’eccellenza; e che a loro volta gli antichi nell’imitazione della natura avevano raggiunto l’eccellenza. Perciò, imitare gli antichi era lo stesso che imitare la natura; e, come quest’ultima, anch’essi, per la stessa ragione, erano insuperabili, modelli assoluti come quelli naturali.
In seguito, già dalla prima metà del secolo XVI, la determinazione del moderno si andò via via incrementando. Lo si vede, in particolare, negli svolgimenti del pensiero politico. La riflessione di Machiavelli ne è un buon esempio. Egli dichiara, infatti, di costruirla su due pilastri, su un doppio riferimento di metodo: la «lezione delle cose antique» e «l’esperienza delle cose moderne». E le «cose antique» sono per lui quelle dell’età antica.
Non che egli ignori gli svolgimenti storici del Medioevo. Al contrario. È davvero singolare che manifesti, anzi, una conoscenza non banale e non superficiale della storia medievale della sua città, e che nelle Istorie fiorentine dimostri, narrando le vicende di Firenze, la capacità di percepire aspetti e problemi di ordine generale di quella storia, nel cui quadro la storia della città viene collocata. Esemplare è certamente, a questo riguardo, il brano delle Istorie fiorentine (libro I, cap. V), in cui si nota che, caduto l’Impero di Roma, «l’Italia e le altre provincie romane [...] non solamente variarono il governo col principe, ma le leggi, i costumi, il modo del vivere, la religione, la lingua, l’abito ed i nomi [...] Da questo nacque la rovina, il nascimento o l’augumento di molte città [...] e molte variamente furono disfatte e rifatte [...] Sursono nuove lingue [...] Hanno variato il nome non solamente le provincie, ma i laghi, i fiumi, i mari e gli uomini, [e] non fu di minor momento il variare della religione». Il passaggio dall’età antica a quella medievale è qui delineato in poche righe, ma in tutta la sua portata e varietà di radicale e totale mutamento della vita civile.
Eppure, l’esemplificazione storica alla quale Machiavelli sistematicamente ricorre nella costruzione delle sue idee quasi mai si riferisce al Medioevo. Le «cose antique» da cui trarre insegnamenti e ammonimenti sono per lui, come abbiamo già detto, e con tutta evidenza, le cose dell’età antica e, soprattutto, romane. Da Giustiniano a Carlomagno, da Carlomagno a Federico II, sembra davvero stendersi per lui un vuoto di materia storica istruttiva e illuminante ai fini dello sviluppo e della dimostrazione delle sue idee: un vuoto dal quale nulla, o ben poco, può essere tratto per la maturazione e per l’approfondimento di quella sapienza politica che è il fine della sua riflessione. E poiché a integrare la «lezione delle cose antique» vale l’esperienza delle cose presenti – le «cose moderne» – appare implicita anche nel caso del Machiavelli la tripartizione antico-medievale-moderno, benché non venga mai esplicitamente formulata come tale.
Per tutt’altra via la stessa triade si afferma anche sul piano, completamente diverso, della vita religiosa. È noto che già con Lutero lo schema storico sul quale venivano fondate le tesi della riforma cristiana da lui propugnata, e che hanno formato la maggiore base dottrinaria del Protestantesimo, presentava una parte iniziale della storia cristiana, costituita dall’età apostolica e patristica; una successiva, lunghissima, millenaria parte, caratterizzata dall’egemonia della Chiesa di Roma; una terza parte che era, per l’appunto, quella che al loro tempo inauguravano Lutero e gli altri riformatori. La prima età era quella della purezza e dell’autenticità evangelica. La seconda era quella della corruzione e dell’adulterazione più piena e degradante della purezza del messaggio evangelico. La terza parte era quella del ritorno al vero Evangelio, che nel loro tempo si proponevano i riformatori.
Era – come ben s’intende – anche questo, al pari di quello machiavelliano sul piano politico, un ampliamento notevole della configurazione che veniva prendendo la modernità. E ancora altri elementi si potrebbero indicare nello stesso senso, ma è di certo più importante osservare che l’idea del Medioevo come “età oscura” fra quella antica e quella moderna finì con l’abbracciare l’intero campo della vita civile, come appare al più tardi, con tutta chiarezza, nel pensiero e nella storiografia dell’Illuminismo. Nell’Illuminismo, infatti, il Medioevo è oggetto della più completa svalutazione. Nella vita morale è il regno della superstizione e del fanatismo religioso. Nell’ordine politico è la dissoluzione dello Stato dinanzi alla Chiesa e al feudalesimo, regime della forza, della violenza e del disordine. Nell’ordine sociale è il regno delle disuguaglianze, del privilegio ecclesiastico e feudale e dell’oppressione violenta a cui è sottoposta la parte restante della società, ossia quasi tutta la popolazione. Nell’ordine giuridico vi dominano i privilegi e le immunità. Nel campo estetico e culturale è il regno dell’ignoranza generalizzata, del gusto barbarico, già deprecato dagli umanisti. E di conseguenza il moderno è l’antitesi di tutto ciò: è la luce che rischiara le tenebre, il trionfo della ragione, che comporta l’ordine e la giustizia.
Questa estensione generalizzante del significato di “modernità” dal punto di vis...
Table of contents
Citation styles for Prima lezione di storia moderna
APA 6 Citation
Galasso, G. (2011). Prima lezione di storia moderna ([edition unavailable]). Editori Laterza. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3460663/prima-lezione-di-storia-moderna-pdf (Original work published 2011)
Chicago Citation
Galasso, Giuseppe. (2011) 2011. Prima Lezione Di Storia Moderna. [Edition unavailable]. Editori Laterza. https://www.perlego.com/book/3460663/prima-lezione-di-storia-moderna-pdf.
Harvard Citation
Galasso, G. (2011) Prima lezione di storia moderna. [edition unavailable]. Editori Laterza. Available at: https://www.perlego.com/book/3460663/prima-lezione-di-storia-moderna-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Galasso, Giuseppe. Prima Lezione Di Storia Moderna. [edition unavailable]. Editori Laterza, 2011. Web. 15 Oct. 2022.