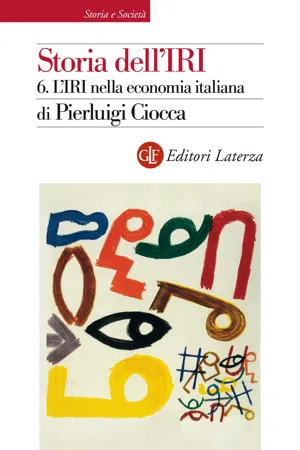Capitolo 1. Prima dell’IRI
L’Istituto per la ricostruzione industriale – l’IRI – è stato parte dell’economia italiana come economia di mercato capitalistica in incerta transizione verso assetti più avanzati, incline per la debolezza dei produttori privati al sostegno dello Stato. Questi tratti costituiscono lo sfondo su cui s’innestò la crisi, industriale e quindi finanziaria, dei primi anni Trenta del Novecento. Essa scaturì dagli scompensi e dalla fragilità dell’industria, accentuati dal susseguirsi di guerra e dopoguerra, sopravvalutazione della lira, recessione mondiale del 1929.
La natura e la gravità della crisi imposero nel gennaio del 1933 l’inedita soluzione dell’IRI: ente pubblico azionista di controllo di grandi imprese e banche operanti nel mercato in regime di diritto civile, aperte all’azionariato privato in minoranza. L’IRI – questa la sua fondamentale ragion d’essere – dovette sostituirsi ai capitalisti dimostratisi inadeguati al compito di conservare al paese quelle grandi imprese, quelle grandi banche.
In positivo e in negativo, il sistema produttivo ne fu segnato per il resto del secolo. Sin quasi alla liquidazione dell’Istituto, nel 2002, la presenza pubblica nell’economia italiana si è identificata in ampia misura con l’IRI e con le aziende nel tempo da esso possedute. L’IRI, d’altra parte, non poteva non riflettere le vicende, le luci e le ombre, della storia economica e politico-sociale del paese.
1. Un apparato produttivo in ritardo
All’inizio degli anni Trenta del Novecento la società italiana era ancora largamente rurale. Gli addetti al settore primario erano il 54% della forza lavoro, rispetto al 25 nell’industria e al 21 nel terziario. Con bassa produttività della manodopera ed elevata produttività della scarsa terra coltivabile e fertile, la campagna esprimeva un terzo del valore aggiunto dell’economia. Il prodotto interno lordo (Pil) pro capite – una misura del benessere materiale, ma anche una prima approssimazione della produttività del lavoro – sfiorava appena i due terzi della media europea, e non arrivava alla metà del livello degli Stati Uniti.
Attraversata una plurisecolare decadenza, l’economia della penisola aveva espresso una crescita di trend fra il 1861 e il 1900. Ma in termini di reddito pro capite il progresso era stato lento (0,7% l’anno), aveva deluso le attese. L’accelerazione giolittiana – con una crescita salita all’1,9% annuo fra il 1900 e il 1913 – restrinse, non colmò, il fossato che divideva l’Italia dalle economie avanzate. Nel periodo 1914-1929, tra guerra e primo fascismo, lo scarto mancò di ridursi ulteriormente.
Vistosa conferma, effetto, concausa del ritardo e degli squilibri era l’arretratezza economica del Sud continentale e delle isole rispetto al Centro-Nord. Dal 1861 il Mezzogiorno aveva sperimentato anch’esso uno sviluppo, tuttavia inferiore a quello del resto d’Italia, dove si concentrava l’avvio dell’industrializzazione. Il Meridione aveva risentito del brigantaggio che l’insanguinò nel primo decennio unitario, della precarietà dell’artificiale industria borbonica, della scarsità di capitale sociale, della lontananza, non solo fisica, dall’Europa progredita. Questi ultimi fattori, strutturali, rendevano il Meridione meno predisposto allo sviluppo capitalistico, di cui il Risorgimento e l’Unità ponevano anche in Italia i presupposti.
Seppure sfruttati al limite, sino a trascurare i costi, suolo e sottosuolo non fornivano a sufficienza prodotti primari e, soprattutto, fonti d’energia. L’esportazione s’imponeva per finanziare le indispensabili importazioni, in un’economia necessariamente aperta ai traffici con l’estero. Nella bilancia dei pagamenti di parte corrente solo nello scorcio dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento i passivi del saldo merci trovavano temporanea compensazione negli attivi dei servizi e trasferimenti. L’equilibrio esterno era questione di qualità e costi comparati dei prodotti. Ma era anche questione di regime e livello dei cambi, emigranti e loro rimesse, merito di credito e politica estera del paese, capitali che dalle piazze finanziarie internazionali erano in mutevole misura disposti a investirsi nelle economie della «periferia», fra cui quella italiana.
L’industria manifatturiera si era configurata come domestico-artigiana sino a Ottocento inoltrato. Negli anni Trenta del Novecento restava «leggera», in un duplice senso: bassa intensità di capitale fisso e orientamento a soddisfare una domanda interna di beni di consumo principalmente primari. Dal censimento del 1927 risultò che le attività con minor rapporto capitale/lavoro che producevano per il consumo occupavano due terzi degli addetti alla manifattura.
Quest’ultima era costituita da una moltitudine di aziende, ma di modesta dimensione. Nel 1927 assommavano a circa 500mila. Poche ripartivano la produzione in più di un opificio. Il numero medio degli addetti per «esercizio» non arrivava a sei. Solo mezzo milione di lavoratori – il 20% del totale manifatturiero – era occupato in stabilimenti con oltre 500 addetti. Le unità locali dotate di più di 1.000 dipendenti erano meno di 200, con 300mila lavoratori (1.700 per unità, in media). La veste giuridica societaria era assunta da una ristretta compagine di aziende industriali: 7mila (edilizia esclusa) su un totale di poco più di 13mila società per azioni.
Un tessuto siffatto univa al potenziale d’imprenditorialità «manchesteriana» insito nella numerosità degli attori il limite della disarmonia. Non vi era salda connessione fra i tre blocchi del sistema produttivo: la moltitudine delle microaziende, con la tendenza a restare tali raramente tentando il superamento della ditta familiare; la bassa quota delle aziende medie propense ad accettare il rischio del ricercare l’innovazione e sperimentarla; la rarità della grande impresa in grado di lanciare su larga scala le produzioni innovative più promettenti, così da diffondere i benefici del progresso tecnico in un mercato di massa. Un presupposto del capitalismo dinamico è che la ricerca di base, se onerosa e aleatoria per i privati, sia promossa dallo Stato presso le università e altri centri, mentre le imprese medio-grandi si dedicano alla ricerca applicata, sviluppabile con rendimenti crescenti nella produzione di beni e servizi per il mercato. In un contesto di concorrenza attuata attraverso l’innovazione, prima ancora che attraverso il prezzo, la produttività si configura come il motore dello sviluppo economico moderno. Dall’Unità a oggi, per l’alterno realizzarsi di questi presupposti, il contributo del progresso tecnico alla crescita è risultato discontinuo. Era stato pressoché nullo dal 1861 al 1900, allorché soltanto poche aziende arrivavano a impiegare un migliaio di lavoratori. Assunse valori apprezzabili nell’età giolittiana, con un centinaio di ditte manifatturiere salite oltre i mille addetti.
Ai mediocri livelli e alla lenta progressione della produttività il sistema suppliva ricercando il profitto nel basso costo del lavoro e nella protezione dalla concorrenza. Occupazione eccedente in agricoltura ed emigrazione riflettevano l’abbondanza della manodopera bracciantile e urbana. Le ricadute negative in termini di diritti e condizioni di lavoro potevano essere solo contenute dalle organizzazioni dei lavoratori, fra ricorrenti tensioni sociali e rivolte proletarie incapaci di sbocco rivoluzionario. L’eccesso d’offerta di manodopera e la durezza repressiva delle forze dell’ordine e della magistratura, insieme con la debolezza di quelle organizzazioni, calmieravano i salari. Unitamente al divario Nord-Sud e a uno sviluppo diseguale tra settori e imprese, i bassi salari rendevano sperequata la ripartizione personale e familiare del reddito. La sottrazione alla concorrenza, d’altra parte, non aveva assunto la forma della grande impresa schumpeteriana, oligopolistica perché innovativa, ma quella del rapporto con la politica, con lo Stato, con le amministrazioni locali e fra le stesse aziende nelle più svariate modalità collusive.
Il Regno d’Italia era nato con gli assetti e le infrastrutture di uno Stato moderno tutto da edificare, ma con ambizioni da potenza europea espresse dalla Destra storica. Con la Sinistra, al governo dal 1876, l’intervento pubblico nell’economia si estese. La spesa pubblica era sin dal 1861 larga per i tempi (12-14% del Pil), data l’arretratezza dell’economia; arrivava a sfiorare il 20% del Pil al tempo di Crispi, nello scorcio dell’Ottocento. In politica commerciale la soluzione protezionista era stata ampiamente praticata con le tariffe doganali del 1878 e soprattutto del 1887. Le imprese produttrici dei beni oggetto di commercio internazionale presero da allora a farvi affidamento. Sempre con la Sinistra, il favor per determinati settori e per determinate imprese si era venuto articolando in una gamma di opachi provvedimenti speciali: commesse, convenzioni, premi, sovvenzioni, sgravi fiscali, privative, garanzie. Si trattava di aiuti, elargiti con discrezionalità politico-amministrativa per scopi mutevoli. Nel sostegno a un’economia – e segnatamente a un’industria – in ritardo, strumenti rivolti a obiettivi contingenti si aggiunsero, e spesso si sostituirono, ai meccanismi predeterminati, trasparenti, autonomi una volta apprestati. Ben più dei meccanismi, gli strumenti rischiavano di corrispondere a interessi particolari. Alimentavano negli uomini d’affari l’aspettativa del profitto fondato, oltre che sulla debolezza dei salariati e delle loro organizzazioni, sulle connivenze con il ceto politico. Soprattutto, alimentavano il convincimento che le difficoltà, le perdite, l’eventuale dissesto dell’azienda potevano essere sventati o compensati dal soccorso pubblico. La produttività diveniva secondaria.
Giolitti contrastò questa tendenza. Frenò la spesa pubblica, tenne alto il cambio, inaugurò la neutralità dello Stato – dei suoi carabinieri – di fronte allo scontro fra capitale e lavoro, contrastò la speculazione edilizia, limò la protezione doganale effettiva, nazionalizzò i servizi mal gestiti dai privati (ferrovie, telefoni, assicurazioni). Le sollecitazioni concorrenziali che questa politica impose alle imprese concorsero a far sì che nell’«età giolittiana» – dal 1900 al 1913 – la crescita del Pil accelerasse (2,8% l’anno, dall’1,3 del 1861-1900), per circa due terzi grazie al contributo del progresso tecnico. Nonostante la vera e propria primavera economica che promosse, l’azione dello statista di Dronero non fu compresa. Egli non seppe valorizzarla. Fu avversato da larghi strati della borghesia. Venne impietosamente criticato dagli illustri economisti liberali – de Viti de Marco, Pantaleoni, Barone, Einaudi, Ricci – che vagheggiavano nelle fo...