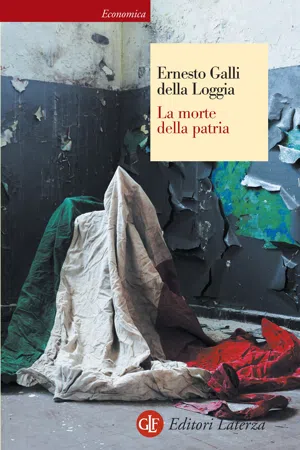
eBook - ePub
La morte della patria
La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica
Ernesto Galli della Loggia
This is a test
Share book
- 152 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
La morte della patria
La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica
Ernesto Galli della Loggia
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
La Resistenza non è riuscita a fondare una identità nazionale dell'Italia democratica. La crisi dell'idea di patria, già compromessa dall'esperienza fascista, è forse la più pesante eredità che la guerra perduta ha trasmesso alla Repubblica.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is La morte della patria an online PDF/ePUB?
Yes, you can access La morte della patria by Ernesto Galli della Loggia in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Geschichte & Geschichte des 21. Jahrhunderts. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
GeschichteSubtopic
Geschichte des 21. JahrhundertsLa morte della patria
«La morte della patria è certamente l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo». Queste parole, che si leggono in apertura del De profundis di Salvatore Satta1 – senz’altro il libro di più alta e dilaniata riflessione sugli avvenimenti italiani del 1940-45 – potrebbero essere poste degnamente ad epigrafe della sorte che toccò in Italia all’idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale.
Il sentimento di una vera e propria «morte della patria» fu, infatti, ciò che soggettivamente provò, in quel biennio terribile e immediatamente dopo, chiunque nel proprio mondo etico-politico, o solo emotivo, custodisse – in una qualunque foggia – l’idea di nazione, e dentro di sé sentisse questa idea irrevocabilmente legata all’idea, e all’esistenza, di una nazione italiana. «Il bluff è finito – scriveva sconsolatamente Gaetano Salvemini ad Ernesto Rossi in una delle sue prime lettere dall’America, nel dicembre 1944 – l’Italia non è più che una sfera d’influenza inglese, una colonia inglese, una seconda Irlanda»2. Sembra fargli eco, benché di un anno precedente, un’annotazione del diario di Croce: «Sono stato sveglio per alcune ore, tra le 2 e le 5, sempre fisso nel pensiero che tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo in qua costruito politicamente, economicamente e moralmente è distrutto, irrimediabilmente»3. Una disperazione e un senso di annichilimento non dissimili da quelli di due grandi intellettuali come Croce e Salvemini gelarono il cuore degli italiani qualunque rinchiusi in un campo di prigionia in India:
Ci guardavamo come tanti ebeti, ripetavamo sommessamente: «Resa incondizionata». Alla conta delle otto, di fronte agli inglesi sorridenti, i plotoni dei prigionieri sfilarono nel massimo silenzio. Sentivamo, in una disperazione che ci pervadeva tutti, di essere davvero dei vinti. Pensavamo di aver perduto per sempre il nostro onore di uomini e di soldati. Ci sembrava che nel mondo un italiano non potesse alzare gli occhi mai più, sotto il peso della vergogna.4
L’espressione «morte della patria» mi sembra la più adatta per definire la profondità, la ricchezza d’implicazioni, in una parola la qualità tutta particolare che ha avuto in Italia la crisi dell’idea di nazione in conseguenza della guerra mondiale. Tale crisi, infatti, va molto al di là del dato politico-militare della sconfitta: non può essere spiegata esclusivamente con questo dato, così come – tanto meno – può essere identificata o assorbita in esso per intero.
Al contrario, la crisi dell’idea di nazione si radicalizza in «morte della patria», proprio perché in essa moltissimi italiani vedono e sentono coinvolto lo stesso vincolo di appartenenza ad una medesima comunità nazionale, nonché il senso di tale vincolo. Se ciò accade è perché vi è, all’origine, nel drammatico nodo di eventi dal ’43 al ’45 una crisi verticale che colpisce l’intero organismo statuale italiano, determinandone quasi – nei fatti, e soprattutto nell’immaginario – una virtuale scomparsa dalla scena. È questo un fattore della massima importanza. In Italia, infatti, la nazione – come si sa – lungi dal preesistere allo Stato ne è stata, invece, piuttosto una creatura, quasi un effetto derivato. Nella nostra storia l’esistenza della nazione è indissolubilmente legata all’esistenza dello Stato (nazionale), sicché, da un punto di vista storico il concetto e il sentimento di patria costituiscono precisamente il riflesso ideologico-emotivo di questo intreccio5.
Nella radicalizzazione della crisi della nazione in «morte della patria» confluiscono dunque due ordini di fenomeni: da un lato la crisi/scomparsa dello Stato in conseguenza delle particolari modalità politico-militari della sconfitta bellica, dall’altro lato – e proprio per effetto di tali modalità – la sensazione diffusa in moltissimi abitanti della penisola che la sconfitta, in realtà, è stata causa, e insieme prodotto e manifestazione, di qualcosa di molto grave e profondo: di una paurosa debolezza etico-politica (secondo l’espressione che Renzo De Felice è stato uno dei pochi ad adoperare) degli italiani6.
Questa intima gracilità dell’organismo e della tempra nazionali, con l’immagine di «morte della patria» che reca con sé, è quella che affiora – spesso prorompe – dalle mille forme che a partire dal 1940 prende la crisi della sfera statuale italiana. In tale crisi e nelle sue forme ha un rilievo centrale il comportamento tanto delle Forze armate che di branche decisive dell’amministrazione e dei rispettivi gruppi dirigenti, il più delle volte di un’inadeguatezza superiore ad ogni immaginazione. Le vicende drammatiche di quegli anni sembrano offrire solo l’imbarazzo della scelta: da tante pagine grigie (e forse bisognerebbe dire oscure) di una storia bellica che comincia con il fallimentare tentativo di sfondamento delle linee francesi nel giugno del 1940 e termina simbolicamente, nell’estate del 1943, con l’incredibile episodio di Pantelleria, unica isola fortificata (perdipiù in caverna!) mai arresasi nel corso di una guerra esclusivamente in seguito a bombardamenti aerei; dall’improvvisazione dilettantesca con cui il nostro Ministero degli Esteri e lo Stato Maggiore conducono le trattative per l’armistizio, per finire in bellezza con il maresciallo Badoglio che fugge da Roma non preoccupandosi neppure di portare con sé il testo del medesimo armistizio così da doverne poi chiedere una copia agli Alleati, una volta a Brindisi, sostenendo, come se non bastasse, di non aver mai avuto conoscenza delle clausole del documento7. Non si contano, insomma, gli episodi che attestano l’incompetenza, il rifiuto di assumere le proprie responsabilità, il doppiogiochismo, di coloro che rappresentano lo Stato, che ne sono la viva immagine quotidiana.
Nel 1940-43, insomma, nel magma della crisi politico-militare del paese, emerge un dato nella sua sostanza pre o metapolitico, difficilmente collegabile in modo diretto e significativo al fascismo ed ai guasti della dittatura. Un paragone con i contemporanei eventi tedeschi aiuta a chiarire ciò che voglio dire. Nel corso di tali eventi tanto la Wehrmacht che, per esempio, le branche dell’amministrazione preposte all’approvvigionamento della popolazione o altre consimili, mostrarono, come si sa, una ragguardevolissima capacità di padroneggiare gli eventi fino ai limiti del possibile. Ora, così come di ciò non si potrebbe verosimilmente dare merito al nazismo – ma la spiegazione ne va cercata attingendo a falde storiche ben più profonde – allo stesso modo si deve fare, credo, per quanto accadde in Italia. Qui la crisi politico-militare presenta un aspetto evidentissimo di crisi di capacità e di efficienza degli apparati amministrativi e tecnici, la quale riflette a propria volta un deficit di competenza unito ad un vuoto spirituale, di carattere, che trascendono il regime e mettono in gioco, immediatamente e direttamente, la credibilità della sfera pubblico-statuale del paese; e quindi, a causa del già ricordato fortissimo rapporto di dipendenza esistente nel caso dell’Italia tra i due ambiti, la stessa credibilità del vincolo nazionale e della sua radice etico-politica.
Se non fossero queste – anche queste – le questioni in gioco, rimarrebbe un mistero come mai tanti italiani, nella drammatica situazione del paese in quegli anni, fossero colpiti precisamente da ciò: dallo spettacolo della sua debolezza etico-politica, della progressiva, catastrofica inadeguatezza dello Stato, del venir meno di ogni capacità coesiva dell’identità nazionale. È questo insieme di sentimenti ciò che tanti avvertirono, sbigottiti, dietro il fenomeno, per esempio, del «disfattismo italiano» – una vera e propria «cupido dissolvendi», dirà Satta – di cui si trova testimonianza in tutta la memorialistica più vera e spregiudicata.
Su questa «tremenda realtà» (l’espressione è di Corrado Alvaro), che la coscienza pubblica italiana si è rifiutata tanto a lungo di vedere, ma che si è depositata tuttavia nel fondo oscuro della memoria collettiva – dove è rimasta per decenni non rimossa e non rimovibile – sono da meditare oggi più che mai le righe che ci ha lasciato lo stesso Alvaro:
Gran parte d’Italia si augurò dal primo giorno della guerra la disfatta. Gran parte d’Italia credette, quando i tedeschi arrivarono a Parigi, che la Germania avrebbe perduto ugualmente la guerra [...]. Tutti gli italiani pendevano dal microfono di Radio Londra, la quale assicurava che veramente eravamo fatti per essere amici, che tutta la difficoltà consisteva nel fascismo, che bisognava sbarazzarsi del fascismo e dei tedeschi, e poi ci saremmo intesi [...]. Gli italiani credettero a Radio Londra, sperarono sempre più ardentemente nella sconfitta, l’aiutarono, la predicarono: eppure avevano i figli in Africa, nei Balcani, in Russia. Se v’è una condizione morale tragica per il cittadino, questa lo fu. Guardare il proprio figlio come un arruolato a una banda straniera; accogliere il combattente in licenza aprendo il tasto di Radio Londra per sentirsi incitare alla diserzione e alla rivolta e preconizzare la sconfitta; guardare i propri soldati passare con le bandiere e le fanfare, vedendoli già disfatti; assistere ai bombardamenti delle città e dei quartieri abitati dando ragione al nemico; scusare gli stessi errori di tiro che distruggevano case e beni e vite di cittadini [...] ce n’è abbastanza per comporre uno di più tragici quadri della pazzia morale che un popolo può prendere dalle dittature. Eppure questo fu. [...] Era senso della giustizia? Vendetta contro il tiranno domestico? Sentimento della verità? Volontà di espiazione? Era la catastrofe morale di un popolo divenuto insincero anche con se stesso. [...] La solidarietà e il patriottismo e il senso della responsabilità individuale, andavano disperse e uccise.8
Erano i medesimi interrogativi, in sostanza, che si poneva un prigioniero italiano rinchiuso in un campo del lontano Texas, guardando le fotografie dell’ingresso delle truppe alleate a Roma: «Come è possibile festeggiare così i vincitori? [...] Come avrebbe reagito una folla inglese in circostanze analoghe? E come reagirà la popolazione tedesca il giorno che gli Americani dovessero arrivare in Germania?»9.
Queste domande ed il passo di Alvaro rimandano a tutto l’intreccio di circostanze tecniche, umane e morali che avevano accompagnato la sconfitta – e che la sconfitta aveva significato – ma che non erano e non sono tanto facilmente o immediatamente ascrivibili a una diretta responsabilità del fascismo. Rimandano in particolare al modo in cui avevano operato le Forze armate, i comandi e il corpo ufficiali. È un ambito, questo, non molto frequentato dalla storiografia, perlopiù convinta che la qualifica di «guerra fascista» basti, anche in questo caso, a spiegare e giustificare tutto in maniera convincente. Non è così, a mio parere. In realtà, per l’intera durata della guerra il complesso dell’organismo militare italiano da un lato sembra incapace di prestazioni minimamente adeguate, e dall’altro sembra percorso fin dall’inizio da un sentimento di fatalità della sconfitta, così forte da divenire una sorta di profezia che si autoavvera e di fronte alla quale conviene solo rassegnarsi. Gli unici sussulti, gli unici comportamenti in senso contrario si hanno o nei frangenti più disperati (come per esempio durante la ritirata di Russia), ovvero l’8 settembre, quando in qualche caso si assiste al rifiuto di gettare le armi e di consegnarle ai tedeschi. Ma, ripeto, si tratta di eccezioni.
È difficile negare, insomma, che nella crisi 1940-43 non vi sia anche, ed assai incidente, un problema di virtù militare che si riflette in misura notevolissima sulla immagine del paese. Adopero l’espressione «virtù militare» per indicare tanto il valore in combattimento, cioè le qualità di tenacia, di resistenza, di ardimento, il cui apice è costituito da quello che si è soliti chiamare eroismo, quanto la capacità in senso stretto professionale di condurre le operazioni. Dell’una e dell’altra noi manchiamo tragicamente in quegli anni (e, com’è ovvio, i singoli, isolati episodi di abnegazione e di coraggio, che pur vi furono, nulla tolgono al peso di quanto detto). Da questo punto di vista il «timore di inquietare i nemici» da cui agli occhi di Giorgio Chiesura10 sembrano dominati i soldati italiani opposti agli invasori anglo-americani in Sicilia appare solo il punto d’arrivo di un lungo processo in cui si allineano – enumero alla rinfusa – un decennio di marchiani errori della Marina nel progettare le costruzioni navali11, così come la paurosa assenza di ogni difesa contraerea degna di questo nome sulle città della penisola, la liquefazione come neve al sole tra il dicembre ’40 e il febbraio ’41 dell’armata italiana in Libia agli ordini dell’inettissimo Graziani, forte di 300 mila uomini ben equipaggiati, contro appena 36 mila fanti di Wavell (130 mila dei nostri rimasero in mano agli inglesi!) così come il caso (ho ragione di credere unico al mondo) di un comandante di vascello e del suo equipaggio (è il caso del comandante Grossi e del sommergibile Barbarigo) colti in flagrante mendacio circa l’affondamento – mai avvenuto – di importanti unità nemiche, e perciò avventatamente insigniti di riconoscimenti al valore poi annullati, l’infelice scelta strategica di inviare il materiale più moderno invece che in Africa settentrionale (dove avrebbe potuto rivelarsi decisivo) nell’Unione Sovietica con l’Armir12, così come l’irrealistico non cale in cui il generale Ambrosio mostra, nella primavera del ’43, di tenere un eventuale sbarco alleato nelle isole italiane o sulle coste meridionali della penisola13.
È un...