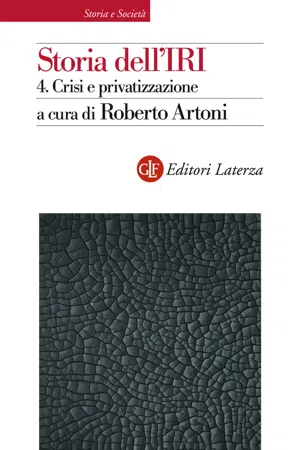1. Il quadro macroeconomico negli anni Novanta
di Carlo Devillanova
1. Introduzione
La politica di privatizzazione delle imprese a partecipazione pubblica è stata avviata nel nostro paese dalla fine del 1992, all’esito di una gravissima crisi valutaria e in un contesto macroeconomico negativo. Oltre che delle privatizzazioni, la crisi del ’92 costituì la premessa, o la causa immediata, di una serie di provvedimenti che incisero profondamente sul nostro sistema di finanza pubblica, sulle nostre strutture produttive, sul funzionamento del mercato del lavoro e, quindi, sulla distribuzione funzionale del reddito.
Anche se crisi valutaria e recessione economica non erano specifici dell’Italia, ma avevano colpito altri paesi industrializzati e molti dei paesi europei aderenti al Sistema monetario europeo (Sme), l’interpretazione prevalente delle vicende del ’92 è centrata sui fattori interni. Tale interpretazione sottolinea, da un lato, l’inevitabilità della crisi e, dall’altro, le sue conseguenze positive per la validità e l’efficacia dei provvedimenti adottati in quelle circostanze ai fini della stabilizzazione. Gli interventi del 1992 e dell’anno seguente furono, in altri termini, l’ineluttabile premessa per la stabilizzazione dell’economia italiana negli ultimi anni del secolo scorso. L’interpretazione cui abbiamo fatto riferimento, che si potrebbe definire «quasi hegeliana» (ciò che è avvenuto doveva accadere e ciò che è accaduto è stato utile), è ben espressa da Salvatore Rossi, quando scrive che
la crisi del ’92-93 è endogena: si tratta del ‘redde rationem’ di oltre due decenni di politiche economiche figlie della temperie sociale e politica iniziata alla fine degli anni Sessanta e proseguita per tutto il decennio Settanta. Politiche volte a sedare l’inquietudine della società del tempo con la morfina dell’inflazione e con denari sottratti alle generazioni future. Dal momento in cui il debito pubblico che ne risulta inizia ad essere collocato presso investitori stranieri, verso la metà degli anni Ottanta, parte un conto alla rovescia che si conclude, nel settembre del ’92, con il ritiro della fiducia da parte di questi ultimi, che dà la stura a facili scommesse speculative sul cambio della lira e a una traumatica svalutazione di questa. Il sistema politico della Prima repubblica, ormai corroso dall’interno, implode rovinosamente pochi mesi dopo4.
Pur ignorando la seconda crisi valutaria di quel decennio (che nel 1995 si risolse in un’ulteriore forte svalutazione della lira), sono agevolmente riconoscibili le conseguenze positive che possono essere attribuite alle scelte del ’92. In particolare, il tasso d’inflazione del nostro paese si allineò di fatto a quello europeo, rendendo possibile la nostra partecipazione all’euro; i conti pubblici registrarono sistematici avanzi primari, continuando una tendenza al miglioramento del saldo primario già manifestatasi in passato.
Possono peraltro essere individuati altri elementi non altrettanto positivi, che, allora non evidenti, hanno tuttavia innescato fenomeni involutivi palesatisi pienamente solo negli anni successivi. I fattori di involuzione possono essere così sintetizzati.
In primo luogo, dopo pochi anni, cominciò a manifestarsi il distacco dell’Italia dagli altri paesi europei in termini di tasso di crescita del Pil. Tale distacco si è accentuato nel primo decennio di questo secolo.
In secondo luogo, a seguito degli accordi stipulati fra il governo e le parti sociali, è stato innescato un rilevante processo di trasformazione del mercato del lavoro che ha certamente contribuito alla concentrazione nella distribuzione del reddito. La modesta crescita dei consumi interni nell’ultimo quindicennio si spiega, in assenza di intermediari finanziari accomodanti, anche con il processo redistributivo allora avviato.
In terzo luogo, le azioni correttive di finanza pubblica hanno sì permesso un sostanziale riequilibrio dei flussi annuali in entrata e in uscita, ma non hanno portato, data l’insoddisfacente evoluzione macroeconomica, al riassorbimento del debito pubblico accumulato nei decenni precedenti: non si è, in altri termini, ripetuto il miracolo del periodo giolittiano, quando fu rapidamente ridimensionato il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno.
È in questo contesto più ampio che deve essere letto e interpretato il processo di privatizzazione degli anni Novanta. Questo processo, giustificabile per più ragioni e certamente condizionato dal clima culturale dell’epoca, pur avendo determinato un profondo cambiamento negli assetti proprietari di settori importanti dell’economia italiana, deve essere valutato anche e soprattutto nella sua capacità di introdurre elementi di vitalità nel sistema produttivo. In particolare, l’identificazione allora posta fra privatizzazioni e stimolo della competitività in senso lato dell’apparato produttivo (al di fuori di ogni esplicito intervento di politica industriale) deve essere analizzata alla luce dell’evoluzione successiva, distinguendo gli effetti riconducibili alla modifica degli assetti proprietari a livello settoriale da quelli connessi con il più generale quadro in cui le privatizzazioni si sono collocate.
Enunciate le principali problematiche, occorre richiamare «i fatti» che meglio permettono d’inquadrare il contesto in cui il processo di privatizzazione, in generale, e di liquidazione dell’IRI, in particolare, si è sviluppato nel corso degli anni Novanta.
Considereremo in estrema sintesi quattro indicatori riferiti ai sub-periodi in cui può essere suddiviso l’ultimo decennio del secolo scorso: il tasso di crescita del sistema, i saldi dei conti con l’estero, l’andamento della finanza pubblica e la distribuzione funzionale del reddito. Sullo sfondo, una situazione internazionale indubbiamente complessa.
2. La situazione al termine del ciclo 1983-1988
Il termina a quo del nostro discorso è il 1988, quando si esaurì nei paesi industrializzati il lungo ciclo di sviluppo cominciato nel 1983. A questo ciclo l’Italia ha partecipato pienamente con un tasso di crescita attorno al 3% dal 1984 al 1988, sistematicamente più elevato di quello degli altri paesi della Comunità economica europea (Cee). Nel 1988, al sesto anno di espansione, il tasso di crescita del Pil reale in Italia tocca il 4,1%. In questo stesso anno i margini di profitto erano giunti ad un massimo storico5.
Dal 1983 al 1988 il saldo delle partite correnti e quello commerciale del nostro paese hanno registrato andamenti altalenanti, tuttavia in un sostanziale equilibrio. In particolare, risultano positivi nel 1986, per poi peggiorare nel 1987 e, in maniera più marcata, nel 1988. L’andamento dei saldi italiani appare positivo rispetto a quelli di Francia e Regno Unito. Inoltre, la quota del mercato mondiale delle esportazioni italiane di beni è cresciuta nel quinquennio6. Tuttavia, nella relazione sul 1988 la Banca d’Italia avvertiva: «in percentuale al Pil, il disavanzo corrente ha raggiunto lo 0,6%: uno squilibrio modesto, sulle cui prospettive pesano tuttavia il progressivo indebolimento delle posizioni di vantaggio comparato dell’Italia nell’interscambio di servizi e la difficoltà di alcune branche dell’industria italiana a sostenere la concorrenza sui mercati internazionali»7. Se poi si guarda alla quotazione in lire delle principali valute, nello stesso periodo si verificano una rivalutazione significativa nei confronti del dollaro (ma con violente oscillazioni all’interno del periodo), una forte svalutazione nei confronti del marco (pari al 25%, in aggiunta a quella del 31% nel quadriennio 1979-1983) e una svalutazione del 10% nei confronti del franco francese. L’andamento della quotazione della lira ha tenuto conto del differenziale d’inflazione nei confronti della Cee, mantenendosi pressoché costante, in termini reali, nell’arco del periodo8.
Nella situazione italiana l’elemento critico era costituito dall’indebitamento delle pubbliche amministrazioni, sempre superiore al 10% del prodotto interno lordo, sebbene il disavanzo primario fosse sceso dal 4,4% del 1985 al 2,8 del 1988, a segnalare una prima inversione di tendenza. Al contrario, il rapporto debito/Pil era aumentato nel quinquennio, dall’82,7 al 92,9%, per effetto del saldo primario costantemente negativo e del sostanziale allineamento del tasso di crescita del Pil e del costo medio del debito pubblico9.
Una seconda criticità alla fine del 1988 era rappresentata dal differenziale d’inflazione. Il tasso di crescita del deflatore del Pil si è più che dimezzato nel sottoperiodo considerato, ma il differenziale con i paesi Cee ha superato sempre abbondantemente i due punti percentuali, con picchi del 6,4 e del 4,8% nel 1983 e 1984 rispettivamente. L’eliminazione del differenziale passava comunque per la stabilizzazione del valore esterno della lira, oltre che per la rottura della spirale prezzi-salari nominali e per un proseguimento del riequilibrio dei conti pubblici sia nel saldo primario (comunque in via di miglioramento), sia nel livello del tasso d’interesse sul debito pubblico. Si può qui ricordare che alla fine del periodo i tassi di interesse a breve e a lunga si collocavano fra il 10 e l’11%, con un’inflazione al consumo al 5% e un deflatore al 6,8%.
3. Il triennio 1989-1991
Dato il quadro di partenza, il triennio 1989-1991 può considerarsi in modo compatto. In questo periodo il tasso di crescita dei paesi industrializzati si è ridotto progressivamente dal 3,5 allo 0,8% (gli Stati Uniti, in particolare, nel 1991 hanno registrato una caduta dei livelli di attività pari a –0,9%). L’Italia ha seguito l’evoluzione complessiva (il tasso di crescita si è ridotto dal 2,9 all’1,1%), con un differenziale d’inflazione annuo rispetto alla media dei paesi industrializzati pari al 3,6% al termine del periodo, calcolato sulla base del deflatore del Pil.
Il saldo di parte corrente della bilancia dei pagamenti, già negativo alla fine del precedente quinquennio, continua a peggiorare. Nel biennio 1989-1990 il saldo negativo raggiunge l’1% del prodotto interno; nel 1991 il 2,1%.
Di fatto, nel triennio non si sono manifestati problemi significativi nel saldo commerciale e dei servizi, nonostante il rallentamento della domanda estera, evidente soprattutto nel 1991, e la riduzione delle esportazioni nette di servizi turistici. Il deterioramento del saldo delle partite correnti è derivato essenzialmente dal forte incremento del deflusso dei redditi di capitale nella voce pagamenti netti per interessi. Il saldo negativo dei redditi con l’estero è passato da 4.800 milioni di euro nel 1989 ad oltre 11.600 nel 199110. In quegli anni si sono manifestati infatti gli effetti della liberalizzazione dei movimenti di capitale, completata nel 1989. Da un lato, i residenti italiani hanno ricomposto i loro portafogli acquisendo attività estere; nello stesso tempo la situazione di relativa calma valutaria ha indotto un afflusso di capitali verso i paesi dello Sme, fra cui l’Italia, dove, anche a causa della più elevata inflazione, i rendimenti nominali erano relativamente elevati. Nel 1991 il debito estero netto dell’Italia superava l’8,4% del Pil.
All’investimento all’estero degli italiani (cui era associata presumibilmente una moderata propensione al rientro dei frutti dell’investimento) corrispondeva invece il versamento ineludibile degli interessi ai non residenti. Tutto ciò spiega sia il peggioramento del saldo dei redditi di capitale, sia l’elevata entità dei flussi di capitale in entrata, soprattutto di impieghi a breve termine. Nel 1990, ad un saldo di parte corrente negativo di 20.000 miliardi hanno corrisposto afflussi di capitale per 52.000 miliardi; l’anno ...