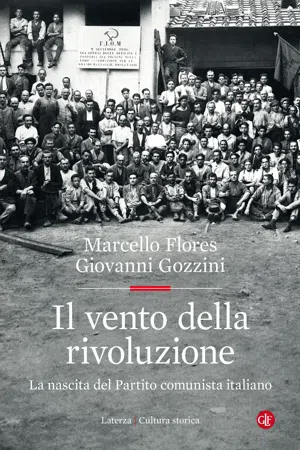![]()
1.
La guerra e l’Oriente
1.1. La stanchezza della guerra
Quando scrive a Corradini nell’agosto 1917, Turati non lo sa ancora o al massimo ne sente solo una pallida eco attraverso la censura di guerra che si esercita su tutti i giornali. Ma di lì a qualche giorno a Torino l’assenza del pane scatena una sommossa, repressa dall’esercito al prezzo di 41 vittime1. Nei mesi precedenti insofferenza, assenteismo, indisciplina si sono diffuse negli stabilimenti industriali della città, al punto da far invocare la proclamazione dello stato d’assedio al ministro generale Dallolio già nel maggio 19172. In prima fila nella protesta sono donne e ragazzi, che sostituiscono in fabbriche e uffici i mariti richiamati sotto le armi e soffrono l’assenza dei padri3. La mancanza dei generi di prima necessità associata alle lunghe ore di fila davanti ai negozi diventa la scintilla per lo scoppio di una esasperazione covata a lungo.
La preoccupazione per le persone care al fronte, il dolore per la morte di parenti e amici, misto all’ira per l’inutile massacro sui campi di battaglia, si accentuano in chi è rimasto a casa, accusato di «imboscamento» anche dall’interno del mondo operaio, perché con un salario e un lavoro sicuro produce strumenti di morte e distruzione, creano sensi di colpa, irrequietezza, un malessere morale aggravato dal senso di impotenza a impedire che il dramma continui4.
Anche a Milano sono entrate in azione le donne – le «furie» di cui Turati scrive ad Anna Kuliscioff il 3 maggio – che hanno fatto uscire gli operai dagli stabilimenti di Porta Ticinese e Porta Magenta, in quella che a lui sembra una rivolta della campagna contro la città.
Vogliono far cessare subito la guerra, rivogliono i loro uomini: ce l’hanno con Milano, che volle la guerra e che ora porta via loro tutto, grano, lardo, riso – riso soprattutto, che in campagna non si trova più e costa 1,70 al chilo – e vogliono far la pelle ai signori, fra i quali – beninteso – siamo anche noi, tanto che si sospettava di una dimostrazione rurale contro il Municipio5.
Sono molte (Barcellona, Pietrogrado, New York, Le Havre) le città dove scoppiano tumulti popolari come quelli di Torino6. Le accomuna la stanchezza della guerra. A lungo una storiografia troppo deformata dalla politica ha letto questi moti entro una scala prefissata e compresa tra i due estremi della spontaneità e dell’organizzazione. Il pregiudizio implicito e teleologico è che la sommossa sia lo «spasmo» meccanico e istintivo prodotto dal peggioramento materiale delle condizioni di vita. Solo quando entrano in ballo attori politici consapevoli capaci di illuminare e guidare le masse, la rivolta diventa soggetto della storia vera7. Per molti versi questa dicotomia arriva pari pari dalle fonti del tempo, attente – come Turati – a cogliere nei sommovimenti minacce e opportunità nella lotta per il potere.
Ma se si analizzano come oggetto di studio autonomo, i tumulti del 1917 permettono di definire e articolare nei suoi diversi significati la stanchezza della guerra. Possono cioè funzionare non solo da termometro delle condizioni dello spirito pubblico ma anche da bussola delle loro traiettorie presenti e future8. Soprattutto, permettono di scorgere una crescente identificazione tra prosecuzione del conflitto e peggioramento delle condizioni di vita. È significativa per esempio l’interpretazione fatta propria dal ministro dell’Interno del tempo, sulla base dei numerosi resoconti locali dei prefetti che anticipano in modo diffuso i fatti di Torino. In una lettera privata (fonte involontaria) scritta al ministro della Guerra nel luglio 1917 si dice convinto della spontaneità dei moti popolari.
Sarebbe erroneo o pericoloso adagiarsi nella credenza che le cause di un fenomeno così complesso e così vasto, possano ridursi nelle modeste proporzioni di un’azione consapevole dovuta a qualche centinaio di mestatori politici, a qualche migliaio di manifestanti sediziosi e a qualche comizio più o meno turbolento9.
Qualche mese dopo, nella testimonianza (fonte volontaria) resa di fronte alla commissione d’inchiesta su Caporetto istituita nel gennaio 1918 da lui stesso (diventato nel frattempo presidente del Consiglio dei ministri), Orlando coglie la genesi dei moti nella stanchezza della guerra patita dai soldati stessi. Il loro temporaneo ritorno a casa in licenza squarcia il velo della censura e rivela ai familiari un quadro della guerra molto diverso da quello della retorica ufficiale.
Queste manifestazioni contro la guerra si collegavano senza dubbio con un’azione dal fronte verso il paese [...] Ecco su che cosa fondo la mia convinzione. Coincidenza di tempo: le licenze invernali. Le donne si muovevano all’arrivo degli uomini dal fronte. Indipendenza dal fattore politico: le dimostrazioni di donne [...] sono avvenute in tutta Italia, senza che si possa distinguere tra l’Italia socialista (Italia rossa) ed il rimanente dell’Italia. Dimostrazioni di donne si ebbero in Calabria, dimostrazioni di donne si ebbero in Sicilia dove il socialismo non esiste, né esistono forme di organizzazione di partito contro la guerra10.
In tempo di guerra le popolazioni civili sono forzosamente chiamate ad ampliare le proprie soglie di tolleranza, sopportando i costi massimi che le istituzioni possono loro imporre: vite umane in trincea, razionamento dei generi alimentari ma anche caroviveri, file ai negozi, sostituzione dei richiamati sotto le armi in uffici e stabilimenti, riconversione della produzione. Sono prezzi ancora possibili da pagare finché prevale l’idea di una guerra breve e quindi di restrizioni con una durata limitata nel tempo. Ma quando l’illusione della brevità svanisce, l’insofferenza torna a manifestarsi con una potenza raddoppiata.
Nei moti popolari confluisce allora il senso di una autodifesa collettiva dalle pretese del potere. A stemperarlo vale solo l’incentivo del sacrificio patriottico: l’idea del «bene supremo della Patria» che deve mettere insieme governanti e governati. Almeno per chi ci crede: vale a dire i possessori di patrimoni sul suolo nazionale (terre o fabbriche che siano) da difendere contro ogni invasione straniera e l’arcipelago di mestieri e professioni del ceto medio urbano – negozianti, impiegati pubblici e privati, avvocati, medici, ingegneri – accomunati dall’unica ideologia (quella nazionalista) capace di tenere insieme condizioni di vita così diverse e nello stesso tempo di nutrire l’ambizione di una scalata sociale, via dal proletariato e verso la borghesia. Ma presso gli strati bassi dell’opinione pubblica, i contadini e gli operai, che pure sono più degli altri chiamati a rischiare la propria vita sotto le armi, il mito della patria vale molto meno. Non solo perché i benefici che possono scaturirne appaiono poco concreti; non solo perché i bassi livelli di scolarizzazione – nel 1921 un terzo degli italiani non sa né leggere né scrivere – impediscono a molti l’uso dell’italiano e quindi la mera comprensione dei manifesti di propaganda antiaustriaca. Ma anche perché si è diffusa da tempo un’idea diversa, che fa leva sulla condizione comune del lavoro dipendente per dipingere un futuro socialista e che presenta il vantaggio immediato e pratico di essere pacifista e antimilitarista, contraria alla guerra. Principi che la Seconda Internazionale ha solennemente riaffermato nel suo congresso di Basilea (1912). Con un esito paradossale rispetto ai propri intenti unificanti, il nazionalismo finisce per polarizzare ulteriormente la società civile tra due fronti che non si parlano più.
In realtà, la guerra distrugge l’«economia morale» che presiedeva ai vecchi tumulti per il pane di epoca preindustriale, come quelli raccontati da Manzoni nei Promessi sposi. A quel tempo l’ordine sociale era considerato immutabile e le guerre le combattevano soldati di professione, non i coscritti di leva. E si poteva ritenere condivisa anche da chi era analfabeta l’idea – alla base dell’antropologia economica di Polanyi – che tra gli abitanti della stessa città e di qualsiasi ceto e condizione valessero non solo i rapporti fissati dalle leggi dello stato e i rapporti fissati dal libero mercato e dalle sue intrinseche ineguaglianze, ma anche rapporti di reciprocità per cui almeno il pane doveva rientrare tra i diritti non scritti della plebe e doveva avere un giusto prezzo. La reciprocità, in altre parole, fissava un limite «morale» a una ineguaglianza considerata «naturale». Quando il prezzo del pane (elemento base della dieta alimentare quotidiana e quindi della sopravvivenza) esorbitava tale limite, l’assalto ai forni dove veniva prodotto diventava lo strumento per ricordare ai potenti la reciprocità e non per fare la rivoluzione11.
Almeno in teoria il conflitto armato determina uno stato di emergenza e in tutta Europa le istituzioni centrali e periferiche cercano di mettere a regime i rapporti di reciprocità attraverso politiche di razionamento della distribuzione e di calmiere dei prezzi. Ma la guerra che si combatte dal 1914 è radicalmente diversa da tutte le precedenti perché è la prima guerra di massa, che schiera eserciti non mercenari, fondati sul richiamo obbligatorio sotto le armi di un’intera generazione di maschi appena adulti. Quando questi ragazzi cominciano a morire, ogni rapporto di reciprocità sparisce. Questa nuova guerra di massa distrugge la reciprocità perché distribuisce i propri costi, anzitutto in termini di vite umane, in maniera ineguale. Poveri e ricchi, fanti e ufficiali non muoiono allo stesso modo e nella stessa quantità. Il tumulto quindi acquisisce una fisionomia del tutto nuova, seppur dentro una veste antica: non per caso sono spesso le donne ad assumerne la guida. E sono sempre donne a iniziare l’8 marzo 1917 la rivoluzione di febbraio in Russia (il calendario giuliano che lì è ancora in vigore anticipa di tredici giorni quello del calendario gregoriano) con un corteo che chiede alla Duma (il parlamento russo) pane e pace12.
Non solo in Europa ma anche (e forse soprattutto) nell’Asia di Gandhi, Mao Zedong, Ho Chi Minh, la guerra incrina il senso di superiorità della civiltà ...