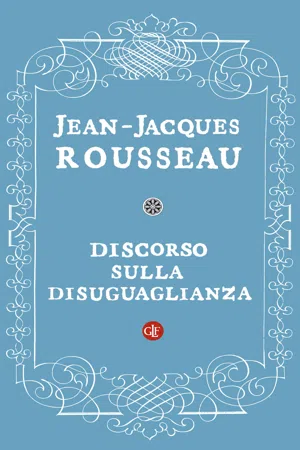Note
Nota A. Erodoto racconta che dopo l’uccisione del falso Smerdi87, essendosi i sette liberatori della Persia riuniti per deliberare a proposito della forma di governo che avrebbero dato allo Stato, Otane si pronunciò decisamente in favore della repubblica; parere tanto più straordinario in bocca a un satrapo, non solo perché avrebbe potuto pretendere al comando, ma in quanto i grandi temono più della morte una forma di governo che li costringa a rispettare gli uomini. Otane, si può ben crederlo, non fu ascoltato, e, vedendo che si stava per procedere all’elezione di un monarca, lui, che non voleva né obbedire né comandare, cedette spontaneamente agli altri candidati il suo diritto alla corona, chiedendo come solo compenso, per sé e per i suoi discendenti, libertà e indipendenza: il che gli fu accordato. Se anche Erodoto non ci informasse della restrizione imposta a questo privilegio, dovremmo necessariamente supporla; altrimenti Otane, non riconoscendo leggi di sorta e non dovendo render conto di nulla a nessuno, sarebbe stato onnipotente nello Stato e più potente dello stesso re. Ma non sembrava probabile che un uomo capace di contentarsi, in tali circostanze, di un tale privilegio, fosse capace di abusarne. Infatti non risulta che questo diritto abbia mai cagionato il minimo turbamento nel regno, per opera del saggio Otane o di alcuno dei suoi discendenti.
Nota B. Fin dall’inizio mi appoggio fiduciosamente su una di quelle autorità che godono il rispetto dei filosofi in quanto derivano da una ragione solida e sublime che i filosofi soli sanno trovare e sentire88.
«Per grande che sia il nostro interesse a conoscere noi stessi, mi viene il dubbio che conosciamo meglio tutto ciò che è altro da noi. Dotati da natura di organi destinati soltanto alla nostra conservazione, li usiamo unicamente per ricevere le impressioni esteriori, cercando solo di espanderci fuori di noi e di esistere fuori di noi; troppo impegnati a moltiplicare le funzioni dei nostri sensi e ad aumentare l’estensione esteriore del nostro essere, di rado ci serviamo di quel senso interno che ci riporta alle nostre vere dimensioni e che separa da noi tutto ciò che è altro da noi. Tuttavia, se vogliamo conoscerci, dobbiamo servirci di quel senso; è il solo che ci permetta di giudicare noi stessi. Ma come dare a questo senso la sua attività e tutta la sua estensione? Come liberare l’anima nostra, in cui esso ha sede, di tutte le illusioni del nostro spirito? Abbiamo perduto l’abitudine di farne uso; l’anima è rimasta inattiva in mezzo al tumulto delle nostre sensazioni corporee; il fuoco delle nostre passioni l’ha inaridita; il cuore, lo spirito, il senso, tutto ha congiurato contro di lei». (Hist. nat., t. 4, p. 151, della natura dell’uomo).
Nota C. I mutamenti che la lunga consuetudine di camminare sui due piedi ha potuto produrre nella conformazione dell’uomo, i rapporti che ancora si osservano fra le sue braccia e le gambe anteriori dei quadrupedi, ciò che si ricava dalla loro maniera di camminare, hanno potuto far nascere dei dubbi su quella che doveva essere più naturale per noi. Tutti i bambini cominciano col camminare a quattro zampe e per imparare a stare in piedi hanno bisogno del nostro esempio e dei nostri insegnamenti. Ci sono anche popoli selvaggi come gli Ottentotti che, trascurando parecchio i bambini, li lasciano camminare con le mani e coi piedi così a lungo da durar poi una gran fatica per abituarli a star ritti. Lo stesso dicasi dei bambini dei Caraibi, nelle Antille. Si hanno diversi esempi di uomini quadrupedi, e potrei citare fra gli altri quello del bambino che fu trovato nel 1344, presso Hesse, dove era stato nutrito dai lupi; in seguito, alla corte del principe Enrico, diceva che, se fosse dipeso da lui, avrebbe preferito tornare fra loro piuttosto che vivere fra gli uomini. Aveva preso a tal segno l’abitudine di camminare come quegli animali che fu necessario legargli addosso dei pezzi di legno per costringerlo a star ritto, in equilibrio sui due piedi. Altrettanto dicasi del bambino trovato nel 1694 nelle foreste della Lituania, che viveva tra gli orsi. Non dava, racconta Condillac89, nessun segno di ragione, camminava sulle mani e sui piedi, non usava nessun linguaggio, ed emetteva suoni che in nulla somigliavano a quelli degli uomini. Il piccolo selvaggio di Annover che parecchi anni fa90 fu condotto alla corte d’Inghilterra durava grandissima fatica ad adattarsi a camminare su due piedi, e nel 1719 si trovarono nei Pirenei altri due selvaggi che correvano per le montagne alla maniera dei quadrupedi. Quanto all’eventuale obbiezione che ciò significherebbe privarsi dell’uso delle mani da cui ricaviamo tanta utilità, a parte l’esempio delle scimmie che ci mostra come la mano possa essere usata benissimo in entrambe le maniere, proverebbe soltanto che l’uomo può assegnare alle sue membra finalità più comode di quelle naturali, non che la natura ha destinato l’uomo a camminare diversamente da come essa gl’insegna.
Ma per sostenere che l’uomo è un bipede si possono, mi pare, addurre ragioni molto migliori. In primo luogo, quand’anche si dimostrasse che in origine poteva essere conformato diversamente da come lo vediamo e tuttavia finire col diventare com’è, questo non basterebbe per concludere che le cose sono andate così: infatti, messa in luce la possibilità di tali mutamenti, prima di ammetterli bisognerebbe anche mostrarne almeno la verosimiglianza. Inoltre, se pare che le braccia dell’uomo abbiano potuto, in caso di necessità, servirgli da gambe, questa è la sola osservazione favorevole alla teoria in questione, di fronte a un gran numero di altre a sfavore. Fra queste le principali sono: che la testa dell’uomo è attaccata al corpo in modo che, invece di dirigere la sua vista orizzontalmente, come avviene in tutti gli animali e nell’uomo stesso quando procede su due piedi, gli avrebbe tenuto, quando avesse camminato a quattro piedi, gli occhi fissi direttamente a terra, posizione assai poco favorevole alla conservazione dell’individuo; che la coda che gli manca e di cui, camminando su due piedi non saprebbe che fare, è utile ai quadrupedi, che non ne sono mai privi; che il seno della donna, molto ben collocato per un bipede che tiene in braccio il figlio, sarebbe per un quadrupede in una posizione così sfavorevole che in nessun quadrupede si presenta mai a quel modo; che, essendo il treno posteriore troppo alto in rapporto alle gambe anteriori – per cui camminando a quattro zampe ci trasciniamo sui ginocchi – ne sarebbe risultato un animale mal proporzionato e impedito nel camminare; che se l’uomo avesse appoggiato il piede piatto come la mano avrebbe avuto nella gamba posteriore un’articolazione di meno degli altri animali, cioè quella che unisce lo stinco alla tibia; e se d’altra parte, avesse poggiato solo sulla punta dei piedi, come senza dubbio sarebbe stato costretto a fare, il tarso, per non parlare delle numerose ossa che lo costituiscono, sarebbe risultato troppo grosso per sostituire lo stinco, e le sue articolazioni col metatarso e la tibia troppo ravvicinate per conferire alla gamba umana in questa posizione la flessibilità delle gambe dei quadrupedi. Prendere come esempio i bambini nell’età in cui le forze naturali non sono ancora sviluppate né le membra consolidate, non serve a nulla; tanto varrebbe, secondo me, dire che i cani non sono destinati a camminare perché a qualche settimana dalla nascita si limitano a strisciare. Gli esempi particolari hanno ancora scarso rilievo di contro alla pratica universale di tutti gli uomini, anche di popoli che privi di qualunque comunicazione con gli altri non potevano imitarli in nulla. Un bambino abbandonato in una foresta prima d’essere in grado di camminare, e nutrito da qualche bestia, avrà seguito l’esempio della nutrice esercitandosi a camminare allo stesso modo; l’abitudine lo avrà potuto facilitare in cose che non gli erano naturali; e come certi monchi, a forza di esercitarsi, arrivano a fare coi piedi tutto ciò che noi facciamo con le mani, sarà arrivato, alla fine, a usare le mani come piedi.
Nota D. Se ci fosse tra i miei lettori qualche scienziato così sprovveduto da muovermi delle obbiezioni sulla supposizione della naturale fertilità della terra, lo rimanderei al seguente passo: «Poiché i vegetali traggono per il loro nutrimento molta più sostanza dall’aria e dall’acqua che non dalla terra, accade che, quando si corrompono, restituiscano alla terra più di quanto non ne abbiano ricavato; d’altronde una foresta, trattenendo i vapori, determina la pioggia. Così in un bosco serbato a lungo intatto lo strato di terra che serve alla vegetazione aumenterebbe considerevolmente; ma poiché gli animali rendono alla terra meno di quanto ne traggono e gli uomini consumano enormi quantità di legname e di piante per il fuoco e per altri usi, lo strato di terra vegetale di un paese abitato deve sempre diminuire e divenire alla fine come il terreno dell’Arabia Petrea e di tante altre province dell’Oriente, che, effettivamente, è il paese abitato da più tempo, dove si trovano solo sale e sabbia: infatti il sale fisso delle piante e degli animali resta, mentre tutte le altre parti si volatilizzano» (Buffon, Hist. Nat.)91.
A ciò si può aggiungere la prova di fatto offerta dalla quantità di alberi e di piante di ogni specie di cui erano piene quasi tutte le isole deserte scoperte negli ultimi secoli, e da quanto la storia c’insegna delle immense foreste che si sono dovute abbattere su tutta la terra via via che si è popolata o civilizzata. In proposito aggiungerei questi tre rilievi. In primo luogo, se c’è un tipo di vegetazione che possa compensare il consumo di materia vegetale dovuto agli animali, secondo il ragionamento di Buffon, esso è costituito dai boschi che con le cime e con le foglie raccolgono e trattengono più acqua e più vapori delle altre piante. In secondo luogo, la distruzione del suolo, cioè la perdita di sostanza adatta alla vegetazione, deve accelerarsi in rapporto alla maggior coltivazione della terra e al maggior consumo di prodotti agricoli di ogni specie da parte di uomini più industriosi. La mia terza e più importante osservazione è che i frutti degli alberi offrono all’animale un nutrimento più abbondante di quanto non possano fare gli altri vegetali: ne ho fatto l’esperienza da me stesso paragonando i prodotti di due terreni, uguali per grandezza e qualità, l’uno coperto di castagni, l’altro seminato a grano.
Nota E. Fra i quadrupedi i due caratteri distintivi più generali delle specie carnivore sono offerti dalla forma dei denti e dalla conformazione degl’intestini. Gli animali che si nutrono esclusivamente di vegetali hanno sempre i denti piatti, come il cavallo, il bove, il montone, la lepre; i carnivori invece li hanno appuntiti: come il gatto, il cane, il lupo, la volpe. Quanto agli intestini, gli erbivori ne hanno qualche parte, come il colon, che nei carnivori manca. Parrebbe dunque che l’uomo, provvisto di denti e di intestini analoghi a quelli degli erbivori, si debba naturalmente collocare in questa classe, e tale opinione non solo è confermata dalle osservazioni anatomiche, ma trova largo appoggio nei monumenti dell’antichità. San Girolamo dice92: «Dicearco, nei suoi libri sull’antichità greca, riferisce che sotto il segno di Saturno, quando la Terra era ancora spontaneamente fertile, nessun uomo mangiava carne, vivendo tutti di frutti e legumi che crescevano naturalmente» (L. II, Adv. Jovinianum)93. Di qui si vede che tralascio molti elementi a favore che potrei far valere. Essendo infatti la preda quasi la sola causa di lotta fra i carnivori, e vivendo gli erbivori fra loro in una pace costante, se la specie umana fosse appartenuta a questo genere, evidentemente le sarebbe stato molto più facile sussistere nello stato di natura e il suo bisogno e le sue occasioni di uscirne sarebbero stati molto minori.
Nota F. Tutte le conoscenze che richiedono riflessione, che si acquistano solo col concatenarsi delle idee perfezionandosi soltanto in seguito, sembrano essere del tutto fuori portata per il selvaggio, per mancanza di comunicazione coi suoi simili, ossia perché gli mancano lo strumento che serve a tale comunicazione e i bisogni che la rendono necessaria. Il suo sapere e la sua abilità si riducono al salto, alla corsa, alla lotta, a lanciare un sasso, a dar la scalata a un albero. Ma se sa solo queste cose, le sa, in compenso, molto meglio di noi, che non ne abbiamo la stessa necessità, e, dipendendo esse unicamente dall’esercizio del corpo senza possibilità alcuna di comunicazione o di progresso da un individuo all’altro, il primo uomo ha potuto eccellere in esse quanto i suoi più tardi discendenti.
Le relazioni dei viaggiatori sono piene di esempi della forza e del vigore degli uomini presso i popoli barbari e selvaggi; né vantano meno la loro destrezza e agilità; e, bastando gli occhi per osservare questo genere di cose, niente impedisce di prestar fede alle testimonianze in proposito dei testimoni oculari. Scelgo a caso qualche esempio dai primi libri che mi capitano sotto mano.
«Gli Ottentotti, dice Kolben94, s...