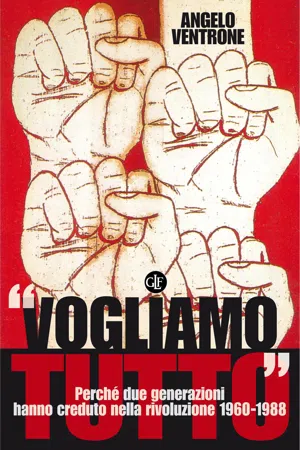
eBook - ePub
"Vogliamo tutto"
Perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1988
Angelo Ventrone
This is a test
- 400 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
"Vogliamo tutto"
Perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1988
Angelo Ventrone
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Come mai tanti giovani appartenenti ai gruppi della sinistra rivoluzionaria hanno creduto di poter cambiare il mondo?Come volevano cambiarlo e per quali ragioni?Perché a un certo momento hanno cominciato a pensare che la violenza fosse lo strumento necessario per realizzare questo sogno?Perché davano per scontato che la rivoluzione fosse il passaggio obbligato per accedere a una vita degna di essere vissuta, a una vita autentica?Angelo Ventrone indaga alcuni decenni della storia recente del nostro paese, dal 1960 fino alla fine degli anni Ottanta, per capire cosa è accaduto e cosa è restato di quei sogni e di quelle ribellioni.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is "Vogliamo tutto" an online PDF/ePUB?
Yes, you can access "Vogliamo tutto" by Angelo Ventrone in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Historia & Historia del siglo XXI. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
HistoriaSubtopic
Historia del siglo XXIVII. Violenza diffusa e lotta armata
Ma cos’è la rivoluzione?
Come abbiamo visto, negli anni ’60 e in maniera ancora più decisa negli anni ’70, una contraddizione balza subito agli occhi rispetto alle aspettative rivoluzionarie: solo nei gruppi più ortodossi (l’Uci, ad esempio) si parlava di cosa sarebbe accaduto una volta preso il potere. Negli altri, le indicazioni erano sempre molto ottimistiche, ma anche molto generiche. Nel 1977, «A/traverso», la rivista dell’Autonomia bolognese, ad esempio scriveva: «Il movimento che riuscirà a distruggere la gigantesca macchina burocratica capitalistica sarà a fortiori sicuramente capace di costruire un altro mondo – la capacità collettiva gli verrà strada facendo, senza che sia necessario [...] architettare dei “progetti di società” di ricambio»[461]. Il che voleva dire che la rivoluzione non sarebbe nata dall’opera di un centro decisionale, il partito-guida, ma sarebbe stata realizzata dal basso, in una convergenza spontanea di esperienze che mentre distruggevano il vecchio mondo, producevano quello nuovo.
Eccoci allora tornare alle considerazioni da cui siamo partiti, che vedevano nell’affluent society lo sfondo naturale della protesta. Il vero problema non era più produrre ricchezza, traguardo ormai raggiunto, quanto permetterne il godimento a tutti coloro a cui ne era impedito l’accesso. Un documento delle Brigate Rosse avrebbe chiarito bene la questione: proprio perché, grazie all’altissima capacità produttiva raggiunta dalla «metropoli imperialista» era data finalmente la condizione materiale per eliminare immediatamente, insieme al capitalismo, anche la «maledizione del lavoro sfruttato», si poteva evitare di ripetere la strada percorsa da altre rivoluzioni nel passato. Ora, la dittatura proletaria non avrebbe più dovuto aspettare, come in Unione Sovietica, di passare attraverso una fase in cui il modo di produzione capitalistico sarebbe stato conservato, perché era ormai possibile «una diretta e immediata transizione al comunismo»[462].
Queste posizioni sarebbero state sostenute, quasi con le stesse parole, anche da tante altre formazioni. Dai Comitati Comunisti Rivoluzionari, legati all’Autonomia Operaia, ad esempio, o da Azione Rivoluzionaria, un altro gruppo armato più movimentista delle Br ma loro ideologicamente vicino, che spiegava come sarebbe stata una società comunista. Il «comunismo – affermava un suo documento – è avvento del regno della gratuità, scomparsa del denaro, del valore di scambio, fine della peste mercantile che ha pervaso ogni piega dell’esistenza umana. Abolizione dell’economia con tutte le sue categorie: salario, prezzo, profitto [...] soddisfazione illimitata dei desideri e dei bisogni umani, realizzazione piena della libertà di vivere secondo il proprio piacere e le proprie inclinazioni»[463].
Con l’eccezione per l’appunto di chi si limitava a ripetere l’ortodossia leninista o maoista, nessun gruppo è dunque mai riuscito in quegli anni a definire la propria idea di rivoluzione se non come fenomeno, per così dire, processuale, che si sarebbe cioè chiarito nel corso dello stesso processo rivoluzionario. Un’idea che, se volessimo collocarla nelle categorie novecentesche, apparirebbe più di matrice anarco-sindacalista che leninista. In effetti, come ha ricordato Adriano Sofri, il leader dell’organizzazione più movimentista, Lotta Continua: «Non mi sono mai prefisso risultati nelle lotte cui partecipavo o che capeggiavo [...]. Il risultato era la lotta» stessa[464].
Anche nelle Brigate Rosse, quando si arrivava a discutere della questione si diceva: «quando avremo vinto, ne parleremo...». Nemmeno loro hanno mai chiarito né quale fosse il loro progetto di disarticolazione e di distruzione dello Stato, né le modalità della presa del potere, le tappe, i passaggi, i risultati intermedi di questo possibile processo. Lo Stato andava abbattuto? Ci sarebbe stata una presa del potere? Un governo rivoluzionario? E prima ancora, ci sarebbe stata una lotta armata aperta?[465] In effetti, non c’erano idee precise a riguardo, ma solo un generico ottimismo che faceva pensare che in cinque, dieci, al massimo venti anni, la vittoria sarebbe inevitabilmente arrivata.
Antonio Savasta, passato da Potere Operaio, all’Autonomia e poi alle Br, ha infatti ricordato che se nell’organizzazione non si parlava apertamente di tali questioni, lo facevano però i singoli militanti tra di loro, in modo informale. E immaginavano la società del domani, molto semplicemente, come una «democrazia diretta, l’immagine del soviet, fatta di luoghi e di situazioni in cui poter decidere direttamente di tutto e della propria vita». Ovvero, come un momento di «festa e di gioia», di «persone che scoprivano giorno per giorno le proprie possibilità, e quindi si responsabilizzavano su tutto e cominciavano a decidere del proprio posto di lavoro, della produzione, dell’educazione dei propri figli [...] in cui la violenza non c’era più». Ma alla domanda specifica sul perché nell’organizzazione non si parlasse di queste cose, ha risposto: «Non lo so. Non se ne parlava e chi lo sa?».
In effetti, sono numerose le testimonianze su come questo nodo, che si trascinava irrisolto dagli anni ’60, rimanesse tale anche nelle formazioni armate. Come ha ricordato, ad esempio, Paolo Lapponi, un ex militante di Potere Operaio poi passato alle Unità Comuniste Combattenti: «indubbiamente, quello che pensavo io – bisognerebbe [dire] quello che pensavamo noi – e ciò che noi ci prefiguravamo era qualche cosa di estremamente vago, perché al di là del momento della rottura rivoluzionaria non si andava. Non c’era mai stato un discorso su che cosa noi intendevamo per società comunista, società rivoluzionaria. Tutti i nostri discorsi erano in negativo sulla società presente, ma non erano mai in positivo su una eventuale società futura [...]. Andavamo incontro a un grossissimo punto interrogativo che non aveva risposta di nessun tipo»[466].
Ancora all’inizio degli anni ’80, le Brigate Rosse-Partito della Guerriglia – guidate da Giovanni Senzani e dalla breve vita, visto che, nate nel 1981 dalla scissione dalla formazione madre della colonna napoletana e dei componenti del Fronte Carceri, avrebbero cessato la loro attività dopo un’ondata di arresti già alla fine del 1982 – avrebbero individuato il «Programma di Transizione al Comunismo» articolandolo nel modo seguente: «Lavorare tutti, lavorare meno [...] Ricomposizione del lavoro manuale e del lavoro intellettuale [...] Abolizione della proprietà privata e riappropriazione sociale della ricchezza [...] Riqualificazione della produzione, del rapporto uomo-natura [...] effettivo internazionalismo proletario»[467]. Questioni certamente non originali, in cui l’ortodossia marxista era stemperata dal linguaggio operaista ripreso dai documenti prodotti dall’Autonomia Operaia.
Ma i punti di contatto tra le varie formazioni rivoluzionarie erano anche altri. Ad esempio, la convinzione che la battaglia per il potere coinvolgesse ormai l’intera società. Ciò voleva dire che la liberazione collettiva non poteva essere risolta solo con la conquista del Palazzo d’inverno, ovvero del cuore del potere. Questo cuore, inteso come luogo fisico, infatti non esisteva più, perché ormai il potere aveva i mezzi per giungere in ogni piega della società e conquistarla, per così dire, dall’interno.
Anche il riferimento delle Brigate Rosse all’attacco al «c...