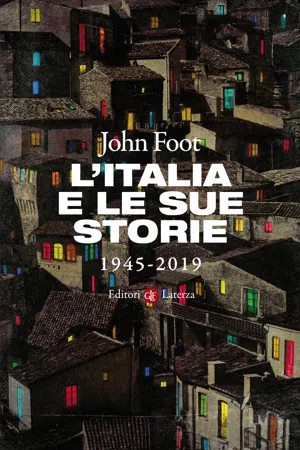
L'Italia e le sue storie
1945-2019
John Foot
- 432 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
L'Italia e le sue storie
1945-2019
John Foot
About This Book
«L'Italia conta, e non solo per gli italiani. Tutt'altro che marginale in Europa, la penisola è sempre stata al centro del cambiamento e dell'innovazione politica. Nel bene e nel male – come dicono gli italiani – questo è un paese dal quale abbiamo molto da imparare.»
Una storia che si legge d'un fiato, capace di portare alla luce vicende complesse con chiarezza e semplicità."Sunday Times"
Una ricerca superba."Observer"
Un viaggio divertente e mozzafiato (e a tratti disperante) nell'Italia del dopoguerra. Una lettura che è un piacere, piena di personaggi, aneddoti e fatti affascinanti.Donald Sassoon, "Literary Review"
La storia d'Italia è contraddistinta da rivoluzioni brevi e controrivoluzioni prolungate. Dal 1945 ci sono stati momenti in cui è sembrata lanciata a tutto vapore verso il futuro, e altri in cui è apparsa bloccata, come da un sortilegio. Ma sempre sono singoli individui a spezzare il maleficio, a mutare il corso della storia. Ci sono stati italiani comuni che hanno cambiato il loro paese: la donna che rifiutò il matrimonio a dispetto delle convenzioni sociali, lo psichiatra che disse 'no' alle pratiche della repressione e della deumanizzazione, il magistrato che non si piegò alle pressioni politiche, il prete deciso a dare un'istruzione decente anche ai bambini più poveri, il cineasta che provò a costruire bellezza dal caos della guerra. Queste storie ci aiutano a capire l'Italia e i suoi contrasti: la sua meravigliosa indipendenza e le sue soffocanti continuità.