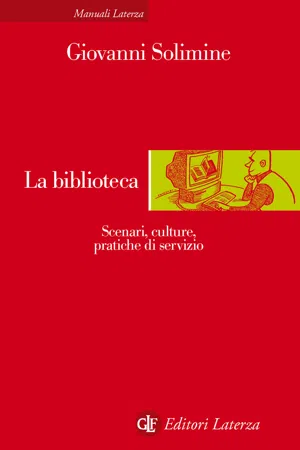
eBook - ePub
La biblioteca
Scenari, culture, pratiche di servizio
Giovanni Solimine
This is a test
- 278 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
La biblioteca
Scenari, culture, pratiche di servizio
Giovanni Solimine
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
La rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente i modi della produzione e le dinamiche dell'organizzazione e della circolazione del sapere. Uno studio completo sulla biblioteca contemporanea che è anche un manuale di biblioteconomia.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is La biblioteca an online PDF/ePUB?
Yes, you can access La biblioteca by Giovanni Solimine in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Bookkeeping & Budgets. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1. L’universo digitale e l’accesso alla conoscenza
1. Il quadro di riferimento
Una delle principali caratteristiche della società in cui viviamo può essere individuata nelle trasformazioni che investono la circolazione della conoscenza.
L’enorme quantità di documentazione e informazione che viene prodotta ogni giorno rappresenta uno degli elementi costitutivi della vita quotidiana di milioni di persone che hanno bisogno di accedere in modo completo, affidabile e tempestivo a questi documenti – e, prima ancora, ai servizi e alle informazioni attraverso cui reperirli – per poter esercitare i propri diritti di cittadinanza, per poter partecipare alla vita collettiva, per poter svolgere la propria attività lavorativa, per poter utilizzare in modo intelligente il proprio tempo libero. Per indicare questa necessità di aggiornare costantemente il proprio bagaglio di conoscenze e di competenze, informandosi e documentandosi durante tutto l’arco dell’esistenza, è stata coniata l’espressione società dell’apprendimento: l’attività di studio, infatti, non si esaurisce con la fase iniziale della vita, quella durante la quale ci si forma e ci si prepara ad entrare nel meccanismo produttivo, né riguarda soltanto quei lavoratori intellettuali che fanno dello studio il proprio lavoro abituale. Anche se in misura diversa e con caratteristiche differenti il problema si pone per tutti, indipendentemente dal tipo di attività svolta e non solo in funzione di essa, poiché se si è tagliati fuori dai flussi informativi risulta depotenziata anche la capacità di partecipare alla vita associata.
Oltre venti anni fa Jean-François Lyotard aveva intuito le conseguenze che le trasformazioni in atto nei processi di trattamento e trasferimento delle informazioni, iniziate almeno a partire dalla fine degli anni Cinquanta del XX secolo, erano destinate ad avere e aveva previsto che esse avrebbero coinvolto la natura stessa del sapere: secondo lui, infatti, il sapere e le istituzioni che lo producono cambiano di statuto con il passare delle società nell’età postindustriale e con il passare delle culture nell’età postmoderna1. Oggi possiamo constatare che le tecnologie digitali, ad esempio, consentono di utilizzare in maniera integrata e convergente codici di comunicazione differenti e portano alla nascita di nuovi linguaggi e nuovi saperi.
Ciò che invece neppure i futurologi più attenti erano riusciti a immaginare in tutti i suoi effetti penetranti era la portata che avrebbe assunto lo sviluppo della rete: al di là delle stime sulla sua crescita quantitativa, è fuori di dubbio che Internet è il mezzo di comunicazione che si è diffuso più rapidamente nella storia dell’umanità. Ma non avremmo compreso fino in fondo questo fenomeno se lo identificassimo solo con le tecnologie che esso utilizza e con la capillarità della sua diffusione: la dimensione di rete investe il modo di produrre e diffondere la conoscenza, il modo di aggregare interessi e formare comunità, il modo stesso di lavorare e di vivere. E che non si tratti solo di un problema di ‘accesso’ alla conoscenza, ma di partecipazione attiva, è dimostrato dal fatto che la principale opportunità legata alla comunicazione reticolare consiste nel passaggio dal flusso da uno a uno oppure da uno a molti alla comunicazione da molti a molti, poiché «in rete è estremamente facile passare dal ruolo spesso passivo di ‘destinatario’ del messaggio, di ‘ascoltatore’, al ruolo attivo di chi crea e diffonde un messaggio, al ruolo cioè di emittente»2.
In questo senso possiamo dire che ciò che accade in questo ambito specifico è rapportabile a fenomeni ben più vasti e complessi, come quello della globalizzazione. La rivoluzione culturale che Internet ha prodotto, qualunque sia il giudizio che se ne vuole dare, è profondissima e induce a porsi un interrogativo altrettanto penetrante: cosa si può fare per evitare che un così potente fattore di crescita, e di per sé stesso anche di democratizzazione nell’accesso alla conoscenza, divenga al tempo stesso un elemento di forte discriminazione?
I dati sull’evoluzione di questo fenomeno invecchiano molto rapidamente e per fortuna si muovono, sia pure lentamente, in direzione di un riequilibrio, anche se permangono forti disuguaglianze. Soltanto qualche anno fa, nel 1999, il 5% della popolazione mondiale, e cioè quella residente negli Stati Uniti, costituiva da sola più della metà dell’utenza di Internet3, mentre nel marzo 2004 la percentuale era scesa sotto il 30% e quella degli utenti di lingua inglese era pari complessivamente al 35,8%4. A quella data la popolazione mondiale di utilizzatori di Internet che disponeva di un accesso da casa veniva stimata in circa 730 milioni di persone5 e si incrementava del 4% al trimestre: 204 milioni di americani, 52,9 milioni di tedeschi, 34,4 milioni di inglesi, 24,3 milioni di italiani (il 3,3% del totale mondiale), 28 milioni di francesi avevano un collegamento alla rete. La crescita è esponenziale: nel nostro paese le connessioni coprivano nel 1997 il 2% della popolazione e nel 2002 il 38% (ma altri paesi crescono ad un ritmo maggiore: infatti nell’ultimo anno la ‘presenza’ italiana in Internet è calata dal 4 al 3,3% dell’utenza mondiale). Anche la diffusione nelle famiglie europee sta diventando capillare: limitatamente agli ultimi anni, notiamo che la percentuale di famiglie che dispone di una connessione è passata dal 18,3% del marzo 2000 al 42,6% del novembre 20026.
Si accennava alle disuguaglianze e ai rischi connessi a queste forme di tecno-apartheid7: l’Asia intera rappresenta solo il 14% dell’utenza mondiale di Internet e l’America Latina il 3%, e si pensi che nella sola città di Tokyo esistono più apparecchi telefonici che in tutto il continente africano, come è stato autorevolmente denunciato qualche tempo fa dal segretario generale delle Nazioni Unite8.
Si va diffondendo sempre di più la consapevolezza di alcuni pericoli generati dalle modalità con cui la conoscenza viene oggi distribuita. Il mondo accademico sta reagendo alla crisi della comunicazione scientifica attraverso la costituzione di consorzi per garantire l’accessibilità della letteratura specialistica; il mondo degli studi e delle professioni ha dato vita ai portali verticali per organizzare un accesso ordinato alle risorse presenti nel Web e pertinenti ai diversi ambiti specifici; le reti civiche, insieme a siti e portali della pubblica amministrazione, tentano di rendere più agevoli i rapporti tra i cittadini e la documentazione di fonte pubblica. Si potrebbero portare numerosi altri esempi degli sforzi con i quali si cerca di fronteggiare le difficoltà che si sono venute a determinare.
All’interno di questo quadro di riferimento complessivo, sui cui contorni ci sarà modo di ritornare, e con questa chiave di lettura, analizzeremo il ruolo della biblioteca nella società contemporanea, i riferimenti culturali e ideali che fanno da sfondo alla sua azione, i processi che in essa si determinano, i metodi e le tecniche con le quali essa organizza e gestisce i suoi servizi.
In particolare, questo capitolo di apertura intende osservare i problemi delle forme di produzione e circolazione della conoscenza che caratterizzano la nostra società e dei diversi contesti in cui esse si manifestano – dalla comunicazione scientifica a quella che fa riferimento alle amministrazioni pubbliche, dal complesso mondo dell’e-learning al mondo dell’intrattenimento – guardandoli dal punto di vista del ruolo che possono esercitare i servizi pubblici di accesso alla conoscenza, come le biblioteche e gli altri istituti che operano nel campo della documentazione. Ciò nella convinzione che esiste la possibilità, e forse la necessità, di riproporre e rilanciare i valori fondamentali su cui si fondano la biblioteca e la professione del bibliotecario, come ha affermato recentemente Michael Gorman9.
Una presenza incisiva delle biblioteche in questo contesto si fonda anche sulla consapevolezza di quella che è stata in passato la loro funzione, sintetizzabile ora come allora nel favorire l’incontro fra gli utenti, da una parte, e i documenti che essi vorrebbero utilizzare, dall’altra. Se condividiamo questa impostazione, possiamo dire che l’evoluzione della biblioteca, delle discipline che ne regolano il funzionamento e del profilo dei professionisti che vi lavorano consiste proprio nel continuare ad esercitare questa funzione attraverso un lavoro di continuo e progressivo adeguamento, a mano a mano che si modificano i bisogni del pubblico, che si modificano le forme di produzione e circolazione del sapere e dei documenti in cui esso è registrato, che si presenta l’esigenza di elaborare ed utilizzare nuovi strumenti di lavoro.
Si tratta di conciliare questa evoluzione, che sembra riconducibile ad una sostanziale continuità, con quanto in precedenza abbiamo detto anche in riferimento alle posizioni di Lyotard, vale a dire con le conseguenze pervasive di questi stessi fenomeni evolutivi, che stanno modificando la natura del sapere e la sua circolazione.
2. Il sapere e le sue forme
La storia della comunicazione è scandita da tante rivoluzioni – la scrittura, l’alfabeto, la carta, la stampa, l’elettricità, l’elettronica e le telecomunicazioni, per citare solo le tappe principali – che vanno ripercorse senza cadere in facili e banali semplificazioni, secondo le quali esse segnano un progresso lineare e ininterrotto, attraversato da concatenazioni logico-cronologiche e da eventi sempre uniti da un nesso causale. Non è così, perché gli elementi di discontinuità spesso equivalgono agli elementi di continuità o di ciclicità, così come alle situazioni che producono effetti simili in luoghi diversi si oppongono quelle che provocano effetti completamente differenti, a seconda delle circostanze.
Tradizionalmente, il ruolo delle biblioteche è per definizione legato al libro, nelle varie forme che esso è andato assumendo nei secoli, e alla comunicazione scritta. Non è questa la sede per ripercorrere il complesso e articolato dibattito su ciò che è stata la comunicazione scritta nel tempo – anche perché ciò ci porterebbe lontano dagli scopi di queste pagine – né per definire cosa sia stato e cosa sia il libro10, ma può essere utile riprendere alcuni spunti che possono esserci di aiuto per l’individuazio...
Table of contents
Citation styles for La biblioteca
APA 6 Citation
Solimine, G. (2015). La biblioteca ([edition unavailable]). Editori Laterza. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3461329/la-biblioteca-scenari-culture-pratiche-di-servizio-pdf (Original work published 2015)
Chicago Citation
Solimine, Giovanni. (2015) 2015. La Biblioteca. [Edition unavailable]. Editori Laterza. https://www.perlego.com/book/3461329/la-biblioteca-scenari-culture-pratiche-di-servizio-pdf.
Harvard Citation
Solimine, G. (2015) La biblioteca. [edition unavailable]. Editori Laterza. Available at: https://www.perlego.com/book/3461329/la-biblioteca-scenari-culture-pratiche-di-servizio-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Solimine, Giovanni. La Biblioteca. [edition unavailable]. Editori Laterza, 2015. Web. 15 Oct. 2022.