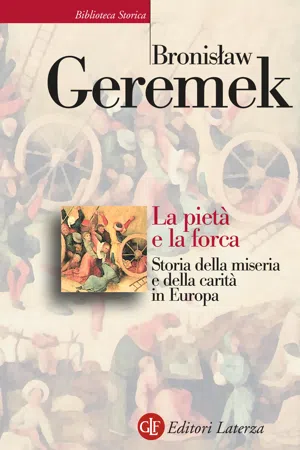III
La nuova politica sociale
Quel modello di vita sociale, le cui origini abbiamo potuto notare nelle trasformazioni dell’economia europea del XVI secolo, ha caratterizzato l’ulteriore sviluppo della civiltà dell’Europa nella successiva metà del millennio. I meccanismi di trasformazione che agivano, con diverse conseguenze e diversa intensità, nell’ambito della vita rurale e nel settore urbano che lentamente si veniva ampliando, producevano una miseria di tipo e di dimensioni senza precedenti nelle epoche passate. E così alle soglie di questo mezzo millennio riscontriamo, nell’ambito delle istituzioni sociali e della mentalità sociale, un tentativo di dare una risposta a questa «sfida del tempo».
Gli studi sulla nascita del capitalismo e sulla fase iniziale dell’espansione capitalistica hanno messo in chiaro delle differenze sostanziali all’interno di quei processi. Senza addentrarci in considerazioni particolareggiate, possiamo affermare che qui si delineano tre tipi di capitalismo nascente: l’«agrario», il «commerciale» e l’«industriale». Queste definizioni hanno carattere puramente convenzionale, visto che segnalano soltanto in quale campo si nota un più forte dinamismo nelle trasformazioni ed una più intensa accumulazione di capitale. In tutti e tre i casi il basso livello di paghe svolgeva un ruolo importante per determinare il regime di vita delle grandi masse, come strumento di queste trasformazioni, come risultato della tendenza delle classi abbienti a massimizzare il profitto. Non dappertutto si riusciva a realizzare questa tendenza. Molti dati confermano che, per esempio nei Paesi Bassi, fuori dai periodi di crisi alimentare non si riscontrava un così pronunciato e brusco calo delle paghe reali, al contrario di quanto avveniva in altri paesi. Nel secolo XVI il ribasso delle paghe reali, come ha dimostrato anni fa uno dei pionieri degli studi sulla congiuntura, Earl Hamilton, costituisce una tendenza generalizzata. L’«inflazione dei profitti», legata ad essa, stava diventando una delle leve di sviluppo del capitalismo nascente. Questo fenomeno, insieme alla necessità di creare un libero mercato della manodopera, può essere considerato come uno degli elementi che legano indissolubilmente l’evoluzione iniziale del capitalismo alla pauperizzazione. Questo spiega anche la generalizzazione del problema dei poveri nell’Europa del XVI secolo. La riforma dell’assistenza sociale, intrapresa allora nelle città, costituiva quindi una risposta alle trasformazioni in atto, delle quali le città stesse erano portatrici. Tale riforma doveva creare condizioni favorevoli a queste trasformazioni e livellare le tensioni sociali che sorgevano come «effetto collaterale».
1. I decisivi anni Venti del XVI secolo
Gli archivi del XVI secolo mostrano il pauperismo come un fenomeno di vita urbana. Alla luce di quanto abbiamo detto, il fatto che le vere origini di questo fenomeno fossero radicate nelle trasformazioni delle strutture agrarie, mentre esso si manifesta pienamente proprio nelle città, costituisce un paradosso solo apparente. Le città, a cavallo tra il XV e il XVI secolo, non sono riuscite a creare «strutture di adattamento» capaci di disciplinare il massiccio afflusso di persone prive di qualifiche professionali e non abituate alla vita urbana. Nell’ambito tradizionale di una organizzazione corporativa, un nuovo arrivato poteva essere lentamente preparato al mestiere ed alla vita cittadina nel corso di anni di pratica artigianale o in botteghe di mercanti, a contatto con le case e con le famiglie borghesi. Posti di fronte ad una massiccia affluenza nelle città, legata all’espansione demografica ed ai processi di pauperizzazione interna, quei meccanismi tradizionali potevano svolgere oramai solo un ruolo marginale, persino indipendentemente dai mutamenti che avvenivano nell’organizzazione della produzione urbana.
Abbiamo mostrato che il ritmo dei processi di pauperizzazione nell’Europa occidentale era determinato dalle crisi alimentari. La serie di queste crisi moderne è inaugurata da quella dell’ultimo quarto del XV secolo, ma sono poco noti il suo andamento e le sue conseguenze. È lecito supporre che le osservazioni e le esperienze di quel periodo abbiano influito sulla presa di coscienza dell’importanza della politica sociale e del legame fra povertà e lavoro da parte del predicatore alsaziano Greyler da Kayserberg o di un altro predicatore e scrittore a cavallo di quei secoli, Johannes Pauli o, infine, di un classico della letteratura spagnola rinascimentale sulla miseria, l’umanista spagnolo J.L. Vives. Queste esperienze hanno avuto anche una grande importanza per le iniziative di riforma cittadina delle istituzioni di carità e per la formazione di una moderna politica sociale. Tutto questo insieme di problemi, nei quali si intrecciano problematiche politiche e ideologiche, azioni pratiche e polemiche dottrinali, sembra esplodere in un momento preciso: negli anni Venti del XVI secolo. Nel 1522 a Norimberga viene effettuata la centralizzazione dell’assistenza ai poveri; un anno più tardi lo stesso avviene a Strasburgo; nel 1525, a Ypres, viene emessa un’analoga disposizione che conquisterà una grande popolarità e darà luogo a molte imitazioni. Nel 1526 viene stampato il trattato di Vives Sull’aiuto ai poveri e alcuni anni più tardi, nel 1531, viene proclamato un editto imperiale che sanziona le iniziative delle città e fissa le regole della politica sociale e della riorganizzazione dell’assistenza ai poveri. È stato proprio questo insieme di fatti, collegati fra loro, a costituire oggetto di contesa fra la storiografia cattolica e quella protestante. La coincidenza dei tempi non è casuale; l’importante però non è stabilire chi ha imitato l’altro, ma sapere che questi avvenimenti cadono in un momento molto particolare della crisi economica e sociale.
Il cattivo raccolto dell’annata 1521-22 ha dimensioni europee. Il danno è aggravato dal fatto che già nel corso del decennio precedente si susseguirono annate cattive. Nella Linguadoca si riscontra una serie di cattivi raccolti negli anni 1495-97; seguono le annate sfavorevoli tra il 1504 e il 1508, e ancora un ciclo fra il 1513 e il 1515. Poi i cattivi raccolti si ripetono ormai ogni due anni, il che costringe i governi a vietare l’esportazione del grano da una regione che ne era tradizionalmente esportatrice. L’esportazione viene vietata anche negli anni 1522 e 1524; infine tale divieto vige in Linguadoca per tutto il decennio 1526-35. Questa sequenza di cattivi auspici è accompagnata da immediate decisioni adottate nei confronti dei poveri. Queste decisioni si differenziano per alcuni aspetti: verso la fine del XV secolo, nelle annate più difficili, venivano organizzati ricoveri per i poveri e distribuzioni di viveri; durante la crisi degli anni 1504-8 le parrocchie espellono i poveri abili al lavoro, negando loro un sostegno; negli anni di carestia tra 1513 e 1515 si adottano misure per ripulire le città dalle folle dei miserabili, ed i vagabondi vengono puniti con frustate. La carestia degli anni 1526-35 rivela il conflitto fra l’incremento demografico e la penuria di cibo; il vagabondaggio diviene un fenomeno di massa, e si intensifica un’ondata di provvedimenti repressivi nei confronti dei poveri. Oramai si tratta di una «crisi abissale» – conclude Emmanuel Le Roy Ladurie – che nasce dalle contraddizioni interne della società e tocca sia le sue basi biologiche (con la concomitanza di denutrizione, di fame e dell’epidemia del 1530, particolarmente mortifera) che le sue strutture psicologiche: una crisi decisiva, dopo la quale non era più possibile vivere e governare come prima.
Si tratta, infatti, di una crisi su scala europea, di un segnale drammatico che l’agricoltura non è più in grado di reggere l’incremento demografico, e che la sua trasformazione è legata ad alti costi sociali. La depressione tocca anche il commercio e le finanze, gli sbocchi dei prodotti industriali si contraggono vistosamente, per cui la città non solo non è più in grado di assorbire il massiccio aumento dell’offerta di manodopera, ma restringe i livelli di occupazione. La disoccupazione, l’eccedenza dell’offerta sulla domanda, si manifestano in entrambi i mercati di manodopera – del lavoro specializzato e di quello non qualificato – che nell’economia di quel periodo funzionano in base a principi di larga autonomia e di reciproca chiusura.
L’Inghilterra, nell’epoca moderna, non ha vissuto le drammatiche crisi alimentari che hanno scosso il continente: abbiamo già visto che ciò dipende dalla differenza nelle trasformazioni del sistema agrario. Le crisi dei secoli XVI-XVII si manifestano in Inghilterra come concomitanza di cattivi raccolti e alti prezzi dei generi alimentari, con una flessione della congiuntura favorevole nel commercio internazionale e con la contrazione della domanda di prodotti industriali inglesi sui mercati interno ed esterno. Ma le carestie e le epidemie sono legate qui con la questione dei poveri in termini simili a quelli del continente. Negli anni 1527-28 il problema dell’assistenza ai poveri è all’ordine del giorno. Il cattivo raccolto del 1527 provoca un aumento del prezzo del grano ed una vasta ondata di speculazioni alimentari: viene istituita una apposita commissione per esaminare l’entità delle provviste e per combattere la speculazione. La situazione è inquietante: in alcune parrocchie del Wiltshire i commissari constatano che solo il 3-5% degli abitanti dispone di grano. Nell’Essex e nel Suffolk i commissari si appellano agli abitanti più facoltosi perché comprino provviste di grano per i poveri, ma il risultato è alquanto modesto; contemporaneamente si inasprisce la caccia ai vagabondi, che vengono puniti severamente. Nel 1528 il raccolto è buono e la situazione migliora rapidamente. Un ulteriore elemento di difficoltà in quegli anni è costituito dalle complicazioni sul mercato di lavoro. All’inizio del 1528 l’Inghilterra si dichiara dalla parte della Francia nella guerra contro l’imperatore, e per questo motivo le industrie laniere inglesi vedono chiudersi gli sbocchi commerciali dei Paesi Bassi. Questa situazione, di breve durata, provoca tuttavia una temporanea disoccupazione. Il consiglio regio fa pressione sui mercanti lanieri, affinché comprino le merci indipendentemente dalle difficoltà, evitando in tal modo la disoccupazione in quello che era il ramo principale della produzione inglese. È significativo che in entrambi i casi – della situazione alimentare e della disoccupazione degli operai lanieri – l’argomento decisivo per spingere all’azione le autorità statali è quello dell’ordine pubblico, della paura di sommosse sociali. I timori non erano infondati, dato che sia la disoccupazione che il carovita (il cui effetto psicologico era potenziato dalla svalutazione, decisa nel 1527) avevano provocato un’ondata di tumulti. Vale anche la pena di rivolgere l’attenzione sulla Spagna, uno dei pochi paesi che nel corso del XVI secolo non si erano decisi a vietare la mendicità. Tuttavia anche qui, negli anni Venti, si prospettano tentativi di adottare misure in tal senso. Le Cortes, cioè l’assemblea degli stati della monarchia castigliana, si pronunciano contro il massiccio incremento del numero dei mendicanti. Nel 1523 le Cortes di Valladolid, richiamandosi ad una petizione di qualche anno prima, deliberano che i poveri hanno diritto di chiedere l’elemosina solo nei loro luoghi di origine. Nel 1525, anno di cattivo raccolto, le Cortes di Toledo vietano di mendicare senza una specifica licenza, e questo divieto viene ripreso dalle Cortes di Madrid nel 1528 e nel 1534.
La portata della crisi sociale di quegli anni si rispecchia anche nelle rivolte popolari, nelle guerre e nelle rivolte contadine in Germania (1525-26), in Spagna (1520-21 e 1525-26), e in una serie di rivolte contadine e urbane in Inghilterra, in Francia, e nei Paesi Bassi. Si calcola che nelle città dell’Impero, nella seconda metà del XV secolo, si aveva in media una rivolta urbana ogni due anni, mentre nel terzo decennio se ne avevano in media 4-5 ogni anno, cioè nove volte di più. Uno storico della Linguadoca dimostra anche che l’avanzata della riforma in quella regione era legata all’inasprimento degli atteggiamenti contestatari, e che questa cade proprio nel periodo della crisi sociale degli anni 1526-35.
In questa situazione così complessa, il problema dei poveri si presenta sotto due aspetti: le città si trovano nella necessità di fronteggiare le masse di miseri affamati che arrivano dai dintorni (e quand’anche fosse stato possibile chiudere loro le porte della città, questi si sarebbero accampati intorno alle mura); d’altra parte si pone la necessità di mettere ordine nell’organizzazione dell’assistenza ai mendicanti, di fissare le regole e le istituzioni di assistenza sociale: lo esigeva la situazione interna delle città, ma un peso notevole può essere attribuito anche alla tendenza di ridurre l’attrattiva della città come luogo di abbondanza di elemosine, ove ognuno può contare su un aiuto. Ci soffermeremo qui su tre esempi di riforma municipale in quel periodo critico, senza tuttavia tentare una caratterizzazione di tipo monografico di alcuno di essi. Attraverso questi tre casi cercheremo di delineare le caratteristiche fondamentali della situazione e le misure adottate dalle autorità municipali.
a) Parigi: inquietudini morali e paura
Il carattere complesso della situazione di Parigi era legato alla particolare importanza dell’esempio parigino per le altre città. Questo derivava soprattutto dal fatto che si trattava della capitale. La presenza della corte reale e dell’amministrazione centrale influenzavano in modo evidente le decisioni delle autorità cittadine, consapevoli del fatto che le loro iniziative erano osservate dall’alto ed esigevano un consulto con le istituzioni del governo centrale. Il problema dei poveri nella capitale era sotto la diretta tutela del Parlamento, mentre il tesoro regio si preoccupava di fornire mezzi per il sostegno. Non priva d’importanza era anche la presenza dell’università, che perpetuava una tradizione di autorità teologica e dottrinale di grande peso nel mondo cristiano. Ma le decisioni riguardanti l’assistenza ai poveri toccavano in modo più diretto la dottrina e la pratica della Chiesa. Le iniziative parigine erano osservate da altre città che da Parigi attendevano esempio e istruzioni concrete. Invece la capitale francese, una delle città più grandi d’Europa, importante centro commerciale e finanziario nonché centro produttivo, specializzato in articoli di lusso, lottava come le altre città contro l’incremento del numero dei miserabili per le strade, indecisa sulle misure da adottare.
Sin dall’inizio del XVI secolo a Parigi si svolgono discussioni e iniziative sulla riorganizzazione dell’amministrazione ospedaliera. Dall’anno 1505 nell’Hôtel-Dieu parigino funziona una commissione di amministratori laici; fatto di grande importanza, perché denota la laicizzazione dell’amministrazione ospedaliera, e rappresenta una delle tappe decisive nel conflitto fra autorità cittadine e capitolo di Notre-Dame. Questa laicizzazione procede gradualmente, anche se in tempi diversi, in tutte le città della Francia. Nel 1520 Francesco I affidò la questione della riforma dell’amministrazione ospedaliera e degli ospizi della monarchia al suo Grande Elemosiniere, che doveva nominare in ogni diocesi due controllori della riforma, un ecclesiastico e un laico. È ovvio che il cambiamento più significativo era costituito dall’ordine di partecipazione dei laici nel controllo degli ospedali; tuttavia nella direzione degli ospedali continuavano ad essere presenti le autorità ecclesiastiche e le persone legate alla Chiesa. L’interesse delle autorità cittadine per gli ospedali è causato in gran parte dalle epidemie: ogni ondata epidemica costringe ad adottare misure immediate. L’iniziativa è nelle mani del Parlamento di Parigi, la principale autorità giuridica della monarchia, dotata di un’ampia sfera di poteri e di prerogative. Nel Parlamento si svolgono le assemblee consultive, alle quali vengono invitati anche i rappresentanti della Camera dei Conti, del capitolo parigino, del governo regio e dell’autonomia comunale. (Parigi infatti non era una città libera e era sottoposta a un sistema di doppio governo: quello del re e quello dell’autonomia municipale, guidati rispettivamente dal prevosto del re e dal prevosto dei mercanti.) Così è anche nel 1510 quando, a partire da agosto, la città è in preda ad una grave epidemia di pertosse: alla finestra di ogni casa, nella quale vi è un malato, per due mesi deve essere appeso un mazzetto di paglia, come avvertimento. Alcuni anni più tardi, nel 1515, Jean Bissonet, presidente della Camera dei Conti, particolarmente attivo in iniziative di carattere caritatevole sul territorio di Parigi (sarà proprio lui uno dei due controllori della riforma degli ospedali designati nella diocesi di Parigi dal Grande Elemosiniere in seguito alla menzionata ordinanza di Francesco I), in una speciale riunione di notabili e di esperti presentò la proposta di approntare dei locali che, in caso di bisogno, permettessero un ricovero isolato dei malati contagiosi. Ma la proposta non fu accolta favorevolmente né dalla Facoltà di Medicina né d...