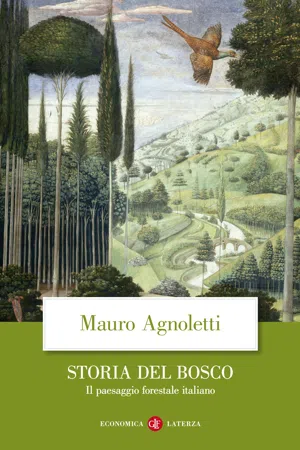1.
La domesticazione del paesaggio naturale
1. La colonizzazione antropica
La storia del paesaggio italiano in epoca antica è in gran parte caratterizzata dalla trasformazione dell’ambiente naturale in aree agricole, intendendo con questo processo anche la coltivazione del bosco. Il passaggio da una società caratterizzata dalla prevalenza di cacciatori e raccoglitori di frutti ad insediamenti agricoli temporanei e poi ad aree permanentemente coltivate, in grado di fornire raccolti stabili, è stato alla base del processo di civilizzazione. A questo processo si accompagna anche la domesticazione del bosco che non è stato soltanto ridotto di estensione per realizzare città, pascoli e campi, ma soprattutto modificato nelle sue caratteristiche di densità, struttura e composizione specifica per fornire una vastissima gamma di prodotti necessari alla vita.
Per un lunghissimo periodo storico che va dal primo sviluppo delle attività agricole fino ai primi anni del secondo dopoguerra non era pensabile fare agricoltura senza avere una sufficiente dotazione di alberi, sia in forma di boschi sia di alberature sparse. Pertanto, la ricostruzione di una storia del paesaggio forestale, se deve necessariamente tenere conto anche delle trasformazioni della estensione dei boschi, non può che basarsi soprattutto sugli usi del bosco e sulle sue modalità di gestione. In questo senso, le caratteristiche ambientali dell’Italia in termini di specie arboree, e la loro distribuzione geografica ed altimetrica, in relazione al suolo ed al clima, giocano sicuramente un ruolo importante, ma spesso secondario rispetto alle necessità della popolazione. Intendiamo con questo che, pur riconoscendo ad esempio la prevalenza di certe specie vegetali in alcuni contesti ambientali, come ad esempio il castagno sulle Alpi e sugli Appennini, le necessità di coltivare questa specie nel corso dei secoli la portano ad essere oggi presente dal livello del mare fino a 1500 m del Monte Etna, in ambienti molto lontani dalle sue ideali esigenze ecologiche.
Peraltro, la sostanziale unità a scala geografica della penisola che, come ricorda De Seta, ha unito i popoli dell’Italia prima ancora delle vicende storiche1, ha costituito un limite fisico entro il quale la circolazione delle culture e delle specie animali e vegetali è stata in qualche modo costretta a muoversi in uno spazio limitato ma denso. Non è quindi intenzione di questo lavoro concentrarsi in modo particolare sulle trasformazioni delle superfici boscate nei secoli, o sui caratteri naturali della vegetazione forestale, peraltro facilmente rinvenibili nella letteratura scientifica, ma piuttosto di mettere in evidenza le caratteristiche del paesaggio forestale determinate dalle dinamiche storiche legate al continuo rapporto fra esigenze antropiche e caratteristiche naturali.
Pensando al paesaggio in epoca protostorica, dobbiamo innanzi tutto rifuggire dall’idea della prevalenza di montagne coperte da boschi e di insediamenti umani concentrati soprattutto nelle pianure. Ciò non significa che le vallate escludessero aree abitate, numerosi autori segnalano però la preferenza delle popolazioni primitive per le terrazze e gli anfiteatri morenici delle zone montane, giustificandola con le condizioni di esposizione e la pedologia dei versanti. La scioltezza del terreno fertilizzato dai fanghi glaciali e l’assenza di un fitto mantello forestale costituiscono senza dubbio un elemento decisivo per questa localizzazione degli insediamenti primitivi, ben documentata anche dal punto di vista archeologico2. Tale situazione è in qualche modo confermata da storici come Strabone, il quale precisava che i monti e le cime sovrastanti i contrafforti alpini delle Alpi occidentali erano ben popolati3. Le notizie disponibili per l’età del bronzo in area alpina parlano di sistemi agro-pastorali montani seminomadi, dove piccole superfici coltivate sono vincolate alle esigenze dell’allevamento del bestiame e ai necessari spostamenti per la ricerca di pascoli4. Il popolamento della montagna probabilmente interessò in una prima fase i conoidi di deiezione o le falde di detrito più fertili, in conseguenza della rimozione dei querceti e delle faggete. Gli insediamenti abitativi più stabili erano concentrati soprattutto nella fascia altimetrica della mezza montagna, con pendenze più dolci e dai suoli spesso più evoluti, specie sugli altopiani, dove il bosco lascia spazio alla messa a coltura delle terre5.
L’intensa frequentazione della montagna alpina sembra in qualche modo suffragata anche da recenti scoperte legate al ritiro dei ghiacciai, come nel caso del ritrovamento della mummia di Ötzi, altrimenti detto l’uomo del Similaun, un ghiacciaio posto in Alto Adige al confine con l’Austria nel quale il corpo di questo pastore dell’età del rame è stato ritrovato. Analizzando quanto recuperato in termini di attrezzi e indumenti sul corpo dell’uomo, vissuto attorno al 3200 a.C., si sono potute riconoscere 17 specie arboree, dal pero al larice, dal pruno al ginepro, dall’olmo al salice, segno di una notevole varietà di impieghi delle piante arboree che suggeriscono conoscenze approfondite delle loro qualità in relazione ai vari impieghi che vanno dagli indumenti agli oggetti che il cacciatore aveva con sé. Le ricerche genetiche condotte sul cadavere confermerebbero le notizie secondo le quali Ötzi e i suoi antenati avrebbero fatto parte di popolazioni agricole appartenenti ad un gruppo chiamato aplogruppo G, tipico di popolazioni radicate in Medio Oriente. Ciò confermerebbe anche la radice indoeuropea di alcuni termini legati alle specie arboree presenti nell’arco alpino, oltre ai flussi culturali che hanno influenzato il paesaggio italiano dal mare e attraverso i percorsi terrestri che collegano la piattaforma continentale euroasiatica6.
La presenza dei primi insediamenti nelle aree montane non è sicuramente una caratteristica unica del paesaggio italiano. Anche nel vicino Medio Oriente i reperti archeologici e i dati linguistici ci mostrano come le sopraelevazioni del terreno siano state particolarmente ricercate dalle popolazioni primitive, fin dal neolitico. Se le cime più elevate delle colline e delle montagne sono state utilizzate come rifugio e difesa, le alture e le sopraelevazioni minori del terreno sono state più largamente e normalmente frequentate, essendo spesso le prime terre che le tribù primitive hanno scelto per l’occupazione. In territori come quelli della valle padana emersi sulle alluvioni pleistoceniche, ancora soggetti a inondazioni e impaludamenti, o comunque occupati dalla foresta postglaciale, questa scelta probabilmente era quasi obbligata e spesso l’unica alternativa agli insediamenti palafitticoli. Ciò è avvenuto anche nel delta del Rodano e lungo la fascia litoranea dallo stagno di Berre ai Pirenei, in cui ogni sopraelevazione del terreno ha segnato, dalle epoche più antiche, una tappa nell’occupazione del suolo e negli insediamenti umani.
La scarsezza di relitti linguistici e toponomastici preromani, che si riferiscano alle maggiori depressioni vallive, suggerisce pertanto che le grandi vallate non ebbero un ruolo significativo per le fasi iniziali dell’occupazione dello spazio da parte dell’uomo. È solo in epoca più tarda, nella fase celtica, romana, e spesso romanza che nei fondovalle ricchi e freschi, ma proprio per questo ingombri di un più fitto mantello forestale, si sono sviluppati i dissodamenti e moltiplicate le frequenze umane. Gli insediamenti vallivi sono più frequenti là dove aree naturalmente spoglie di vegetazione arborea offrono condizioni più propizie per una tecnica ancora relativamente arretrata per operare disboscamenti. Difficilmente le prime popolazioni affrontano un disboscamento in vallate ove la vegetazione arborea sia densa e continua e dove l’umidità del terreno rende difficile l’impiego del fuoco, la principale forma di modellamento del paesaggio del Mediterraneo.
L’ipotesi di una prima colonizzazione delle aree montane troverebbe una parziale conferma anche per l’area appenninica, con la presenza documentata di numerosi insediamenti del paleolitico superiore, circa 35.000 anni fa, mentre vi sono molte notizie sul regolare sfruttamento stagionale dei pascoli estivi alle quote elevate per il neolitico7. L’ipotesi di insediamenti montani di una discreta importanza sembra suffragata anche dalle classificazioni delle ceramiche, i cui tipi fondamentali iniziano con la fase della «ceramica appenninica decorata e grezza» dell’età del bronzo, precedente la fase villanoviana. Tali informazioni si accompagnano però a descrizioni di insediamenti localizzati a quote più basse, dove rispetto ad una economia basata prevalentemente sulla caccia, troviamo popolazioni già dedite all’allevamento di animali domestici e alla coltivazione dei cereali, come evidenziato dagli scavi nell’insediamento neolitico di Pienza in Toscana, un’area collinare della Val d’Orcia, ma anche da decine di altri siti presenti nell’Etruria e nell’Italia meridionale, in particolare in Puglia. Fra il secondo ed il primo millennio a.C., la quantità degli insediamenti sembra comunque aumentare in modo proporzionale, in pianura ed in montagna, tanto che per l’età del bronzo italiana è stato coniato il termine di «cultura appenninica»8.
Nell’analisi delle dinamiche del paesaggio non possiamo comunque trascurare che alcuni importanti aspetti relativi alla vegetazione forestale e agli insediamenti abitativi sono stati condizionati dall’evoluzione climatica e dalle condizioni orografiche. La forma della penisola la proietta dal centro della piattaforma continentale europea fino a toccare quella africana con climi che variano da quelli glaciali a quelli subtropicali e semiaridi, secondo la classificazione di Köppen. Questo propone una grande varietà di ambienti diversi per lo sviluppo della vegetazione forestale ai quali si aggiungono le varianti altitudinali, dal livello del mare fino ai picchi della catena alpina, con un territorio per il 35,2% montano e per il 41,6% collinare, ma con solo il 23% di pianure, donandogli così quel connotato di paesaggio soprattutto a sviluppo «verticale» ricordato da Emilio Sereni, così diverso dai paesaggi del centro e del nord dell’Europa9.
A questa diversità di ambienti si aggiungono particolari fenomeni legati alle variazioni climatiche di lungo periodo. Ciò vale, ad esempio, per la particolare situazione della regione alpina insubrica, corrispondente alla zona dei laghi lombarda, caratterizzata da vegetazione tipica della zona mediterranea, poco legata al tradizionale ambiente alpino e prealpino, frutto dell’immigrazione di elementi termofili e sud-orientali nel periodo postglaciale. Il peggioramento climatico verificatosi successivamente avrebbe determinato l’«isolamento» di queste formazioni nella zona dei laghi, eliminando le vie di penetrazione dal mare attraverso la pianura padana, salvo la zona dei colli Euganei che ancora lo testimonia. Le particolari condizioni climatiche della regione insubrica h...