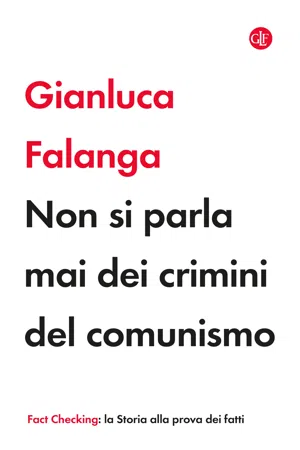1.
Cento milioni di morti!
Cento milioni è un numero che rimane impresso.
L’edizione originale francese lo portava stampato sulla fascetta che avvolgeva la copertina, quelle fascette di colori sgargianti che aiutano a catturare l’attenzione dei lettori nelle librerie, ricorrendo a superlativi, paragoni strabilianti, numeri di vendita d’eccezione.
Ma cento milioni non erano le copie vendute.
Erano i morti.
Cento milioni di morti!
Baam! Una cannonata. Un botto che doveva scuotere le coscienze, liberarle da un potentissimo maleficio che continuava a tenerle prigioniere. «Non è nostra intenzione istituire in questa sede chissà quale macabra aritmetica comparativa né tenere una contabilità rigorosa dell’orrore o stabilire una gerarchia della crudeltà», avvertiva la prefazione, «ma i fatti parlano chiaro e mostrano che i crimini commessi dai regimi comunisti riguardano circa 100 milioni di persone, contro i circa 25 milioni di vittime del nazismo. Questa semplice constatazione deve quantomeno indurre a riflettere sulla somiglianza fra il regime che a partire dal 1945 venne considerato il più criminale del secolo e un sistema comunista che ha conservato fino al 1991 piena legittimità internazionale, e che tutt’oggi è al potere in alcuni paesi e continua ad avere sostenitori in tutto il mondo»1.
Era il novembre 1997. Nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Rivoluzione d’Ottobre l’editore parigino Laffont pubblicava Il libro nero del comunismo: 841 pagine di massacri, esecuzioni, deportazioni e carestie provocate da politiche scellerate, dalla Russia all’Afghanistan, passando per la Cina, il Vietnam, la Cambogia, l’Europa fra le due guerre mondiali e quella divisa della Guerra fredda, i regimi afrocomunisti degli anni settanta, Angola, Etiopia, Mozambico, giù fino a Cuba e al Nicaragua. Una carrellata secolare di crimini immensi, abusi sistematici e atrocità di ogni genere compiute da regimi comunisti o sedicenti tali in quasi ogni angolo della Terra. A raccontarli e documentarli un collettivo di undici autori, ricercatori del prestigioso Centro Nazionale di Ricerca Scientifica francese. Alcuni di loro erano importanti collaboratori di François Furet, il quale avrebbe dovuto impreziosire il Libro nero con una sua autorevole introduzione, ma la morte improvvisa glielo aveva impedito. Di aprire e chiudere il volume, dandogli una cornice, s’era incaricato allora il curatore e coordinatore del progetto, Stéphane Courtois.
Il libro nero del comunismo ebbe un impatto editoriale fenomenale: tradotto in oltre venti lingue, un milione di copie vendute nel mondo, i numeri di un bestseller. Appena uscito, si scatenò subito un dibattito internazionale vasto e profondo, molto acceso, perché la fine dell’era sovietica era ancora vicina e il libro non mancò di essere impugnato nella contesa fra forze politiche in vari paesi. Le destre esultarono, le sinistre lo contestarono, ricevendolo come un attacco prevenuto alla loro storia. L’accademia si divise, non risparmiò critiche severe all’impostazione e alla metodologia dell’opera, ma sottolineando il valore e lo spessore di alcune sue parti. Nel complesso, il volume aveva il pregio di tentare una narrazione d’insieme della storia del comunismo, offrendo un panorama completo del fenomeno in tutta la sua estensione geografica e cronologica, con un respiro internazionale sicuramente consono alle ambizioni di un’ideologia universalista che voleva riscattare l’umanità intera dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Tuttavia, l’appiattimento sulla dimensione criminale trasformava il libro in una specie di tribunale pubblicistico, un lungo e corposo atto d’incriminazione per un’immaginaria Norimberga post festum del comunismo.
Lo sforzo di invocare una concentrazione internazionale su fatti estremamente significativi della storia umana del Novecento, anche tematizzando l’esistenza di un problematico squilibrio nella percezione pubblica dei crimini commessi da regimi comunisti rispetto a quelli del nazismo, era di per sé apprezzabile, ma perdeva gran parte della sua incisività per la manifesta intenzione di Courtois di vedere sancita una perfetta equivalenza criminale di nazismo e comunismo, affiancando al «genocidio di razza» del primo il «genocidio di classe» del secondo: «la morte per stenti del bambino di un kulak ucraino deliberatamente ridotto alla fame dal regime stalinista “vale” la morte per stenti di un bambino ebreo del ghetto di Varsavia ridotto alla fame dal regime nazista»2. Insomma, il comunismo ridotto a una forma di nazismo rosso, al quale sarebbe spettata anche la paternità di metodi repressivi e di sterminio che «non soltanto ricordano quelli nazisti, ma molto spesso ne sono il precorrimento»3. Courtois riproponeva insomma l’idea del “nesso causale” fra comunismo sovietico e nazionalsocialismo tedesco, già stata respinta dieci anni prima dagli storici coinvolti nella famosa Historikerstreit (“disputa degli storici”), scatenata dalle provocazioni di Ernst Nolte, secondo il quale: «Se nella testa di Adolf Hitler non si fosse formata l’idea che gli ebrei erano responsabili dei gulag e del cosiddetto Terrore rosso del 1919 e 1920, non ci sarebbe potuta essere Auschwitz»4.
Una causalità di questo genere, forse è superfluo ricordarlo, non ha alcun fondamento storico. Non l’aveva allora, nel 1997, e non ce l’ha oggi, allo stato delle conoscenze più approfondite e precise che abbiamo. Al di là di certe affinità elettive sul piano culturale, politico e strutturale fra bolscevichi e nazionalsocialisti o fra i regimi di Stalin e Hitler (parallelismi che meritano di essere sottoposti a un’attenta analisi, ma solo dopo aver chiarito esattamente cosa paragonare, come farlo e soprattutto a che fine operare il raffronto, evitando sciocche equiparazioni), la formula “genocidio di classe” adoperata da Courtois, al sol scopo di equipararlo alla Shoah, rappresentava una più che discutibile forzatura di un concetto, quello di genocidio, la cui applicabilità ai crimini staliniani continua ancora oggi ad essere molto controversa. Problematico era anche l’uso disinvolto che lo storico francese faceva dei concetti di “classe” e di “razza”, come se non si trattasse di categorie estremamente imprecise e arbitrarie perché politiche, rispondenti a criteri adottati dai regimi per operare i loro interventi epurativi5.
A infiammare il confronto scaturito dalla pubblicazione del Libro nero non fu però solo l’infelice approccio equiparativo adottato da Courtois, peraltro apertamente contestato persino dagli stessi autori del collettivo6. Quel numero – cento milioni – appariva più funzionale a una strategia sensazionalistica che il risultato di un serio e ponderato tentativo di quantificazione scientifica. Lo stesso Courtois, argomentando, menzionava talvolta la cifra di 80 milioni, talaltra 85, altrove ancora 100, come se, dato l’ordine di grandezza, la differenza di 15-20 milioni di morti si potesse semplicemente arrotondare! Courtois, sbagliando, giudicò superfluo informare i lettori che si trattava di una sommatoria di stime da decenni oggetto di controversia nella comunità scientifica per almeno due ragioni: la limitata disponibilità di documenti ufficiali e dati demografici affidabili e il disaccordo sui criteri in base ai quali stabilire quali vittime di quali atti criminosi contare, sommare, eventualmente confrontare. Ma non era questo il problema più serio. La cifra tonda serviva a impressionare e, direttamente contrapposta ai “soli” 25 milioni di morti causati dal nazismo, a dimostrare che il comunismo fu infine peggiore del nazismo, perché uccise quattro volte tanto. In altre parole, Courtois andava oltre l’equiparazione di nazismo e comunismo, affermando la maggiore letalità di quest’ultimo in virtù di un unico criterio: la conta dei cadaveri.
Sia chiaro: non era in dubbio la verità dei fatti riportati nel Libro nero, sostanzialmente coerenti con le ricostruzioni di altri studi e pubblicazioni, precedenti e seguenti, e corredato di abbondanti riferimenti bibliografici e archivistici, in larga parte nemmeno inediti. Oltremodo critica, per non dire irricevibile, era l’enfasi sul resoconto dei crimini in termini numerici, puramente quantitativi. Il mero numero, a prescindere da come ci si arriva, è sul piano etico un criterio abbastanza equivoco, a meno che non si sia disposti a giudicare migliore, meno brutale o addirittura più umano un regime che ammazza 25 milioni di persone rispetto a un altro che ne ammazza 50 o 100. In termini di qualità, invece, vale a dire sul piano dello sforzo conoscitivo delle caratteristiche specifiche dell’esperienza storica del comunismo, la storiografia con la calcolatrice di Courtois ha fatto parecchi danni.
Innanzitutto, non ha risvegliato, come si proponeva, le coscienze sorde ai crimini del comunismo, generando piuttosto nuova insensibilità. Il Libro nero ha fornito munizioni (cento milioni di morti!) alla più squalificata propaganda dei detrattori del comunismo ma anche, sul versante opposto, un’opportunità a chi non vuole prendere atto della storia di rifugiarsi comodamente in una povera polemica sulla serietà scientifica e l’imparzialità dell’opera. Inoltre, la focalizzazione quasi esclusiva sui morti ha oscurato l’evoluzione del sistema sovietico e dei regimi realsocialisti europei dopo la morte di Stalin, mancando di cogliere le caratteristiche particolari e i problemi del post-stalinismo, che riguardano per esempio il raffinamento e lo sviluppo di nuove metodologie repressive, e ignorando danni ingenti di altra natura, che pure meritano di essere conosciuti e ricordati, le devastazioni sul piano umano, morale, economico, ecologico, che costituiscono oggi la pesante ipoteca del comunismo in Europa orientale e in tutta l’area post-sovietica.
Su questo, mi concedo una piccola digressione. È notizia molto recente l’approvazione da parte del governo federale tedesco di un provvedimento che dispone il versamento di un assegno di risarcimento ai cittadini dell’ex Germania orientale vittime delle cosiddette “misure di disintegrazione” (Zersetzungsmaßnahmen), una sottile e terribile tecnica di guerra psicologica adoperata dalla Stasi per intimidire o destabilizzare psicologicamente dissidenti e altre persone giudicate di attitudini ostili al regime7. Ne gioveranno alcune migliaia di persone, fra queste per esempio Rita8, che da giovane madre aveva preso a frequentare un gruppo antimilitarista. Per indurla a tenersi lontana da quegli ambienti, la Stasi fece tutto il possibile per distruggere la sua reputazione, mettendo in circolazione voci che si prostituisse, e quando si resero conto che non bastava, fecero in modo che i suoi bambini non v...