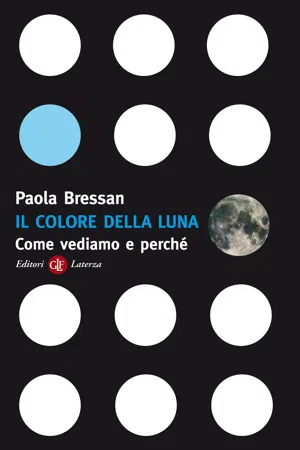1.
La luce
Alla prima del thriller Gli occhi della notte, nel 1967, le luci di sala vennero spente una alla volta negli ultimi 12 minuti di proiezione; una luce per ogni lampadina che Audrey Hepburn, nella parte di una donna cieca che cerca di difendersi da tre malintenzionati nel suo appartamento di New York, mandava in frantumi. La scena finale, in un crescendo di tensione, culminava nella perfetta oscurità (dentro e fuori dal film), mettendo sullo stesso piano non solo l’eroina non vedente e i malvagi vedenti, ma anche, imprevedibilmente, gli spettatori.
Nel buio pesto non è facile farsi un’idea di che cosa ci circonda, né di ciò che accade intorno a noi. Suoni e rumori non ci trasmettono alcuna informazione su oggetti o eventi silenziosi, gli odori sono di scarso aiuto e la pressione di certe superfici sulla pelle non ci dice nulla sulle parti dell’ambiente con cui non siamo direttamente a contatto. Non a caso la paura del buio è una delle più ancestrali, assieme a quella dei serpenti, dei ragni, dei temporali e degli estranei. (Ironicamente, ben pochi hanno altrettanta paura di pericoli evolutivamente recenti come le automobili, l’alcol e le sigarette, pur sapendo che oggi questi uccidono molte più persone di quanto non facciano i ragni, i fulmini o i serpenti.) Da che mondo è mondo, o perlomeno dal Pleistocene in qua, per sentirci a nostro agio abbiamo bisogno di procurarci informazioni rapide e abbondanti sul mondo che ci circonda; e per farlo abbiamo bisogno di luce.
1.1 Che cos’è la luce
La luce è una forma di energia elettromagnetica, esattamente come le onde radio, le microonde, i raggi infrarossi e ultravioletti, i raggi X. La natura della luce ha rappresentato la materia di una delle più roventi controversie nella storia della scienza. La luce è un insieme di onde o di minuscole particelle? Dopo alterne fortune dell’una e dell’altra interpretazione, si è giunti alla conclusione di aver bisogno di entrambe. Ci vediamo insomma costretti a impiegare contemporaneamente due analogie differenti, e a immaginare la luce come composta sia di particelle che di onde.
L’unica differenza fra le varie forme di energia elettromagnetica è la lunghezza d’onda, che può essere misurata in chilometri, metri o centimetri, ed esprime la distanza percorsa dall’onda fra un’oscillazione e l’altra. Un’alta frequenza di oscillazione, ad esempio, significa che l’onda non fa molta strada fra un’oscillazione e l’altra e ha quindi una lunghezza d’onda piccola.
Fig. 1.1 Una goccia che cade nell’acqua genera una serie di onde concentriche. Possiamo immaginare che le onde luminose irradiate da una fonte di luce, come il sole o una lampadina, si propaghino nell’aria in modo analogo. Già nel V secolo a.C. i Greci si erano resi conto che l’occhio e l’oggetto guardato dovevano essere collegati da qualche cosa, ma la natura di questo legame (che è la luce, come ora sappiamo) rimase sconosciuta per almeno duemila anni. La convinzione predominante era che l’occhio emanasse dei raggi che viaggiavano fino all’oggetto e lo toccavano. Idea respinta prima da Aristotele, con l’argomento che in tal caso saremmo in grado di vedere al buio; poi da Leonardo da Vinci, con l’obiezione che sarebbe impossibile vedere il sole immediatamente dopo aver aperto gli occhi, considerata la distanza che ce ne separa. (La «corona» causata dall’impatto di una goccia sulla superficie dell’acqua è seguita da una colonna liquida che si solleva a un’altezza sorprendente, per frantumarsi poi in goccioline che la forza di gravità fa ridiscendere verso il basso. Immagini come questa sono ottenute in un ambiente perfettamente buio: un sincronizzatore rileva il passaggio della goccia mentre questa cade, e attiva un flash luminoso dopo un appropriato intervallo. Foto: © Andrew Davidhazy. Per gentile concessione dell’autore.)
A un’estremità dello spettro elettromagnetico stanno le onde radio usate nelle comunicazioni transoceaniche: fra un’oscillazione e l’altra si possono spostare di chilometri. Più corte sono le onde radio su cui si basano gli apparecchi radiofonici e televisivi, e ancor più corte quelle usate dai telefoni cellulari, come stanno a testimoniare le antenne più piccole (la lunghezza di un’antenna è di regola proporzionale alla lunghezza delle onde che essa ha il compito di catturare). Seguono le microonde, che fra un’oscillazione e l’altra percorrono al massimo qualche centimetro. Tutti sappiamo adoperare un forno a microonde, se non altro per scongelare il pesce, ma non tutti sanno che si deve alle microonde se i radar sono in grado di determinare la posizione di navi o aerei altrimenti invisibili. Il radar emette microonde un po’ più lunghe di quelle del nostro forno, e registra la direzione e l’intensità dell’eco proveniente dagli oggetti colpiti.
La radiazione successiva nello spettro elettromagnetico è l’infrarosso, la cui lunghezza d’onda non supera le dimensioni di una capocchia di spillo. Non vediamo i raggi infrarossi, ma li percepiamo sotto forma di calore. Una normale lampadina a incandescenza comincia presto a scottare proprio perché emette più del 90% della sua energia nell’infrarosso, ovvero sotto forma di calore anziché nello spettro visibile – uno spreco considerevole. L’efficienza di una lampada al neon si avvicina al 30%; sempre poco in confronto all’efficienza di una comune lucciola, che sotto forma di luce visibile libera più del 75% della sua energia.
Fig. 1.2 Lo spettro elettromagnetico comprende tutte le forme di energia che viaggiano alla velocità della luce. L’unica differenza tra queste forme di energia è la lunghezza d’onda, che qui è rappresentata in metri: 106 significa 1 seguito da 6 zeri, ovvero un milione di metri (la distanza in linea d’aria fra Venezia e Catania); 10-6 significa 1 diviso 1.000.000, ovvero un milionesimo di metro, che è meno del diametro di un globulo rosso. La lunghezza d’onda della luce visibile viene espressa di solito in miliardesimi di metro, o nanomètri. (Tanto per avere un’idea, un capello umano ha uno spessore di circa 80.000 nanometri.) Un modo di generare energia elettromagnetica è quello di applicare calore; più caldo un oggetto diventa, più la lunghezza d’onda delle radiazioni che emette si accorcia. Un pezzo di metallo, ad esempio, se viene scaldato emette radiazioni sempre più corte finché non raggiunge una temperatura di circa 500 gradi, quando comincia ad emettere luce visibile. È mediante questo processo, detto incandescenza, che il sole, il fuoco, e le tradizionali lampadine al tungsteno producono luce.
Ogni oggetto che abbia una temperatura emette radiazione infrarossa, anche un cubo di ghiaccio, ma oggetti più caldi ne emettono in misura maggiore. Su questo principio si basano le fotografie all’infrarosso: l’apparato rileva le differenze di temperatura nella scena e assegna un diverso (falso) colore a ciascuna temperatura, generando un’immagine che i nostri occhi possono interpretare. Alcuni rettili, come il serpente a sonagli, riescono a «vedere» la luce infrarossa direttamente e quindi a individuare animali a sangue caldo anche al buio. La natura non ha ritenuto di doverci dotare di un apparato di rilevazione dell’infrarosso, ma in certe situazioni averne uno non sarebbe male. Nella scena madre dell’inseguimento notturno, nel bel film di Michael Crichton Il mondo dei robot, la visione a infrarossi di cui è equipaggiato l’androide inseguitore Yul Brynner gli conferisce, per esempio, un evidente vantaggio sullo sfortunato Richard Benjamin, unico oggetto caldo rimasto in circolazione. Benjamin tenta di far perdere le proprie tracce camminando nell’acqua, ma il calore irradiato dalle sue impronte sul fondo ne tradisce ogni passo: attraverso gli occhi dell’androide, vediamo le orme brillare nella semioscurità. Nel mondo reale, l’acqua corrente farebbe dissipare il calore all’istante e comunque ben prima che l’androide sopraggiunga, ma l’idea non è priva di merito. Le telecamere a infrarossi mostrano, ad esempio, che le orme lasciate da un orso polare nella neve continuano a emanare calore per parecchi minuti dopo che l’orso se ne è andato.
Fig. 1.3 Fotografia all’infrarosso del muso di un gatto. Gli occhi e la parte interna delle orecchie (color arancio nell’immagine originale) sono le aree più calde; il naso (azzurro nell’immagine originale) è la parte più fredda. L’uso di pellicole all’infrarosso rende possibile fotografare o filmare al buio, una tecnica resa popolare dalla sua recente utilizzazione nei reality show, i cui partecipanti vengono spiati ininterrottamente anche nelle ore notturne. La medesima tecnica viene usata per smascherare rapinatori o intrusi, per studiare le reazioni del pubblico nei cinema, e per immortalare gli animali selvatici senza spaventarli. Si è scoperto recentemente che alcune specie di scoiattolo usano l’infrarosso per segnalare al serpente a sonagli, predatore naturale dei loro piccoli, l’intenzione di contrattaccare. Il segnale (prodotto solo in presenza del serpente a sonagli, che percepisce l’infrarosso, e non di serpenti che non sono in grado di farlo) consiste nel riscaldare la punta della coda e agitarla poi minacciosamente di qua e di là. Proprio studiando il serpente a sonagli, l’aviazione americana sta tentando di sviluppare un dispositivo per la rilevazione dell’infrarosso che sia in grado di individuare missili nemici nell’oscurità. Un congegno di questo tipo è già stato costruito, ma ha prestazioni grossolane (identifica la presenza ma non la posizione dell’oggetto caldo) e ha l’inconveniente di dover essere mantenuto a una temperatura inferiore ai 200 gradi sotto zero. Gli organi che permettono al serpente a sonagli di percepire i raggi infrarossi non hanno questi difetti: sono sensibili a cambiamenti di temperatura dell’ordine di tre millesimi di grado, ed essendo posti bilateralmente determinano la distanza dell’oggetto caldo con impressionante precisione. Questi organi non funzionano come termometri, ma rilevano la differenza fra la temperatura del corpo del serpente (che è uguale a quella esterna) e la temperatura del corpo della preda. (Foto: SE-IR Corporation, Goleta, CA. Da http://imagers.gsfc.nasa.gov/ems/infrared.html.)
La porzione più corta dell’infrarosso (quella vicina alla luce visibile) fa eccezione perché non è calda, e non la possiamo percepire in alcun modo. Queste lunghezze d’onda s...