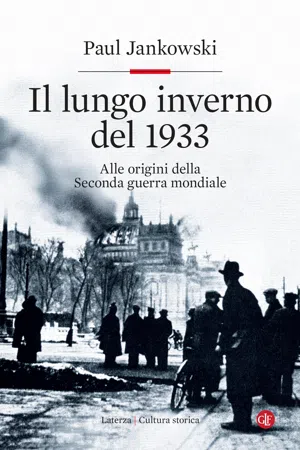1
Gli anni della locusta
«E avevamo fame». Erano affamati come bambini, durante la guerra e anche dopo, con l’inflazione e la sua valanga di soldi inutilizzabili, poi ancora quando la crisi economica colpì di nuovo nel 1929 e interruppe quel breve interludio che aveva fatto rinascere la vita di un tempo, con le vecchie regole e maniere d’anteguerra. Per un giovane tedesco della generazione nata un decennio prima del conflitto, tutto quello che nell’autunno del 1932 poteva ricordare gli indicava che gli elementi di cui beneficiava il mondo attuale non erano che un prestito casuale. Se mai fossero riapparsi, non c’era da aspettarsi che durassero. Disoccupato, aveva smesso di fare castelli in aria o di sognare un impiego stabile con uno stipendio di 200 marchi al mese: lui e i suoi contemporanei guardavano a un lavoro e al sussidio di disoccupazione come a un mezzo di sopravvivenza nell’immediato, e niente più. Non avevano più fede in qualche vocazione liberatrice, né in un ordine mondiale che li aveva esclusi dai ranghi dei viventi. Le impressioni suscitate in loro dalle immagini infantili di uniformi grigie, mitragliatrici, elmetti, trincee e cucine da campo, di marce e di assedi, avevano accompagnato la loro giovinezza disancorata e la prima maturità, mescolando fantasie militaresche a bisogni materiali. Era un connubio che poteva suscitare infatuazioni rivoluzionarie come controrivoluzionarie, o di altro tipo ancora. Quei giovani si chiedevano se i governi si rendessero conto dei pericoli derivanti dall’aver risvegliato quelle immagini ben conservate del passato nei tempi attuali, tormentati dalla disperazione e da un clima di guerra civile1. Nel 1932 la Depressione, incommensurabile, incomprensibile, senza possibilità di vederne la fine per chi vi si trovava dentro, assomigliava alla guerra. Per milioni di persone che le avevano subite entrambe, ognuno di questi eventi era accaduto a loro – ne erano le vittime, non i colpevoli. Il romanziere inglese J.B. Priestley, ritrovatosi con i sopravvissuti del suo battaglione al piano superiore di una taverna a Bradford nel 1933, dopo diciassette anni da quando li aveva lasciati sulla Somme, si rese conto che alcuni di loro mancavano perché erano talmente poveri da non potersi permettere di partecipare. Assieme ai commilitoni di un tempo, brindò alla memoria dei caduti, uccisi da vecchi grassoni e diplomatici col monocolo, dai giornalisti a caccia di storie e dalle donne che avevano sventolato le bandiere. Ma non ai vivi, «i quali avevano combattuto per un mondo che non li voleva, erano tornati per cambiare le loro uniformi con degli stracci». Erano senz’altro vittime anche loro, come quelli che avevano lasciato laggiù, ma i volti dei loro persecutori erano più oscuri. «E chi restituirà loro gli anni che la locusta si è mangiata?»2.
I malcontenti causati prima dalla guerra e poi dalla pace si incrociavano a tratti, ma erano destinati ad unirsi. Nel 1932 l’opinione comune associava già la Grande depressione alla Grande guerra; gran parte dell’opinione colta dipingeva la seconda catastrofe come un cupo postumo della prima. Su come esattamente la causa avesse prodotto l’effetto non c’era il minimo accordo: alcuni incolpavano l’inflazione del periodo bellico e degli anni immediatamente successivi, altri la dura deflazione che, in conseguenza di ciò, era stata imposta dai governi; c’era chi puntava il dito contro le riparazioni dovute dalla Germania ai suoi vincitori e le somme che questi a loro volta dovevano agli Stati Uniti, contro tutti i debiti sovrani che la guerra aveva lasciato dietro di sé alterando profondamente e a lungo la dinamica degli scambi dopo la fine delle ostilità; altri sottolineavano l’ascesa di nuovi produttori e mercati nel periodo bellico e l’eccesso di offerta e la saturazione che ne erano derivati; altri ancora, lo sperpero di risorse per finanziare gli eserciti e le marine, una dipendenza da cui gli ex belligeranti si rifiutavano ostinatamente di affrancarsi. La dottrina sovietica e quella comunista attribuivano entrambe la colpa dei parossismi a livello globale alla stessa lotta imperialista per il dominio dei mercati. A Ginevra i venticinque esperti della «Gold Delegation», riunita per la prima volta nel 1929 dalla Società delle Nazioni per compiere un’indagine sulle istituzioni finanziarie mondiali, attribuì la causa di molti dei problemi monetari internazionali, fonte della paralisi commerciale e per estensione della disoccupazione e della miseria, alla guerra. E i politici ripresero il tema3. Negli Stati Uniti il presidente Herbert Hoover, nell’ottobre di quell’anno, durante la campagna elettorale che lo avrebbe portato alla rielezione, parlò agli agricoltori dello Iowa e agli abitanti di Cleveland dell’«enorme eredità del debito», dell’aumento degli eserciti permanenti e dei tracolli finanziari di una follia internazionale che ora raccoglieva quello che aveva seminato4. Fu una dichiarazione elettorale di dubbia efficacia, poiché teorie del genere, fondate o meno, potevano persuadere ma non certo spostare la massa dei suoi ascoltatori. Il presidente desiderava assolvere gli Stati Uniti e incidentalmente la propria amministrazione dalla responsabilità di una depressione che non voleva mollare. Loro volevano qualcosa di più semplice.
Identificare le sventure dei loro ascoltatori con quelle della nazione, gli aspiranti al potere con chi già lo deteneva, significava attribuire la colpa alle potenze oltreconfine, o al nemico interno, o ad entrambi. Si offriva così un fondamento nazionalistico al risentimento: la nazione stessa diventava la vittima della guerra passata e della depressione in corso, secondo una narrazione che allo stesso tempo nobilitava ed esonerava da responsabilità i cittadini e forniva una spiegazione alle ingiustizie che venivano loro inflitte. L’economia, come la guerra, era diventata una questione che riguardava tutti, un affronto alla nazione che pochi potevano capire ma di cui molti soffrivano. In tutte le maggiori potenze e anche in alcune di quelle minori, la gente guardava ai capi politici per individuare la via che portasse a una rigenerazione nazionale, nonché a staccarsi o a mettersi al sicuro dal mondo ostile di fuori. Nessun leader internazionalista, nessuno di coloro che ricercavano soluzioni collettive alla miseria e all’insicurezza che affliggevano il mondo poteva sperare di avere spazio in un clima del genere. E nessuno lo fece.
Il vittimismo cominciava dalla realtà vissuta. Verso la fine degli anni Venti uno scrupoloso critico francese analizzò circa trecento testimonianze di prima mano sulla guerra pubblicate da soldati o da ufficiali. «Vediamo morire, molto più spesso che uccidere», scriveva5. E per una ragione ben precisa: in quella guerra industriale fatta di cannoni a lunga gittata e da granate ad alto potenziale esplosivo, nella maggior parte dei casi gli artiglieri facevano fuoco senza vedere i loro bersagli umani, e gli uomini morivano senza vedere i propri uccisori. Perfino nell’epica celebrativa che permeava la letteratura popolare, le opere teatrali e i film, e inondava le più famose cantilene pacifiste, la rappresentazione delle vittime era sostanzialmente la stessa: quella ispirata all’idea di un inutile eroismo, di un nobile fallimento, di una virtù ambigua. Quando nel 1932 in Francia uscì il film tratto dal romanzo Le croci di legno di Roland Dorgelès, con la sua inedita attenzione all’angoscia e al tormento della guerra, i critici si dettero valorosamente da fare per interpretarne il realismo. Secondo uno di loro, la pellicola esaltava al tempo stesso la cavalleria e lo spirito combattente dei francesi, e tuttavia «la storia filmata di quell’eroico plotone susciterà orrore per la guerra e promuoverà la pace mondiale»6. Questa confusa benevolenza riusciva a vedere solo la sofferenza dei soldati.
Poteva anche puntare un dito accusatore contro i compatrioti civili, colpevoli di aver tradito il sacrificio dei combattenti. Nell’autunno del 1932, a Parigi come a Berlino, il pubblico dei teatri che assisteva alla rappresentazione di Miracolo a Verdun, del drammaturgo austriaco Hans Chlumberg, poteva vedere in scena corpi macilenti che sorgevano dalle tombe di un cimitero delle Argonne. Le scene di resurrezioni di massa erano diventate uno spettacolo comune da quando durante la guerra Abel Gance aveva girato J’accuse. Anche in questa pellicola, i soldati ritornano in vita, per poi trovare i loro posti occupati, le mogli che si sono risposate, le proprie gesta eroiche ormai passate nel dimenticatoio. Nel dramma di Chlumberg i francesi e i tedeschi si risvegliano dopo sedici anni dal loro sonno per fraternizzare, vittime chiaramente non del nemico ma della loro stessa parte. I critici non ne furono colpiti. La lontananza del fronte da casa, reale durante la guerra ma anche dopo, era tale però da condannare alla marginalità quegli stessi soldati ufficialmente venerati come idoli. Il successo popolare di racconti d’occasione dal tono indignato in cui venivano presentati come carne da cannone fece il resto. Alcuni erano il frutto della penna di autori che avevano una reputazione autorevole. La World Crisis di Winston Churchill negli anni Venti e le memorie di Lloyd-George nel decennio seguente, vasti ma imprecisi atti d’accusa nei confronti dei generali che avevano gettato via un’intera generazione di giovani, apparvero a puntate e in versioni abbreviate destinate a un pubblico di massa7. Le reclute erano tre volte vittime: del nemico, dei civili e del generale; in una parola: della guerra.
Per quale motivo la nazione a cui quella recluta apparteneva non doveva subire analoghe pene? E, soprattutto quando ne era uscita sconfitta, addossarsi simbolicamente la propria condanna? Hitler perfezionò l’operazione, individuando quella recluta e quella nazione sconfitte con la sua stessa persona. Egli desiderava incarnare il soldato semplice e al contempo la nazione tedesca, tradita nel novembre del 1918 dai criminali e dal loro armistizio, mentre lui stesso si trovava temporaneamente accecato in un letto di ospedale in Pomerania. Hitler non smise mai di ricamare su questo tema. Che produceva il suo effetto. Unica fra le potenze sconfitte, la Germania nutriva l’illusione di aver perso non la guerra, ma solo la vittoria finale. Nel 1932 gli spettatori teatrali di Mannheim, e all’inizio dell’anno seguente anche quelli di Berlino, poterono assistere a Die Marneschlacht (La battaglia della Marna) di Paul Joseph Cremers, in cui le dramatis personae del grande scontro che pose fine all’avanzata tedesca nel settembre del 1914 venivano presentate come personaggi di una tragedia evitabile. «Il popolo e l’esercito tedeschi avevano vinto la battaglia del...