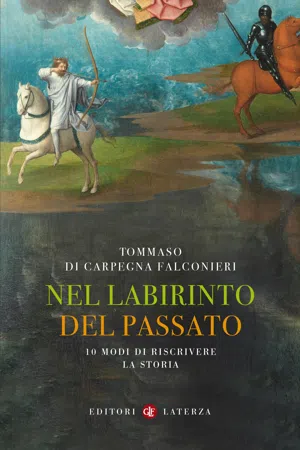1.
La storia al tempo delle fake news
Ci sono qui tanti, non dico furfanti matricolati,
ma cavalieri erranti e scudieri erranti, monaci erranti e menestrelli erranti,
giocolieri erranti e buffoni erranti che un uomo con un solo
marco in tasca sarebbe in pericolo.
Walter Scott, Ivanhoe, cap. XI, pp. 153-154
«Papà, spiegami a che serve la storia». La domanda – se mai viene posta – proviene da ragazzi che concepiscono come un attentato alla loro libertà dover imparare a memoria nomi, date e battaglie, annaspando in un flusso di dati asfissiante. Infatti – molti lo dicono e moltissimi lo pensano – la storia è noiosa. È del tutto slegata dalla vita vera, la vita nostra, cioè quella di tutti i giorni: Cesare, Carlomagno e Napoleone, la rivoluzione agraria e quella francese... ma per favore! Che cosa hanno a che fare con me? Che c’entro io con l’uomo del Similaun, gli Incas o la prima guerra mondiale? «Spiegami a che serve la storia» risulta una domanda retorica, a cui l’unica risposta possibile, quella che i papà spesso avrebbero voglia di dare, è: «Chiedi a mamma».
«Papà, spiegami allora a che serve la storia» è proprio la frase con cui Marc Bloch, uno tra i maggiori storici del Novecento, inizia il suo libro Apologia della storia (Bloch 1949, p. 7 dell’ediz. 2009). È la primavera del 1941, la Francia è occupata e Bloch ha tutte le ragioni per domandarsi a cosa serva questa disciplina in un’ora così buia per il suo Paese, quando la civiltà in cui è vissuto e si riconosce è minacciata a morte dai nazisti, quando occorrerebbe combattere anziché studiare. O magari combattere e studiare insieme? Bloch fa entrambe le cose: capitano e poi partigiano, morirà con onore fucilato dai tedeschi; professore e ricercatore, scriverà quel suo piccolo capolavoro che ancora oggi è il livre de chevet di molti studiosi e viene suggerito agli studenti universitari come un imprescindibile punto di partenza nella metodologia della ricerca storica.
«Papà, spiegami a che serve la storia», dunque: non siamo nel 1941, i nostri Paesi occidentali non sono direttamente coinvolti in guerre combattute sul proprio suolo (diversi altri, purtroppo, lo sono), ma la domanda resta più attuale che mai. Perché? Perché oggi come durante la guerra mondiale, come durante tutte le guerre, noi siamo avvelenati dalle «tossine della menzogna» – le parole sono sempre di Marc Bloch – e «la storia viene falsificata nei suoi dati essenziali», come scrisse in quello stesso lontano ma attuale 1941 Altiero Spinelli, uno tra i fondatori dell’Europa unita.
Oggi siamo immersi nelle fake news. I mezzi di comunicazione e i social network di ogni tipo propagano rumors, voci, dichiarazioni e smentite a velocità turbinosa. Tutti parlano, tutti scrivono, tutti pubblicano, tutti modificano. Le bufale galoppano nei prati del web. Le notizie sono più importanti dei fatti. Anzi, il fatto corrisponde alla notizia: senza notizia, niente fatto. E se poi dietro alla notizia il fatto non c’è mai stato, tanto peggio: la notizia si regge e si legge lo stesso. In fondo, non vi è nulla di più vero di una cosa inventata, che produce comunque i suoi effetti. Noi siamo talmente impantanati in questo modo di accostarci alle informazioni – di più, alla realtà – da usare ormai in modo disinvolto espressioni che in teoria non avrebbero senso, come ‘realtà virtuale’ (un ossimoro) e ‘dire la propria verità’, mentre un ‘reality’ (show) è esattamente l’opposto del suo nome: è una messa in scena. Vaghiamo in un mondo in cui si sono dissolte le nozioni di verità e oggettività, che ha oltrepassato la postmodernità, un mondo in cui la decostruzione della realtà e la sua sostituzione con la sola interpretazione ha raggiunto livelli inimmaginabili persino per Nietzsche. Vaghiamo nella foresta di Brocéliande e siamo tutti cavalieri ‘erranti’. Nei due sensi: non solo vagabondiamo, ma sbagliamo in continuazione. Come nell’inquietante quadro Il cavaliere errante che Oskar Kokoschka dipinse nel 1915, autoritratto in armatura, sbattuto a terra dalla tempesta, in un paesaggio marino che sembra una fangosa trincea (Domenichelli 2004, p. 324).
Tutto questo non è nuovo, anzi ci facciamo i conti da decenni: la realtà è scomparsa (Jean Baudrillard), il pensiero è debole (Gianni Vattimo), la modernità è liquida (Zygmunt Bauman). Cose del genere, le si sapevano e le si dicevano da tempo, tanto che Umberto Eco, già al principio degli anni Settanta, elencava dieci «regole di manipolazione» delle notizie (Eco 1973, pp. 20-26). Ma a parte qualche studioso, chi ci credeva davvero? La televisione equivaleva comunque al vangelo. Oggi, invece, siamo convinti che ‘non bisogna crederci’. La consapevolezza che viviamo in una cultura costruita sulla sofisticazione delle informazioni oggi è davvero diffusa. Una volta esisteva il pensiero unico e chi non vi aderiva era deviante. Da quando è arrivato il web, il mondo si è spalancato. Il web è il principale canale di informazione per la maggioranza delle persone ed è intrinsecamente pluralista. La sua evoluzione 2.0 (la possibilità degli utenti di interagire e modificare i contenuti delle pagine) ha innescato una rivoluzione culturale, perché ha reso un soggetto plurale non soltanto i lettori, ma anche gli autori. A certuni ha offerto il miraggio della democrazia diretta, a molti ha permesso di comprendere per esperienza personale che ogni informazione è alterabile. Che esistono hacker, influencer, hater e troll, che vi sono persone che studiano e mettono in atto sistemi per condizionare l’opinione dei singoli. Di milioni di singoli. Che le elezioni di un grande Paese possono essere pilotate. Che i tweet possono essere fatti a macchina, creati con algoritmi. Che noi stessi possiamo scrivere, commentare e mettere dei like, pubblicare testi, foto e filmati (mentre cancellare è molto più difficile). Tutto si muove e cambia, e lo fa molto in fretta. Le vecchie pagine di Facebook sono sepolte dal presente che avanza, verso il quale siamo protesi e nel quale quotidianamente ci acquattiamo.
Insomma non vi è dubbio: viviamo tempi interessanti (si dice che in cinese «che tu possa vivere in un’epoca interessante» sia una maledizione [Eco 1977, p. 211], speriamo non lo sia per noi): tempi di una rivoluzione culturale che equivale a quella dell’introduzione dei caratteri a stampa al principio dell’età moderna. Proprio per questo, siamo anche disorientati. Qualche punto cardinale è saltato, perché realtà e finzione oggi si equivalgono, o almeno non sappiamo dove trovare gli strumenti per distinguerle.
«Papà, spiegami a che serve la storia». A partire dalla mia esperienza di uomo curioso, di lettore e ricercatore che, per una ragione o per un’altra, si è trovato tutta la vita immerso nello studio delle testimonianze del passato, mi sento di dire: il ruolo della storia in una società in cui la realtà sembra essere scomparsa è quello di riaffermarla. Con metodo, stile e coscienza critica. Questo è il succo del libro. La realtà esiste, a prescindere da tutti gli alias che ci vogliamo attribuire e dalle fake news che sappiamo riconoscere o meno. È la realtà dei fatti accaduti, che implica la responsabilità delle azioni personali e collettive che compiamo. La storia serve a proporre un metodo, un orientamento e un percorso.
Questa disciplina vecchia tra le vecchie ha ancora da dire la sua. Per quali motivi? Non certo perché la conoscenza storica sia l’unica che permetta la comprensione del reale: non siamo storicisti, almeno non fino a questo punto. Altre discipline, dalla fisica alla sociologia, aiutano a capire il mondo. Ma la storia possiede alcune qualità che la rendono essenziale, adesso più che mai. La principale è banale ma occorre ripeterla: i fatti accadono in un modo e in uno soltanto. Sono le interpretazioni che mutano, non i fatti. Esiste una realtà materiale del fatto, realtà che la storia è chiamata a cercare e comprendere. L’atteggiamento dello storico, oggi (solo oggi, naturalmente) è umile: consiste nel tentare di ricostruire i fatti del passato, di interpretarli e di dare conto degli elementi di interrelazione. Tutto questo attraverso la proposizione di molte domande e la formulazione di altrettanti dubbi. La storia è magistra vitae, è proprio vero. Non però nel senso che si dà di solito all’espressione, in quanto i fatti non si ripetono mai e noi dal passato non impariamo granché. Ma nel senso che la conoscenza in forma storica è maestra di vita. La storiografia non è un’arte pratica, una techne; è invece un modo di razionalizzare la propria esistenza e quella delle culture con cui si entra in contatto. A chi la esercita e a chi la riceve, la ricerca storica insegna un modo di conoscere perché educa a cercare e dubitare, e di conseguenza a verificare o confutare. Come scrive Patrick Boucheron (e sottoscrivo), «con la storia si può trasmettere e provare un pensiero critico che spesso sortisce un effetto di emancipazione – insegnarla non è mai una perdita di tempo» (Boucheron 2011, p. 74 dell’ediz. 2016). Questo non riguarda soltanto i fatti, ma anche (anzi soprattutto) le interpretazioni, in quanto la storiografia riflette da sempre su se stessa, si fa i conti addosso. E qui arriviamo al cuore del problema. Le fake news, le bufale e le interpolazioni – in breve, tutto ciò che è ‘falso’ o ‘alterato’ – sono oggetto di indagine storica, da leggersi in questa prospettiva ampia. Di più: lo studio delle falsificazioni è alla base della storiografia moderna (lo vedremo nei prossimi capitoli), perché le falsificazioni sono esse stesse eventi storici, hanno conseguenze tangibili e come tali sono suscettibili di analisi da parte degli studiosi.
Acquisire una mentalità storica è dunque una qualità utile (non voglio arrivare a dire indispensabile, ma ci sono vicino) per accostarci con equilibrio proprio alla realtà così mobile in cui viviamo. Serve a storicizzare, cioè a collocare e spiegare (e di conseguenza, se necessario, disinnescare) le news, le informazioni che ci piovono da tutte le parti e che non di rado sono fake. È da molto tempo che gli storici e i filologi si pongono questo tipo di problemi e hanno sviluppato metodi di analisi e critica delle testimonianze: da quando Lorenzo Valla, nel 1440, ha dimostrato la falsità della Donazione di Costantino (ne parleremo ancora); da quando Jean Bolland ha iniziato a curare gli Acta Sanctorum (1643), in cui le vite dei santi sono sottoposte a vaglio critico – e dunque si struttura scientificamente l’analisi del falso storico – e Jean Mabillon ha pubblicato il De re diplomatica (1681), fondando la disciplina che studia i documenti e plasmando così il concetto di falso documentario. Si può ben dire dunque, facendo proprio il motto di RAI Storia, «il passato non è mai stato così attuale»; ma si può anche dire, con ancora maggior convinzione, «lo studio del passato non è mai stato così attuale».
C’è però un problema, e non di poco conto. Un problema che sta alla base di questo libro. La storia versa in una crisi nera. Sempre meno sono coloro che le danno ancora credito; a seguire il volo in caduta libera che ha fatto dall’Ottocento, non per niente chiamato ‘il secolo della storia’, vengono i brividi. «Lo sceglievano in pochi, è inutile»: è dell’autunno 2018 la notizia che il tema di argomento storico è stato abolito dall’esame di maturità dei ragazzi italiani (il fatto che nel 2020, se non fosse esploso il Covid-19, sarebbe stato ripristinato fa emettere un sospiro di sollievo, ma non elimina il problema). Tante sono le ragioni di questa acuta crisi della storia, dal suo ormai sempre maggior distacco dalla politica, alle chiusure esoteriche (vere o presunte) degli accademici, alla sua asserita inutilità nell’esercizio di attività pratiche e persino nell’agone politico, all’incapacità ormai intervenuta tra la gente di pensare il mondo e la stessa propria esistenza in termini di svolgimento diacronico, anziché come un presente onnipresente, che si dimentica subito. Fino all’attacco alla stessa natura di ‘scienza’, ché tale secondo alcuni la storia non sarebbe. «La storia è un’arte retorica, è letteratura»: tutto questo è stato detto con autorevolezza. Di conseguenza, per fare storia basta narrare. Basta occuparsi del passato. Lo possono fare tutti, perché il web è aperto a tutti. Basta dire qualcosa che attiene alla storia per fare storia. Che sia vero o falso non ha importanza. Un saggio storico e un romanzo storico si equivalgono: sono ‘storici’ entrambi. Ecco, ci risiamo. Turbiniamo di nuovo nell’indefinito rapporto tra realtà e finzione, tra fatto e racconto, tra ricostruire un accadimento e propalare una falsa notizia.
Tante, e tutte benvenute, sono le reazioni che si stanno prospettando negli ultimi anni in risposta e a difesa della vecchia bandiera della storia, che nessuno vuole più sia innalzata alla testa dei destini delle nazioni (lo ha fatto in passato e l’esperienza non è da ripetere), ma che non vogliamo neppure venga ripiegata, pena il rischio di perdere la consapevolezza del nostro essere uomini nel tempo, oltreché nello spazio e nel consumo quotidiano. Ben vengano, dunque, iniziative come il manifesto La storia è un bene comune promosso nel 2019 da Andrea Giardina, Liliana Segre e Andrea Camilleri. Ben vengano iniziative pop come il Festival del Medioevo di Gubbio e i Rendez-vous de l’histoire di Blois. Negli ultimi anni si parla di nuovo e sempre più dell’uso pubblico della storia, riproponendo come una necessità il ripristino del legame tra la società contemporanea e la riflessione sul passato.
La proposta di questo libro va in questa direzione, in una chiave che dirò leggera: è una riflessione sui tanti modi di inventare la storia. Non parlo dunque tanto dei romanzi storici, che, bene o male, si presentano onestamente come opere di fantasia (anche se Dan Brown ha affermato che il 99% di quello che ha scritto ne Il codice da Vinci è vero), bensì essenzialmente di quelle interpretazioni che si propongono come storiche mentre non lo sono, o lo sono soltanto in parte, o lo sono state ma oggi vanno prese con le molle. Di queste interpretazioni ve ne sono moltissime, spesso divertenti, a volte inquietanti, a volte pericolose. Si tratta di racconti la cui presentazione è – credo – utile per capire la società in cui viviamo e il senso che molti danno oggi alla parola ‘storia’. Del passato non ci dicono granché, ma ci rivelano i modi con cui noi entriamo oggi in relazione con il passato, inventandocelo.
Il libro non ha intenzioni censorie e non nasce da analisi filosofiche, semiologiche o sociologiche, bensì dall’esperienza: quello che propongo qui, nella forma di una conversazione (e di quando in quando dell’ego-storia), è proprio «il vero delle cose certe che io vidi e udii», come scriveva Dino Compagni settecento anni fa. Solo che si tratta di storie raccolte alle soglie del bosco. Rifletto sulla storia a partire dai suoi bordi frastagliati, da ciò che le sta intorno: la relazione con le falsificazioni, la contiguità con la letteratura, la tendenza ad assumere forme determinate da modelli preesistenti e da convinzioni ideologiche, l’inclinazione a costruire situazioni immaginarie che si propongono, mimetizzandosi, come fatti accaduti, la confusione tra analogie apparenti e corrispondenze dimostrabili. Insomma evidenzio alcune irrisolutezze della storia con l’intenzione di rivelare tutta la forza conoscitiva che essa, al contrario, possiede. Quella che segue è una sorta di personale collezione di meraviglie, una Wunderkammer di storie straordinarie. L’imporsi, nella nostra società, dell’incapacità di distinguere tra fatto e racconto, tra avvenimento e notizia/propaganda, tra vita reale e virtual reality, rende queste storie seducenti senza che però si avverta il bisogno di valutarne l’attendibilità e la conformità a criteri riconoscibili di autenticità. Invece esse rispondono a ragioni culturali, meccanismi compositivi e forme di aggregazione delle informazioni che qui vengono presentati attraverso una esemplificazione tratta da varie epoche, con una prevalenza per l’età attuale, visto che ci viviamo dentro, e per il medioevo, che è la mia specialità.
Tutto questo per riflettere divertendosi. Perché la storia dà diletto: Marc Bloch e dopo di lui Michel Foucault e Patrick Boucheron lo sanno bene, tanto da avere tutti affermato che una delle ragioni per cui si fa ricerca, oppure si leggono libri di storia o si diventa professori di questa disciplina, è proprio quella che ci si diverte. A ottantadue anni, Cesare Segre scrive Dieci prove di fantasia, un libretto contenente monologhi e interviste impossibili ai personaggi con cui ha avuto a che fare per tutta la vita nei suoi studi filologici e letterari: i personaggi forniscono la loro irriverente e inaspettata versione dei fatti, anche contestando i propri autori (Segre 2010; Longobardi 2014). E come non ricordare Allegro ma non troppo di Carlo Maria Cipolla? Il grande storico dell’economia costruisce una parodia della storia occidentale attraverso il pepe; poi enuncia le «Leggi fondamentali della stupidità umana». E ci prende. Dice il Cuoco nei Racconti di Canterbury di Chaucer: «Tra scherzi e giochi gran verità si posson dire». È un peccato che non esista, per la storia e per le discipline umanistiche in genere, l’equivalente del Premio IgNobel, conferito dal 1991 a dieci ricercatori di materie scientifiche, tecnologiche e mediche che...