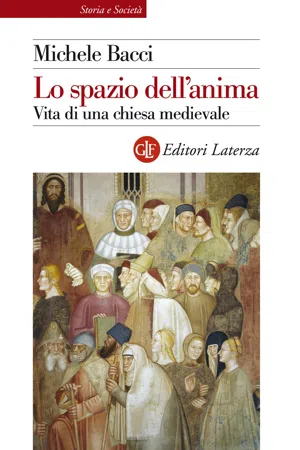III.
Le parti della chiesa
Il corpo della chiesa
Secondo una concezione ben diffusa, e ripetuta spesso nei commentari liturgici, l’articolazione interna delle chiese riproduceva quella del corpo umano e proprio in virtù di questo era scandita da una ben precisa gerarchizzazione spaziale: ogni edificio si suddivideva in tre zone il cui significato era definito dalla dignità morale delle persone che vi si disponevano durante gli offici (Fig. 1). Alla testa corrispondeva il «santuario», cioè il presbiterio, ovvero il luogo dove si ergeva l’altare e in cui risiedeva il sacerdote con i suoi assistenti durante la messa; lo spazio antistante, ossia il coro in cui le comunità di religiosi sedevano mentre assistevano al rito, assieme con i prolungamenti laterali (le due braccia del transetto, laddove presente) equivalevano chiaramente al busto con le braccia e le mani; infine, tutto quello che rimaneva verso occidente e verso la porta d’ingresso, ovvero la navata che era lo spazio riservato ai laici, poteva essere paragonato alla parte meno nobile della persona, quella dall’addome fino ai piedi.
In questa disposizione tripartita si rispecchiava lo stato di perfezione spirituale di coloro che abitavano le diverse zone: in quella più ristretta, dove la liturgia veniva messa in atto, si riconoscevano immediatamente coloro che erano in uno stadio più avanzato. Se questi si attenevano a un ideale di verginità e purezza e i secondi perseguivano una vita da continenti, gli ultimi erano inevitabilmente associati alle debolezze mondane, giacché si sposavano e mettevano su famiglia, praticando il commercio carnale1. Secondo una concezione largamente diffusa, erano due i «generi» di cristiani, che differivano gli uni dagli altri «quanto la luce si distingue dalle tenebre»: c’erano le persone mondane che vivevano in uno stato di vita imperfetto, contaminato dal peccato, e c’erano quelli che, dediti agli offici e alla preghiera, agivano da mediatori per la comune salvezza del genere umano2.
Un po’ come il busto è separato dalle parti disoneste del corpo dalla cintura, così, all’interno delle chiese del tardo Medioevo, i laici erano divisi dai chierici da diversi tipi di barriere architettoniche. In tutta una serie di edifici, perlopiù risalenti al periodo romanico, il coro, che era abitualmente delimitato da un «recinto» in pietra o legno, si disponeva sopra una struttura rialzata che sovrastava l’accesso a una cripta, ossia a un ambiente sotterraneo utilizzato per il culto di qualche antico e venerabile santo. Il dislivello, in qualche caso, poteva essere anche molto forte e molto probabilmente i fedeli dovevano avere una percezione piuttosto limitata (solo sul piano uditivo, molto meno su quello visivo) dell’azione liturgica. In altri contesti le singole zone erano contrassegnate semplicemente dalla presenza di recinzioni (cancelli) disposte sul livello del pavimento e sovrastate da elementi trasversali in legno o pietra (detti transenne), ai quali si fissavano veli per ostacolare la visione delle parti più nobili; talora tutti questi elementi erano uniti a formare strutture non molto dissimili dai templa, ossia le più antiche iconostasi delle chiese bizantine (Tav. 24). In entrambi i casi, si trattava di diaframmi sottili che potevano avere forme più o meno «aperte»: poteva trattarsi sia di una sequenza di arcatelle che, quando non erano coperte con le tende, lasciavano vedere la parte più nobile della chiesa (Tav. 5), sia di una superficie cieca e compatta, in cui erano ricavate una o più porte e, eventualmente, qualche minuscola finestrella (Tav. 4).
Un elemento caratteristico dell’architettura occidentale era il ricorso, soprattutto nel contesto delle chiese monastiche subito imitate anche da quelle degli Ordini mendicanti, a un vero e proprio muro, talora di spessore molto profondo, che era detto jubé in Francia, Lettner in Germania, rood screen in Inghilterra e «muro dei cancelli» o «tramezzo» o anche «ponte» in Italia. La posizione più consueta era a metà circa della navata, ma non mancavano casi in cui, a seconda delle esigenze specifiche del luogo, si preferiva disporli più a ridosso del presbiterio o, persino (come nell’abbazia di Vezzolano in Piemonte), in stretta prossimità dell’ingresso; talora una chiesa poteva accogliere anche più di una barriera al suo interno, anche se va detto che abitualmente ciascuna di queste corrispondeva alla larghezza della navata centrale e non si estendeva necessariamente anche a quelle laterali.
Di norma si trattava di strutture praticabili di varia foggia («a muro» oppure a forma di loggiato o di pergamo) in cui i celebranti potevano all’occorrenza salire per recitare qualche officio: vi era anche addossato il pulpito utilizzato per le letture e per le prediche e si aveva l’abitudine di disporvi sopra immagini sacre e altari. Alcuni avevano dimensioni così larghe da ospitare un certo numero di cappelle – ossia di vani voltati e dotati di altare che venivano utilizzati per lo svolgimento delle messe in suffragio dell’anima di singoli individui. Un caso piuttosto impressionante è quello di Santa Maria Novella a Firenze, di cui sappiamo che aveva uno spessore di oltre sette metri3.
Nel loro complesso, tutte queste barriere, al di là della loro complessità o dell’apparenza più o meno massiccia, rispondevano sia alla volontà di enfatizzare la sacralità del «santo dei santi» creando una sorta di facciata interna della chiesa, sia all’esigenza di impedire o quantomeno di contenere la frequentazione del coro e del santuario da parte dei fedeli disposti nella navata. I frati mendicanti, già pochi anni dopo i loro primi insediamenti nelle città d’Italia, si resero presto conto che queste soluzioni architettoniche erano necessarie perché altrimenti i laici – uomini e donne – non si sarebbero fatti scrupolo ad avvicinarsi e a mescolarsi ai religiosi persino durante la liturgia. Già nel 1239 i Predicatori di Sant’Eustorgio a Milano costruirono degli spazi riservati per sé e per i propri conversi (con appositi cori dotati di stalli) e contemporaneamente separarono questi ultimi dalla navata per mezzo di un solido muro che li nascondeva quasi del tutto dagli sguardi indiscreti: c’era infatti solo una porticina, sulle cui ante furono dipinti i primi frati che san Domenico aveva inviato in città, e due finestrelle da cui i fedeli, a turno, potevano affacciarsi; al di sopra fu disposto subito il pulpito e, nel giro di qualche anno, vi furono anche costruiti tre altari4.
Al giorno d’oggi abbiamo difficoltà a immaginare quanto dovesse esser faticoso assistere alla messa in edifici che erano provvisti di simili barriere visive soprattutto perché queste ultime, dopo esser divenute obsolete già nel corso del Quattrocento (e in qualche caso particolare già nel Trecento5), furono sistematicamente rimosse in seguito alla nuova disciplina ecclesiastica inaugurata dal Concilio di Trento. Per la Chiesa della Controriforma, paradossalmente, il coinvolgimento del popolo nel rito era un imperativo tanto forte quanto lo era stata la sua sostanziale esclusione nei secoli precedenti. Nel tardo Medioevo i fedeli laici non erano chiamati ad interagire con i celebranti nel corso dell’officio, salvo in alcuni momenti rituali ben definiti: a loro era richiesto piuttosto di concentrarsi nella preghiera e nel pentimento dei propri peccati, attraverso una serie di gesti e atti esteriori che acquistavano un valore aggiunto se svolti in sintonia con le singole parti della messa. Quella più importante, che coincideva con la recitazione del Canone, ossia delle formule di consacrazione del pane e del vino eucaristico, doveva avvenire sottovoce proprio per impedire che fosse udita dal popolo: se così fosse stato, si sarebbe corso il rischio che il mistero centrale della liturgia venisse impropriamente ripetuto da bocche profane e, al contempo, che i fedeli venissero distratti dalle loro devozioni6.
A metà del diaframma divisorio tra il clero e il popolo si ergeva, in molti casi, un altare sormontato da una croce detta trionfale: nella messa, questo serviva non solo come luogo deputato alla celebrazione per i defunti, ma anche come vero e proprio punto focale per la contemplazione dei fedeli (cfr. Tav. 4)7. Anche laddove questo elemento non era presente la sua funzione era svolta da un crocifisso monumentale, dipinto o scolpito, posto sulla sommità del tramezzo; la sua funzione è ben illuminata da una delle Facezie del Piovano Arlotto che descrive così un uso che, nel Quattrocento inoltrato, sembrava ormai démodé:
Fu in questa nostra città di Firenze una badia di monaci osservanti, la quale badia era edificata allo antico modo, cioè che nel mezzo della chiesa era uno muro o vero uno legno attraverso, in sul quale era uno antico e grande crocifisso legato al muro con una catena o vero corda. E come voi sapete si fa ne’ luoghi d’osservanza, li monici sempre dicono le sette ore canoniche e quelle cantano in coro, e li loro laici conversi dicono a ogni ora canonica, in iscambio del divino uficio, certi paternostri e avemarie, in quello modo come da’ loro maggiori è ordinato.
Da queste parole apprendiamo come la distinzione spaziale marcata dal tramezzo comportasse, da parte di coloro che stavano al di qua o al di là, un diverso impegno: da una parte si recitavano i riti liturgici, dall’altra si contraccambiava pronunciando devote preghiere. Il personaggio della storia è un converso che si dedica a tutto questo con un’intensità singolare:
In questa badia – continua il piovano – era uno laico converso il quale era molto devoto e a tutte l’ore diceva divotamente li suoi paternostri e avemarie, sempre ginocchione, che mai non mancava a questo crocifisso; e come piacque a Dio, uno giorno quando quello converso diceva le sue divozioni a ora di vespro, ginocchioni innanzi al crocifisso, ruppesi quella corda o vero catena, in modo che il crocifisso...