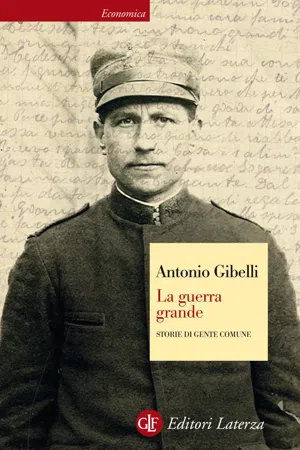Prigionieri
L’Europa dei prigionieri
Dei 4 milioni circa di soldati italiani che conobbero l’esperienza del fronte per tempi più o meno lunghi, circa 600.000 furono quelli che vennero coinvolti nella vicenda non meno drammatica, spesso più dura e nel complesso caratterizzata da un tasso di mortalità superiore (circa 16%), della prigionia. Di questi 600.000, circa la metà furono catturati durante la disfatta di Caporetto e trascorsero nei campi austro-tedeschi l’ultimo anno di guerra. Si tratta di una massa ingente di persone sulle quali nel dopoguerra fu steso a lungo un velo di silenzio, maltrattate, circondate spesso da sospetti e sottoposte a interrogatori. I loro sacrifici, non trasfigurabili in termini di epopea eroica, vennero per lo più misconosciuti. La stessa storiografia ha tardato molto ad occuparsi di loro. Solo nel tardo Novecento si è manifestata una nuova attenzione per i protagonisti non combattenti del conflitto, dalle donne ai profughi, dalle popolazioni soggette a occupazione agli internati fino, appunto, ai prigionieri: tutte categorie che furono profondamente coinvolte nel conflitto, che ne furono interamente partecipi sia pure in modi diversi dal maneggiare le armi e dal subirne direttamente gli effetti, che furono – in una loro parte significativa – ugualmente trascinate per mezza Europa, conobbero la promiscuità tra nazionalità, spesso sperimentarono di persona le condizioni di degrado in cui la guerra aveva gettato la vita del continente, furono separate per tempi anche assai lunghi dalle proprie terre e dalle proprie comunità, talvolta dai loro familiari.
Quando si parla dell’Europa in guerra dunque bisogna pensare non solo ai 70 milioni circa di mobilitati ma al numero molto maggiore di uomini e donne non appartenenti alle classi agiate, non in grado in alcun modo di ripararsi dalle sue conseguenze devastanti e ancor meno di trarne profitto, che costituivano la maggioranza dei suoi abitanti. Tra i non combattenti, i prigionieri furono in molti casi coloro che pagarono i prezzi più alti, e i prigionieri italiani a loro volta quelli che subirono, specialmente a partire dal 1917, tra le sofferenze peggiori. Ciò avvenne nel quadro delle carenze alimentari generali che colpirono gli imperi centrali col prolungarsi del conflitto e che si riverberarono sulla popolazione detenuta. Ma a determinarle furono le diffidenze dei governi e delle classi dirigenti italiane nei confronti dell’affidabilità e fedeltà patriottica dei propri combattenti soprattutto di estrazione popolare. Tali diffidenze vennero acuite dalla vicenda della rotta di Caporetto e dalla lettura prevalente che ne fu data, quindi dal sospetto di scarsa combattività, di arrendevolezza se non addirittura di ribellione e di diserzione che gravò sulla maggior parte dei soldati, ciò che suggerì la calcolata rinuncia da parte del governo a tempestivi e coordinati aiuti alimentari ai detenuti. Solo tali aiuti avrebbero potuto salvare la vita di molti, alleviare le condizioni di tutti in una situazione resa drammatica dall’improvviso, contemporaneo afflusso di masse ingenti di catturati nei luoghi di prigionia ormai sulle soglie dell’inverno. In questo senso la vicenda dei circa 600.000 prigionieri italiani degli imperi centrali nella prima guerra mondiale ricorda quella, che tra l’altro si svolse in parte negli stessi luoghi, degli altrettanti internati militari italiani detenuti nei campi tedeschi e polacchi nel corso della seconda guerra mondiale dopo il disfacimento dell’esercito seguito all’8 settembre, la cattura e la nascita della Repubblica sociale: entrambi a lungo dimenticati, guardati con diffidenza al loro ritorno, riconosciuti tardivamente come un tema centrale della storiografia sulle guerre e sulle condizioni e i comportamenti delle popolazioni nel loro contesto.
Questa specificità italiana non deve far dimenticare altre situazioni drammatiche e una condizione più generale, che costituisce un tratto caratteristico e nuovo dell’esperienza di massa nella prima guerra mondiale. In qualche fase la detenzione stessa fu per alcune categorie di prigionieri anche peggiore di quella degli Italiani. Per esempio, risulta che i prigionieri rumeni in Germania subirono il 30% di decessi. Sui prigionieri austriaci in Italia il quadro delle ricerche non è ancora del tutto completo e i tassi di mortalità rimangono incerti. Cifre ufficiali senza riscontri parlano di 41.000 prigionieri austriaci deceduti in Italia, ma la mancanza di dati analitici sulle cifre complessive della detenzione (presumibilmente 180.000 prigionieri, cui solo nei giorni finali dello sfaldamento imperiale asburgico se ne aggiunsero altri 300.000) e sulle cause di morte impediscono di avere un quadro preciso della situazione. Quel che si conosce abbastanza bene è però il caso dell’Asinara, dove furono internati circa 24.000 prigionieri austriaci che le armate serbe in rotta, traghettate in Italia alla fine del 1915, avevano trascinato con sé nella disastrosa ritirata. Sistemati in accampamenti di fortuna, questi prigionieri dei Serbi passati in mani italiane furono falcidiati da una tremenda epidemia di colera.
Per molti, la fine della guerra non segnò un miglioramento della situazione. I prigionieri tedeschi furono trattati, specialmente in Francia, come veri e propri ostaggi allo scopo di costringere il loro Paese alla firma e al rispetto dell’armistizio. A loro volta, i prigionieri russi, nel caos seguito alla rivoluzione e dopo la pace di Brest-Litovsk, rimasero del tutto abbandonati a se stessi e continuarono per molto tempo ad essere impiegati nel lavoro coatto malgrado la firma del trattato. Sorte spesso molto dura toccò ai prigionieri detenuti dai Russi, anche per il numero molto elevato (oltre due milioni), dispersi sull’immenso territorio euro-asiatico, talvolta in condizioni igieniche e sanitarie pessime che favorivano l’esplosione di epidemie. A questo bisogna aggiungere che la considerazione e il trattamento degli ex prigionieri della prima guerra mondiale furono dovunque, tanto sul piano materiale come su quello simbolico, ben diversi da quelli degli ex combattenti.
La prigionia, come e più della guerra guerreggiata, segnò una formidabile mescolanza dei popoli europei. Per esempio nei campi di concentramento austro-tedeschi convissero e impararono a collaborare, a contrattare, a barattare soprattutto prigionieri italiani, francesi, serbi, russi e tutti dovettero sottostare e impararono a conoscere gli austro-tedeschi, le loro mentalità. Milioni di uomini furono costretti all’attraversamento in condizioni di fortuna, talvolta a piedi o su mezzi trainati da animali o su treni e ancora su imbarcazioni fluviali o marittime, del territorio europeo in tutta la sua estensione: uno dei nostri diaristi, Luigi Colombini, dopo la cattura percorre ad esempio il Friuli, la Slovenia, l’Austria, la Germania fino alle regioni del Nord e poi, alla liberazione, attraversa altro territorio tedesco verso ovest, passa in Olanda, si imbarca a Rotterdam, attraversa il canale della Manica, approda in Francia, percorre in treno il tragitto verso l’Italia attraversando Lione. Molti dei prigionieri italiani detenuti nei campi dell’Austria-Ungheria, dopo il crollo e la disgregazione dell’impero, si allontanarono spontaneamente, senza nessuna guida o organizzazione, seguendo itinerari improvvisati e affrontando viaggi di ritorno in condizioni impossibili.
Per non parlare degli altri “italiani”, in realtà sudditi asburgici del Trentino, di Trieste e dell’Istria, che, finiti a combattere in Galizia e fatti prigionieri (nel numero di circa 26.000), furono portati in Russia e in Siberia. Un trentino racconta di aver percorso, nei vari spostamenti coatti, tutta la Russia europea, da Kiev a Rostow, da Rostow a Orenburg, da Orenburg ad Alexandria presso il lago Onega, da qui a Syzran sul Volga, da Syzran a Kirsanov, nel governatorato di Tambov. Un altro, arruolato come lavoratore ad Acinsk, nella Siberia centrale, nel luglio del 1915 viene trasportato con altri a Kirsanov, a quasi quattromila chilometri di distanza in direzione ovest, dove vengono concentrati i trentini convinti a tornare in Italia come sudditi della nuova patria, dopo che l’Italia è entrata in guerra contro l’Austria.
Le peregrinazioni dei prigionieri trentini sull’immenso territorio russo, tra un campo e l’altro, tra una miniera e una fattoria, avanti e indietro per la Siberia, hanno dell’incredibile. Non meno avventurose le peripezie che portano alcune migliaia di essi a intraprendere il viaggio di ritorno, prima percorrendo i circa 1.800 chilometri da Kirsanov, luogo di concentramento degli Italiani, al porto di Archangel’sk sul Mar Bianco, per compiere da lì il periplo della Scandinavia, raggiungere l’Inghilterra e finalmente puntare sulla Francia e l’Italia. Ma il più rocambolesco, o comunque il più lungo di tutti nello spazio e nel tempo, fu il percorso seguito dai contingenti che, dopo lo scoppio della rivoluzione sovietica e dopo il congelamento che rese impraticabile il porto di Archangel’sk, seguirono la linea della Transiberiana fino a Vladivostok, poi furono coinvolti in complicate vicende legate all’intervento alleato contro il nuovo potere dei bolscevichi e alla costituzione in questo ambito di un corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente. Il ritorno in Italia per molti di loro richiederà ancora molto tempo e molta pazienza.
La fame costituisce il grande tema che domina la realtà e l’immaginario dei prigionieri nella veglia e nel sonno, che fornisce materia centrale dei loro dialoghi e delle loro scritture, che determina persino le forme della grafia, in particolare per quanto riguarda l’uso delle maiuscole. Attraverso l’esperienza dei prigionieri assai più che di quella dei soldati ci inoltriamo in un’Europa affamata dalla guerra, specialmente laddove manca il sostegno di altre aree agricole del mondo (si pensi all’impero britannico e agli Stati Uniti nei confronti delle potenze dell’Intesa), e ancor più dove, in presenza di sostanziali carenze alimentari, la determinazione dei poteri costituiti è quella di privilegiare l’esercito sulla popolazione civile. È nei campi di prigionia austro-tedeschi, soprattutto per i soldati semplici, che si lambiscono e spesso si superano i confini della sopravvivenza per denutrizione, per fatica e per inedia, che saranno lo scenario tipico delle forme di detenzione concentrazionaria durante la seconda guerra mondiale prima di assumere il volto esplicito dello sterminio. L’analogia concerne anche le forme di immatricolazione numerica dei detenuti, le vessazioni gratuite, le marce forzate, l’esposizione alle intemperie, la violenza del linguaggio, gli attentati alla dignità personale, le umiliazioni corporee.
Il diario della fame di Luigi Colombini
Abbiamo lasciato il milanese Luigi Colombini al momento in cui, pochi giorni dopo la cattura seguita alla rotta di Caporetto, stila il suo primo rapporto sulla fame, atto di accusa contro le infamie che la crudeltà del nemico e soprattutto l’insensatezza della guerra infliggono agli uomini comuni come lui. E abbiamo già segnalato l’eccezionalità del documento costituito dal suo diario. Occorre insistere su questo punto, esaminandolo in tutta la sua estensione. Senza considerare le poche pagine iniziali e finali del taccuino, bianche ovvero riservate a scritture occasionali o strumentali come conti, elenchi di spese fatte, e a un componimento in versi datato 7 gennaio 1919, vigilia dell’annunciata partenza per il ritorno in patria cui è dedicato, si tratta di 89 pagine interamente scritte, con una cadenza giornaliera rigorosamente ininterrotta, senza una sola eccezione e pressoché senza un’andata a capo. A parte il periodo al fronte tra l’agosto e l’ottobre del 1917, e poi il tempo della rotta e della breve ritirata conclusa con la cattura, di cui abbiamo già detto, non passa uno solo dei 419 giorni che separano la cattura stessa dalla vigilia della partenza dalla Germania per l’Italia, né degli altri 21 che trascorrono tra la partenza dalla Germania e la vigilia effettiva del rientro a casa una volta superato l’interrogatorio già in territorio italiano, che non sia scrupolosamente annotato nel diario con un numero più o meno grande di informazioni a seconda delle circostanze, delle condizioni ambientali, della rilevanza degli accadimenti, presumibilmente anche dello stato d’animo e delle condizioni di salute del nostro testimone, non di rado assai precarie: dalle poche righe sconsolate alle narrazioni abbastanza ampie di accadimenti e di giorni clamorosi, come saranno fra l’altro quelli della caduta dell’Impero e della rivoluzione in Germania, riverberatasi coi suoi tumulti e le sue novità all’interno dei campi. Il calvario della sofferenza, fatta di privazioni di ogni genere, vi è distillato in una forma che per la sua accuratezza e completezza potremmo dire da ragioniere, se non fosse venato spesso da accenti di malinconia, di disperazione e di sconforto alquanto toccanti. Il percorso della fame, del degrado corporeo, vi è registrato con una precisione quotidiana stupefacente, comprendente non solo le note, spesso forzatamente ripetitive, sul menù e le razioni di quanto si riesce a rimediare giorno per giorno, ora per ora, o viceversa di quanto viene a mancare al desiderio e al bisogno, ma lo stato più o meno ripugnante della materia data per commestibile, le reazioni del corpo provato da un simile trattamento, le manifestazioni sensoriali dell’astinenza ma anche dell’improvvisa gioia fisica di fronte a qualche insperata rottura della routine alimentare coatta.
Seguiamolo dunque nel suo itinerario, a partire dall’inizio del tormentoso viaggio che lo porta oltre il confine italo-austriaco, insieme ad altre centinaia di prigionieri italiani, una volta che le marce forzate hanno finalmente lasciato il campo al vagone ferroviario, come segnalato alla data del 9 novembre. “9/11 notte si sdraia nel vagone ma siamo in troppi si stà male ed è causa di continui litigi tra di noi”, leggiamo sul taccuino come prima annotazione dopo l’interruzione già segnalata. E il giorno dopo: “sempre nel vagone si attraversa monti e Paesi coperti di Neve. Continua a nevicare il treno e [è] più il tempo che si ferma nelle stazioni che quello che va Ce [c’è] un gran Puzzo causa che sono costretti a fare i suoi bisogni nel vagone Il treno sale a grande altura e trova molta neve alle 5 ci danno una fettina di Pane e Carne e una tazza di Brodo alla notte alle 10 ci danno una fetta di Pane e salame e una tazza di Caffè. Si dorme molto male accavallati, sempre dolori alle gambe”. L’11 novembre il convoglio passa la frontiera tra l’Austria e la Germania, il 13 “si arriva ad un gran campo di concentramento”. L’alimentazione precaria comincia a far sentire i suoi effetti, come segnala il 14 novembre: “causa questo sistema di vita mi sento poco bene e diarrea”. Dopo altri trasferimenti a piedi e in vagone ferroviario finalmente il 16 novembre arriva alla stazione di Stendal e al relativo campo, a un’ora di cammino dalla città, dove viene immatricolato col numero 5136-4 e assegnato a una baracca. Qui trascorrerà la prima parte del terribile inverno fino al 22 gennaio del 1918. Nel campo, stando a quanto ci dice più avanti incidentalmente, ci sono in tutto circa quattromila prigionieri.
Alle 5 del pomeriggio dello stesso 16 novembre “ci danno una fetta di Pane, alle 6 un mestolo di Brodo di Rape alle 6½ un mestolo di Caffe acquato alle 7 Appello e a dormire sempre in riga”. Comincia così la vita del detenuto destinata a protrarsi per oltre un anno. Si delinea un regime di alimentazione giornaliera caratterizzato da brodaglie di varia natura, minestre annacquate di barbabietole (o bucce di barbabietole) e di cavoli, un alimento anch’esso acquoso probabilmente a base di mais che il nostro chiama polentina, una sottile fetta di pane. Lo spettro della fame comincia a farsi concreto. Luigi ha la forza di fare dell’ironia per tutta l’acqua calda ingerita: “Sveglia alle 5 – scrive il 19 novembre – Appello e acqua calda, così ci tengono per macchine a vapore che vanno a base d’acqua calda”. Ma aggiunge: “se continua così non so come fare la vita dato che mi sento già molto debole tutti i momenti in riga alle 8½ ci fanno fare dei movimenti in cortile alle 10½ Puntura Alle 11 brodo di rape. La puntura fa molto male, alle [...] 5½ Minestra di foglie di barbabietole”. Il giorno dopo il suo commento è lapidario: “causa questi Pranzi non si va più nemmeno di corpo si piscia solo ma la debolezza e tanta”. Le conseguenze di denutrizione, freddo e fatiche inutili come le cosiddette istruzioni giornaliere si fanno subito sentire: “alle 9 istruzione – annota il 23 novembre – alle 11 brodo di Rape alle 3 istruzione causa la debolezza qualche compagno cadde svenuto”.
La situazione si aggrava in conseguenza della disciplina feroce. Il 30 novembre un prigioniero che tenta la fuga viene ucciso con una fucilata, dopodiché fioccano punizioni e ulteriori restrizioni a titolo intimidatorio. Il giorno dopo non viene dato quello che Luigi chiama spesso “specie di caffè” e il rancio si assottiglia ancora. Solo ora, in prigionia, l’espressione “barbaro nemico” sembra acquistare consistenza, comincia ad avere un senso preciso. Il 2 dicembre, domenica, scrive: “oggi sveglia alle 6. Niente Caffè i Barbari si fanno conoscere anche la sbroda delle 11 non ce la danno intendono di farci morire di fame, qui e una vera desolazione più di 4000 persone debbono così tanto soffrire”; e prorompe in un’esclamazione che, sia pur dettata dall’esasperazione del momento, dice molto sul rapporto tra esperienza della trincea ed esperienza dei campi di prigionia: “a [ah] come era meglio la Trincea malgrado i suoi pericoli. Giornata triste pensando ai miei cari Fuori ce una bufera di vento e neve qui in baracca fa freddo ho i piedi che non li posso scaldare”. Il freddo in effetti morde. I casi di congelamento sono numerosi. “Qui ci sono molti gelementi di piedi 15 oggi sono andati all’Ospedale”, registra il 4 dicembre.
Le restrizioni punitive durano per tutta la prima metà di dicembre, sottoponendo i detenuti a una prova estrema. La morsa del freddo è spietata: “Il freddo e terribile e nevicato io sono ½ assiderato mi manca la forza per scrivere” dice il 3 dicembre, senza in realtà interrompere le annotazioni giornaliere. E il 6: “I sottufficiali anno iniziato il regno del terrore per un nonnulla levano Il pane migliore alimento benché cattivo”. Per poco e cattivo che sia, il pane ha almeno una consistenza solida, serve a colmare sia pure per poco il senso del vuoto che invece lasciano le “solite sbrode”. Per questo diventa un luogo fisso dell’immaginario, un sogno ricorrente. “Dato il desiderio del Pane di notte lo sogno sempre” scrive il 10 dicembre; “aspettare che venga domani per avere quel tozzo di pane Nero che lo sogno anche la notte” ripeterà più avanti (5 luglio 1918). “Il vitto sempre peggio oggi a ½ giorno solo acqua calda non so come fare sta vita non mi sento la forza” (12 gennaio). La fame e il freddo sono un dolore fisico che può diventare acuto. Il 18 dicembre: “Queste maladette istruzioni sulla sabbia mi fanno gelare i piedi mi saliva i brividi al cuore avrei pianto dal dolore. Il Medico ci fa sfilare e ci guarda il petto siamo tutti scheletriti”. Arriva così il primo Natale in cattività, che alle sofferenze del corpo mescola quelle della nostalgia:
Natale sveglia alle 5 e sbroda bianca alle ore 6½ si va a Messa in una baracca alle 11 sbroda con sapore di Salmone. Nella mattina nevica più tardi fa sole giornata di bel tempo Alle 4 fetta di Pane le razion...