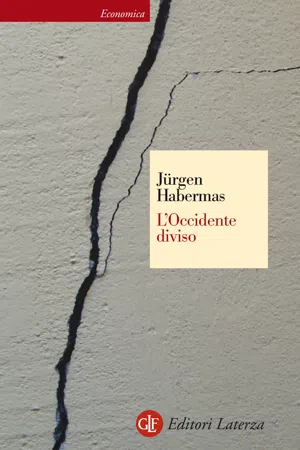
eBook - ePub
L'Occidente diviso
Jürgen Habermas, Mario Carpitella
This is a test
- 220 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
L'Occidente diviso
Jürgen Habermas, Mario Carpitella
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
L'atto di accusa del più grande pensatore politico vivente contro gli errori dell'America, l'incapacità dell'Europa, il naufragio del diritto internazionale.
Una interessante silloge di interventi del filosofo europeo contemporaneo più influente e carismatico, forse l'ultimo esponente di un pensiero forte. Corrado Ocone, "Il Mattino"
Habermas mette a fuoco il conflitto all'interno del mondo occidentale all'indomani della guerra in Iraq e pone interrogativi drammatici sul futuro dell'umanità che non possiamo non fare nostri. Vittorio Bonanni, "Liberazione"
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is L'Occidente diviso an online PDF/ePUB?
Yes, you can access L'Occidente diviso by Jürgen Habermas, Mario Carpitella in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economia & Politica economica. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
EconomiaSubtopic
Politica economica1.
Che cosa significa il crollo
del monumento?*
* Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 17 aprile 2003 (p. 33).
Il mondo intero ha seguito quella scena del 9 aprile 2003 a Baghdad, ha visto i soldati americani porre il cappio al collo del dittatore e, con azione fortemente simbolica, rovesciarlo dal suo piedistallo tra il giubilo della folla. Il monumento, all’apparenza incrollabile, dapprima vacilla, poi cade. Ma prima del crollo liberatorio, la forza di gravità deve superare quella posizione orizzontale grottescamente innaturale in cui la massiccia figura si mantiene, oscillando lievemente, ancora per un terrorizzante secondo. Come in un rebus «scatta» una percezione diversa dei disegni, così in questa scena si inverte la percezione della guerra da parte del pubblico. In questa giornata nel quartiere sciita di Baghdad la diffusione moralmente oscena dello shock e del terrore tra una popolazione spietatamente bombardata, estenuata e indifesa si trasforma nella liberazione dal terrore e dall’oppressione, salutata entusiasticamente dai cittadini. Queste percezioni contengono entrambe un momento di verità, anche se evocano sentimenti morali e prese di posizione contrastanti. Tale ambivalenza di sentimenti deve necessariamente portare a giudizi contraddittori?
A prima vista, la questione è semplice. Una guerra illegale rimane una violazione del diritto internazionale, anche se porta a successi normativamente desiderabili. Ma è tutto qui? Conseguenze negative possono delegittimare una buona intenzione. Ma conseguenze positive non possono produrre un effetto legittimante a posteriori? Le fosse comuni, le segrete sotterranee e le testimonianze dei torturati non lasciano dubbi circa la natura criminale del regime; e la liberazione di un popolo martoriato da un regime barbarico è un bene, il bene supremo fra tutti quelli politicamente desiderabili. In questo senso anche gli iracheni, che esultino o saccheggino, che rimangano apatici o che dimostrino contro gli occupanti, pronunciano un giudizio circa la natura morale della guerra. Da noi si profilano due reazioni nell’opinione pubblica politica.
I pragmatisti credono nella virtù normativa del fattuale e si affidano a un giudizio di tipo pratico, che valuta i frutti della vittoria tenendo presenti i limiti politici della morale. A loro parere la discussione sulla legittimità della guerra è sterile, perché la guerra è diventata frattanto un evento storico. Gli altri che, vuoi per opportunismo, vuoi per convinzione, capitolano di fronte alla forza del fattuale, respingono quella che ora considerano una difesa dogmatica del diritto internazionale, con la motivazione che, per puro eccesso di sensibilità di stampo post-eroico ai rischi e ai costi dell’intervento militare, essa chiude gli occhi davanti alla libertà come vero valore. Queste reazioni mancano entrambe il segno, perché cedono al risentimento contro le presunte astrazioni di un «esangue moralismo», senza aver chiara l’alternativa che i neoconservatori a Washington propongono all’addomesticamento del potere statale da parte del diritto internazionale. Costoro, infatti, alla morale del diritto internazionale non contrappongono né il realismo né il pathos della libertà, bensì una dottrina rivoluzionaria: quando il regime del diritto internazionale viene meno, l’instaurazione egemonica, più efficace politicamente, di un ordinamento liberale del mondo è giustificata a livello morale anche quando si avvale di mezzi contrari a questo diritto.
Wolfowitz non è Kissinger. Più che un cinico assertore del potere, è un rivoluzionario. Certo, la superpotenza si riserva il diritto di agire in maniera unilaterale, e all’occorrenza anche di impiegare preventivamente tutti i mezzi militari disponibili per consolidare la sua posizione egemonica nei confronti di possibili rivali. Ma per i nuovi ideologi questa ambizione al potere globale non è fine a se stessa. Ciò che distingue i neoconservatori dalla scuola dei «realisti» è la visione di un ordine mondiale dettato dalla politica americana, visione che fuoriesce dai binari riformistici della politica dei diritti umani perseguita dall’Onu. Essa non tradisce le finalità liberali, ma fa saltare i vincoli di civiltà che, per buoni motivi, la costituzione delle Nazioni Unite impone al processo di realizzazione degli obiettivi.
Indubbiamente, l’organizzazione mondiale oggi non è ancora in grado di obbligare gli Stati membri trasgressori a garantire ai loro cittadini un ordinamento democratico e costituzionale. E la politica dei diritti umani, perseguita in maniera altamente selettiva, è soggetta ancora alla riserva di possibilità. La Russia, potenza con diritto di veto, non ha da temere un intervento armato in Cecenia. L’impiego da parte di Saddam Hussein di gas nervino contro la popolazione curda del suo Paese è solo uno dei molti casi della cronaca fallimentare di una comunità di Stati che perfino nei casi di genocidio guarda dall’altra parte. Tanto più importante è quindi la funzione centrale di garanzia della pace sulla quale si fonda l’esistenza delle Nazioni Unite – ossia l’imposizione del divieto di guerre d’aggressione, che dopo la seconda guerra mondiale ha abolito lo jus ad bellum, limitando la sovranità dei singoli Stati. Con ciò il diritto internazionale classico ha compiuto almeno un passo decisivo sulla strada che porta a un assetto giuridico cosmopolitico.
Gli Stati Uniti, che per mezzo secolo hanno potuto essere considerati i battistrada in questa direzione, con la guerra in Iraq non solo hanno distrutto questa reputazione e rinunciato al ruolo di potenza garante del diritto internazionale, ma con la loro azione lesiva di tale diritto hanno offerto un micidiale precedente alle superpotenze future. Per parlar chiaro: l’autorevolezza normativa dell’America è in pezzi. Non è stata soddisfatta né l’una né l’altra condizione per l’impiego giuridicamente legittimato delle armi: non lo stato di legittima difesa contro un attacco effettivo o imminente, non l’autorizzazione da parte di una risoluzione del Consiglio di sicurezza a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Né la risoluzione numero 1441 né alcuna delle altre 17 risoluzioni sull’Iraq che l’hanno preceduta (e che sono «andate a vuoto») possono valere come autorizzazioni sufficienti. D’altronde, il gruppo di fautori della guerra lo ha confermato in pratica: in un primo momento ha puntato a una «seconda» risoluzione, ma in seguito non ha sottoposto a votazione la relativa proposta solo perché non poteva nemmeno contare su una maggioranza «morale» dei membri privi del diritto di veto. Infine, tutta la vicenda è diventata una farsa quando il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente dichiarato che all’occorrenza avrebbe agito anche senza il mandato del Consiglio di sicurezza. Alla luce della dottrina Bush, il dispiegamento delle truppe nel Golfo non ebbe fin dal principio il carattere di una semplice minaccia. Questa avrebbe presupposto l’evitabilità delle sanzioni minacciate.
Nemmeno il confronto con l’intervento in Kosovo può essere addotto a discolpa. È vero che anche in questo caso non fu possibile ottenere un’autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Ma la legittimazione raggiunta a posteriori poté fondarsi su tre circostanze: il blocco di una pulizia etnica che (per quanto allora si sapeva) era in corso; l’obbligo di pronto soccorso del diritto internazionale, che per questo caso valeva erga omnes; e il carattere indiscutibilmente democratico e costituzionale di tutti gli Stati membri della coalizione militare che agiva a nome di tutti loro. Oggi il dissenso normativo divide lo stesso Occidente.
Per la verità già allora, nell’aprile del 1999, tra le potenze dell’Europa continentale e quelle anglosassoni si manifestò una notevole divergenza circa le strategie di giustificazione. Una delle due parti trasse dal disastro di Srebrenica un insegnamento: chiudere con l’intervento armato la forbice, aperta con le operazioni precedenti, fra legittimazione ed effettività, per progredire in questo modo sulla strada di una piena istituzionalizzazione del diritto cosmopolitico; invece l’altra parte si accontentò del fine normativo di diffondere, se necessario con la forza, il proprio ordinamento liberale anche in altri Paesi. A suo tempo io ho attribuito questa divergenza alle differenti tradizioni di pensiero giuridico: da una parte il cosmopolitismo di Kant, dall’altra il nazionalismo liberale di John Stuart Mill. Ma alla luce dell’unilateralismo egemonico che i propugnatori della dottrina Bush perseguono fin dal 1991 (si confronti la documentazione di Stefan Fröhlich nella «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 10 aprile 2003) si potrebbe presumere in retrospettiva che la delegazione americana conducesse le trattative di Rambouillet già da questo originale punto di vista. Comunque sia, la decisione di George W. Bush di consultare il Consiglio di sicurezza non fu più dettata dal desiderio di una legittimazione sul piano del diritto internazionale, che a livello ufficioso era ritenuta da molto tempo superflua. Questa copertura era desiderata solo perché avrebbe allargato la base della «coalizione dei volenterosi» e dissipato le perplessità del popolo americano.
Nondimeno, noi non possiamo intendere la nuova dottrina come espressione di un cinismo normativo. Le funzioni che anche una tale politica deve svolgere, come l’acquisizione geostrategica di sfere d’influenza e risorse vitali, possono rendere inevitabile un atteggiamento critico verso tale ideologia. Ma queste interpretazioni convenzionali banalizzano quella rottura, inimmaginabile solo un anno e mezzo fa, con le norme che gli Stati Uniti si erano finora impegnati a rispettare. Noi faremo bene a non soffermarci sull’attribuzione di motivi, bensì a prendere la nuova dottrina in parola. Altrimenti non coglieremo il carattere rivoluzionario di un cambio di orientamento che si alimenta delle esperienze storiche del secolo trascorso.
Hobsbawm ha giustamente definito il secolo XX «il secolo americano». I neoconservatori possono considerarsi «vincitori» e prendere a modello di un nuovo ordine mondiale, instaurato sotto la guida degli Stati Uniti, gli innegabili successi: il nuovo assetto dell’Europa, del Sud-est asiatico e del Pacifico dopo la sconfitta della Germania e del Giappone, come pure la trasformazione delle società dell’Europa orientale e centro-orientale dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Nella prospettiva di una post-storia interpretata in senso liberalistico alla Fukuyama, questo modello ha il vantaggio di rendere superflua una circostanziata discussione sulle finalità normative. Cosa potrebbe essere meglio per l’umanità della diffusione degli Stati liberali su scala mondiale e della globalizzazione dei liberi mercati? Ed è chiara anche la strada che vi porta: la guerra e l’iper-armamento hanno messo in ginocchio la Germania, il Giappone e la Russia. L’intervento militare si prospetta oggi tanto più agevole in quanto nelle guerre asimmetriche si sa a priori il vincitore, al quale la vittoria costa perdite relativamente modeste. Le guerre che migliorano il mondo non hanno bisogno di nessun’altra giustificazione. Al prezzo di trascurabili danni collaterali, esse eliminano mali inequivocabili, che continuerebbero a sussistere sotto l’egida di una comunità di Stati priva di forza. Saddam rovesciato dal suo piedistallo è l’argomento sufficiente per la giustificazione.
Questa dottrina è stata elaborata molto tempo prima dell’attacco alle Torri Gemelle. Ma è stata soprattutto la sapiente regia della reazione psicologica di massa allo shock fin troppo comprensibile dell’11 settembre a creare il clima in cui tale dottrina ha potuto trovare ampia risonanza – anche se in una versione alquanto diversa, inasprita in «guerra al terrorismo». L’inasprimento che ha portato alla dottrina Bush è dovuto a un fenomeno sostanzialmente nuovo per i consueti concetti della belligeranza convenzionale. Nel caso del regime talebano, tra il terrorismo inafferrabile e uno «Stato canaglia» attaccabile esisteva davvero un nesso causale. Secondo questo modello si può, con la classica operazione della guerra fra Stati, togliere la terra sotto i piedi anche a quel micidiale pericolo proveniente da reti diffuse e operanti a livello globale.
Rispetto alla versione originaria, questo collegamento dell’unilateralismo egemonico con l’azione di difesa da una minaccia strisciante mette in campo l’argomento della legittima difesa. Vero è che anche questa azione di difesa ha difficoltà a provare le proprie accuse. Il governo degli Stati Uniti ha dovuto tentare di convincere il pubblico mondiale dell’esistenza di legami fra Saddam Hussein e al-Qaeda. Questa campagna di disinformazione ha avuto in ogni caso tanto successo in patria che secondo gli ultimi sondaggi il 60% degli americani saluta il cambiamento di regime in Iraq come una «espiazione» per l’azione terroristica dell’11 settembre. Ma la dottrina Bush non offre in realtà alcuna spiegazione plausibile per l’intervento militare preventivo. Il potere non-statale dei terroristi – la «guerra nella pace» – non motiva in alcun modo, per il fatto che si sottrae alla categoria della guerra fra Stati, la necessità di svisare il diritto di uno Stato alla legittima difesa, sancita rigorosamente dalle norme del diritto internazionale, nel senso di una anticipata legittima difesa bellica.
Contro i nemici globalmente ramificati, decentrati e invisibili, l’unica difesa è una prevenzione su un diverso piano operativo. Qui non servono bombe e missili, aerei e carri armati, bensì il collegamento internazionale tra servizi segreti e magistrature penali dei vari Stati, il controllo dei flussi finanziari, e in genere l’individuazione dei collegamenti logistici. I corrispondenti «programmi di sicurezza» non toccano il diritto internazionale, bensì i diritti civili garantiti dagli Stati. Altri pericoli, derivanti dal fallimento per propria colpa della politica di non-proliferazione delle armi atomiche, si possono comunque scongiurare con le trattative più che con le guerre per il disarmo – come dimostra la moderata reazione alla Corea del Nord.
Dunque rispetto al fine direttamente perseguito di un ordinamento mondiale egemonico, la dottrina inasprita in «guerra al terrorismo» non offre nessuna legittimazione in più. Saddam abbattuto dal suo piedistallo rimane l’argomento-simbolo del riassetto in senso liberale di un’intera regione. La guerra in Iraq è un anello nella catena di una politica di ordinamento mondiale che si giustifica subentrando alla inefficace politica dei diritti umani di un’organizzazione mondiale esaurita. Gli Stati Uniti si assumono per così dire quel ruolo di curatore fiduciario in cui l’Onu ha fallito. Cosa si può obiettare? I sentimenti morali possono essere fuorvianti, perché restano legati a singole scene e immagini. La questione della giustificazione della guerra nel suo complesso non può essere elusa. Il dissenso decisivo consiste nel chiedersi se si possa, se sia lecito sostituire la giustificazione nel contesto del diritto internazionale con la politica di un ordinamento mondiale unilaterale perseguita da un soggetto egemonico che se ne conferisce da solo l’autorizzazione.
Le obiezioni empiriche alla realizzabilità della visione americana si riducono in ultima analisi al fatto che la società mondiale è diventata troppo complessa per essere ancora guidata da un centro con gli strumenti di una politica fondata sul potere militare. Nella paura della superpotenza tecnologicamente iper-armata di fronte al terrorismo sembra condensarsi la paura cartesiana di un soggetto che tenta di trasformare se stesso e il mondo circostante in oggetto per ridurre il tutto sotto controllo. Se la politica regredisce all’originaria forma hobbesiana di un sistema di sicurezza gerarchizzato, rimane indietro tanto rispetto ai media del mercato, tutti collegati in senso trasversale, quanto rispetto alla comunicazione culturale e sociale. Uno Stato che riferisce tutte le opzioni alla balorda alternativa fra guerra e pace urta ben presto contro le limitazioni delle proprie risorse e capacità organizzative. E indirizza altresì l’intesa con potenze concorrenti e con culture straniere in canali sbagliati, aumentando a dismisura i costi del coordinamento.
Anche nel caso che l’unilateralismo egemonico fosse praticabile, avrebbe tuttavia conseguenze secondarie che sono normativament...