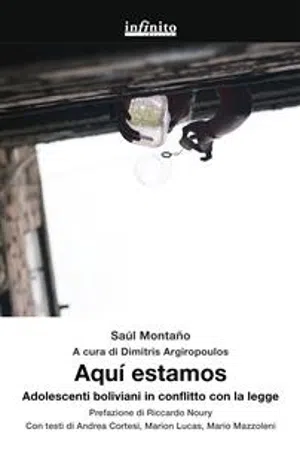di Dimitris Argiropoulos
(docente di Pedagogia)
Considerare, riflettere e analizzare il paradosso che si crea in ogni situazione di limitazione della libertà individuale e in particolare nelle situazioni di detenzione e le conseguenti definizioni e organizzazioni nel contenimento restrittivo del tempo e dello spazio, attraverso proposte educative che rivisitano pensiero, storia e prospettive della persona detenuta, diventa uno dei compiti fondamentali dell’educatore sociale e lo investe pienamente. È il paradosso dell’educazione e dell’educazione alla libertà mentre questa è limitata, ristretta e/o annullata. Tenerlo presente, affrontarlo, orienta l’azione educativa ad addentrarsi nell’impossibile, generando conoscenza sulle situazioni vissute, stimolando la scoperta del sé e indirizzando la persona detenuta in un modo meno vincolante.
L’attenzione educativa è rivolta alle dinamiche che determinano una trasformazione anche parziale della persona in stato di detenzione, del suo modo di essere, di fare e capire e di comprendere sia la strutturazione della vita detentiva sia il suo possibile superamento nonostante le dinamiche che avvengono all’interno dell’Istituto di detenzione. L’attenzione educativa identifica e valorizza ciò che è un fattore fondamentale dello sviluppo sociale della persona in detenzione ed è indispensabile in caso di minorenni. Le buone relazioni, le attività scolastiche, il lavoro e le auto-narrazioni sulla percezione emotiva e psicologica del proprio vissuto e di come la comunità possa attuare un processo di inclusione, sono i mezzi che influenzano un processo positivo, educativo e di riappropriazione del sé.
Cosa è un’istituzione penale totale
In ogni situazione di detenzione, la persona e ogni parte del suo sé viene spogliata, deprivata e riorganizzata secondo i dettami e le regole del sistema penitenziario in cui inizia a espiare le proprie colpe. Il danno sociale provocato è necessariamente da colmare attraverso il confinamento ai margini, la reclusione e la non considerazione di ogni elemento soggettivante. Erving Goffman definì ogni tipo di struttura che isola gli esseri umani in istituzioni totalizzanti, e tali strutture non sono solo di tipo penitenziario, ma anche scuole, ospedali, istituti per anziani, orfanotrofi, su di loro influiscono sia il potere che impone l’istituzione, sia quello che emerge tra gli uomini . Per Goffman, le istituzioni totali sono “luoghi di residenza e di lavoro di gruppi di persone che condividono una situazione comune e trascorrono parte della loro vita in un regime chiuso, la cui caratteristica totalizzante si esprime con l’impedimento allo scambio sociale e ai rapporti con il mondo esterno” .
In queste condizioni, ogni aspetto della vita dei soggetti è svolto nei medesimi tempi e nei medesimi luoghi, sorvegliati dalle autorità che vi operano. Ogni persona perde di soggettività, le azioni e i ritmi avvengono con l’intento assoluto del rispetto delle regole imposte e si è obbligati a fare le stesse cose, organizzate secondo il più rigido schema di esecuzione, come se ogni giorno andasse in scena la stessa recita, con gli stessi attori e gli stessi movimenti, ripetuta in modo ossessivo. Un luogo di una certa violenza, in cui le variabili sono infinite ma creano una quotidianità immutata che si perpetua per tutta la durata della pena .
Approcciarsi significativamente, è chiedersi, in ogni società, a cosa serva l’istituzione detentiva. Non è, questa, una banale e ingenua domanda anche se la si considera scontata, in quanto l’istituzione offre come uniche risposte adeguate al complesso sistema di problemi, criteri di verità, giustizia, devianza e criminalità assai accettati socialmente e spesso non oggetto di riflessione critica. Si finisce così per agire secondo automatismi, preconcetti e meccanismi d’azione. Far emergere le discromie che appiattiscono tale panorama, sarebbe forse l’unico modo per poter promuovere una maggiore razionalità dell’istituzione stessa .
Il principio retributivo prevede che venga colmato il danno provocato dal soggetto, con sanzione commisurata alla gravità; la sua caratteristica principale è quella di essere preventivamente determinata, afflittiva, che renda legittimità alle norme violate. Il soggetto di riferimento si considera razionale, in grado quindi di valutare il senso delle sue scelte, e calcolare il rapporto danni-benefici che derivano dal proprio comportamento. Se si segue tale prospettiva, il carcere funge da deterrente, sia punendo il singolo, sia prevenendo atti criminali all’interno della collettività stessa. Avviene quindi un duplice effetto: le pene certe e proporzionali, la difesa sociale assicurata dalla deterrenza .
Nello schema positivistico, viene interpretato il comportamento criminale come reazioni a fattori ambientali e sociali esterni al soggetto, piuttosto che come un risultato metodico tra vantaggi e svantaggi dell’azione attuata nel reato. Questo modello è stato oggetto di riferimento dei movimenti giovanili e dei cambiamenti sociali degli Anni ‘70 (riscontrabile nel contesto italiano ed europeo fino all’inizio degli Anni ‘90), che stava aprendo le porte di quel che consideriamo il carcere moderno, una coniugazione non solo dei fattori biologici ereditati, ma che propone al carcere una funzione rieducativa . In un contesto primariamente punitivo, si impiegano forme di reazione al crimine ispirate all’idea di trattamento, di premialità e di altre forme alternative all’esecuzione della pena, che viene sostituito da un modello posteriore, un “ processo di burocratizzazione, caratterizzato da una maggiore articolazione amministrativa nell’ambito della quale la qualità dei rapporti tra operatori è sempre più mediata dalla struttura gerarchica” . Burocratizzare porta a numerosi rischi e timori delle responsabilità che ne conseguono; questo genera il pensiero che l’unico modo per prevenire il rischio sia quello di saldare il detenuto all’interno di un ambiente stretto e confinato .
Diritti strutturali e concetto di trattamento
Il recluso ha diritto a uno spazio vitale minimo e devono essergli garantite le minime condizioni sanitarie e di igiene, per quanto riguarda la superficie, l’illuminazione, l’aerazione, accessibilità adeguata a bagno e docce. Il rispetto di tali caratteristiche viene indicato nelle Regole internazionali, a partire da quelle dell’Onu del 1955 per proseguire con le Raccomandazioni europee . In Italia vengono recepite tali indicazioni nel 1988, inserendo indicazioni precise sulle capienze, che vengono suddivise in ottimali, tollerabili e non regolamentari .
Gli standard fissati dal Comitato per la prevenzione della tortura, avverte che i detenuti non possano languire chiusi nelle loro celle. Si prescrive quindi che sia “possibile trascorrere una parte ragionevole del giorno, fissata in otto ore o più, all’esterno delle loro celle, occupati in attività significative di varia natura, mentre per i condannati, il regime dovrebbe essere ancor più favorevole” .
Si ritiene necessario anche considerare altri diritti, che tutelino la dignità umana a partire dalla salute e dalla cura della persona. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel 1948, la intende come uno stato di completo benessere, mentale e sociale, non limitandosi quindi al concetto di sola esclusione dalla malattia. “Se la salute non è assenza di malattia, il diritto alla salute è qualcosa di più e di diverso rispetto al solo diritto di cura. È un diritto che più di ogni altro è al confine tra i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali” . Il diritto alla salute sarebbe quindi di per sé sufficiente a muovere l’organizzazione della vita detentiva in modo dignitoso e legale .
Un altro diritto, costituzionalmente sancito, è il richiamo al valore del perseguimento del libero sviluppo della propria personalità. Il diritto al trattamento si concretizza “con l’offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti e che, quindi, l’umanizzazione e la restituzione di una dignità effettiva è proporzionale alla quantità e alla qualità dell’offerta trattamentale” .
L’amministrazione, in tal senso, deve necessariamente orientare i propri sforzi con l’obiettivo di ridurre le differenze tra la vita libera e quella detentiva, quando tali differenze potrebbero indebolire il senso di responsabilità del detenuto e il rispetto della sua dignità . È importante chiarire che si va in carcere perché si è puniti e non per essere ulteriormente puniti e che, nella privazione della libertà, non dovrebbe esservi motivo per afflizioni aggiuntive .
Considerando la concretezza delle azioni da introdurre, la Raccomandazione Europea R (873), regola 66, sintetizza che ogni sforzo debba essere fatto, e ogni risorsa debba essere impiegata, affinché siano previsti assistenza spirituale, la possibilità di lavorare e di fruire di un orientamento e di un addestramento professionale, di studiare, di praticare attività fisica, d’essere occupati in attività socializzanti e ricreative. Si richiama anche alla necessità di provvedere a sistemi di comunicazione e stili gestionali, che favoriscano lo stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, ritenendole parti essenziali per rendere efficace l’offerta trattamentale .
Progetto pedagogico e patto trattamentale
Si problematizza il termine rieducazione, che andrebbe rivisto e associato al termine risocializzazione, in quanto sarebbe più coerente con l’azione svolta nelle carceri, orientata al reinserimento del detenuto in società .
“Secondo il magistrato (Margara), il carcere e il processo di rieducazione non mirano a cambiare l’uomo, quanto a fornirgli quelle possibilità che gli sono venute a mancare e che lo hanno portato a operare delle scelte. Tuttavia, la questione rimane insoluta: non si può educare attraverso la segregazione all’obbedienza dei precetti” .
Il ministero della Giustizia italiano ha ridefinito l’organizzazione dell’area educativa, con la circolare del 9 ottobre 2003 n. 3593/6043, facendo riferimento a tre livelli: le modalità di pianificazione della direzione dell’istituto, il modo in cui l’area educativa gestisce e coordina le attività e il livello operativo del trattamento individualizzato. La circolare prevede che siano i direttori a occuparsi del progetto pedagogico d’istituto, contenente le indicazioni sulle risorse dell’istituto e della comunità esterna, con particolare riferimento al lavoro, ai corsi di istruzione, alle attività culturali, sportive, ricreative e ai contatti con la famiglia.
Il “patto trattamentale” permette al detenuto di aderire a tutte le iniziative proposte dall’istituto nell’ambito del progetto pedagogico. La circolare pone l’attenzione non solo al colloquio come strumento per acquisire elementi valutativi, ma precisando e valutando “l’osservazione partecipata”, per estendere e cogliere l’attenzione anche ad altre occasioni di vita quotidiana, come ad esempio i colloqui con i familiari o le dinamiche di incontro di gruppo con altri detenuti .
Dignità e diritto allo sviluppo della propria personalità e alle relazioni umane
Il diritto al trattamento, che i detenuti possiedono, si concretizza nell’offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, professionali e culturali; la restituzione di una dignità va quindi di pari passo con le proposte trattamentali. La dignità individuale è la somma di dignità innata e dignità acquisita. La dignità innata, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’essere umano, rientra nell’articolo 2 della nostra Costituzione, laddove l’articolo successivo sancisce la pari dignità sociale tra tutti i cittadini, senza distinzione né di condizione personale né sociale . La dignità acquisita può essere invece descritta come il risultato delle azioni dell’individuo e può essere conquistata, perduta e successivamente riconquistata .
Le Raccomandazioni europee del 1987 , ulteriormente sviluppate nel 2006 , chiariscono che gli Istituti penitenziari devono avere cura di rendere chiaro l’obiettivo del sistema penitenziario al personale dipendente, gestito in un contes...