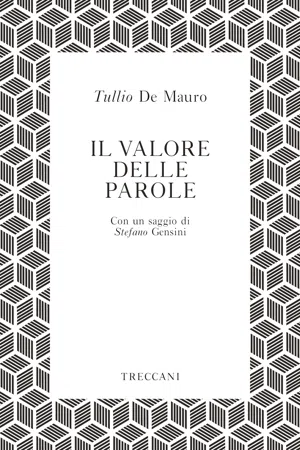![]()
LA SEMANTICA “INTEGRATA” DI TULLIO DE MAURO*
Il saggio che qui si ripresenta in forma di libro fu scritto da Tullio De Mauro nel 1979-1980 e venne pubblicato nel 1982 in uno dei volumi della “Enciclopedia del Novecento” dell’Istituto della Enciclopedia Italiana: un’opera di grandi ambizioni, in tredici volumi, fatta di ampie voci redatte dal meglio della cultura italiana e mondiale del tempo. Basti pensare che l’area delle scienze del linguaggio era rappresentata, oltre che da De Mauro, dal grande semiologo argentino Luis Prieto, allora a Ginevra sulla cattedra che era stata di Ferdinand de Saussure (sue le voci Lingua e Semiologia), dal linguista francese André Martinet (Linguistica), dall’italiano Giulio C. Lepschy, al tempo professore presso l’università inglese di Reading (Strutturalismo). E, pescando quasi a caso nell’ambito umanistico, incontriamo ancora i nomi di Claude Lévi-Strauss (Antropologia), Giulio Carlo Argan (Arte), René Wellek (Critica letteraria), e tanti altri, scelti al fine di offrire un aggiornato stato dell’arte dei rispettivi saperi, nel momento in cui il «secolo breve» si avviava alla sua fase finale.
La voce Semantica alla quale De Mauro aveva intensamente lavorato per un biennio si presentava dunque come una riflessione a tutto tondo sullo stato di una disciplina complessa e articolata al suo interno in problematiche che dalla linguistica – terreno originario in cui il termine si era affermato, fin dalla fine del XIX secolo, col pionieristico Essai de sémantique (1897) di Michel Bréal1 – si erano estese alla filosofia, alla logica, alla psicologia, fino a toccare in anni recenti il terreno della biologia e delle intelligenze artificiali. Non era certo un caso che la direzione dell’“Enciclopedia del Novecento” avesse individuato in De Mauro l’autore in grado di cimentarsi con una prova del genere: non solo questi era (e lo vedremo meglio più avanti) lo studioso che in Italia, fin dagli esordi della sua carriera scientifica, aveva fatto della semantica l’oggetto privilegiato di un’attività scientifica straordinariamente intensa; ma era anche il linguista che più di tutti sembrava potersi muovere lungo il difficile crinale che da un tema apparentemente specifico dell’analisi delle lingue riconduceva al grappolo di saperi che abbiamo menzionato, in cerca di una integrazione della tradizionale ottica umanistica con quella delle scienze dure e delle scienze applicate.
De Mauro era dal 1974-1975 professore di filosofia del linguaggio alla Sapienza (dapprima era stato ordinario di linguistica generale a Palermo e a Salerno), ma la sua singolarissima capacità di dialogo con competenze e studiosi di svariata estrazione scientifica lo aveva collocato al centro di una linguistica proiettata in senso interdisciplinare, nella quale riflessione teorica, gusto per l’analisi dei dati empirici e disponibilità alla contaminazione con altri settori di ricerca (la logica, la matematica, la biologia e la neurobiologia) facevano tutt’uno.
Il lettore tenga dunque presente che, malgrado questa Semantica esca a distanza di trentasette anni dalla sua prima edizione, essa (insieme al volumetto Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, uscito presso Laterza nello stesso anno, che ne costituisce una versione ampliata) non va letta solo come un documento storico di una fase importante, ma ormai lontana, della ricerca di settore. Semantica era per un verso un bilancio ricco ed equilibrato di quel che la semantica era stata dai suoi esordi, in Europa e altrove, soprattutto a opera dei linguisti e, in misura appena minore, dei logici; anche era però, e per molti aspetti rimane, un saggio fondativo, inteso a delineare un quadro teorico e perfino terminologico per lo studio del significato, nell’ipotesi che questo si sarebbe sempre più allargato a saperi e professionalità diverse. Se dunque sarà necessario, concludendo la nostra rassegna, indicare alcuni dei temi e dei campi di ricerca che, se non altro per motivi cronologici, restano marginali o addirittura esterni alla prospettiva di De Mauro, altrettanto importante è, per il lettore di oggi, tenere saldo il filo conduttore della sua argomentazione che, come si vedrà, riporta ai problemi centrali, tuttora in buona parte aperti, della disciplina: la definizione dell’oggetto stesso della ricerca – il significato –, posto al crocevia fra dimensione linguistica e attività mentale, la collocazione che esso assume a seconda della prospettiva ermeneutica adottata, lo statuto medesimo di un sapere, quale la semantica, caratterizzata da una natura in certo modo aporetica, consistente nel suo aspirare a “catturare”, in quanto metalingua, un oggetto non interamente calcolabile, cioè “indeterminato”, necessariamente aperto a fluttuazioni nello spazio e nel tempo quali non si verificano in altre manifestazioni del linguaggio.
PAGLIARO E LA SEMANTICA
In un certo senso, la carriera scientifica di De Mauro era nata nel segno della semantica. Il suo professore, il glottologo Antonino Pagliaro (1898-1973), figura di primo piano della linguistica italiana del dopoguerra, aveva elaborato una teoria del significato linguistico come complesso di valori “saputi” (cioè “generici”, astratti, non meramente individuali o psicologici), sedimentati nella forma di simboli condivisi, funzionalmente operanti in uno spazio e un tempo determinati. Il significato, detto altrimenti, visto come l’obiettivarsi della coscienza umana mediante la “tecnica” del linguaggio, in un corpo a corpo fra valori semantici e risorse significanti che giunge a cristallizzarsi in forme storiche concrete, in parole e testi. Muovendosi con grande personalità sulle orme di classici come Aristotele, Giambattista Vico, Wilhelm von Humboldt, fin dagli anni Trenta Pagliaro aveva messo in circolazione nel nostro paese una concezione della linguistica profondamente diversa da quella tradizionale, positivistica e naturalistica.2 Nel suo profilo scientifico, la consueta strumentazione del glottologo (una perfetta conoscenza delle lingue classiche, l’esperienza filologica, l’attenzione al dato empirico, fonico-acustico, morfologico o lessicale) si combinava con una genuina sensibilità filosofica (che lo aveva portato già giovanissimo a distaccarsi da Benedetto Croce) e con una raffinata capacità ermeneutica che aveva trovato nella critica semantica il terreno su cui dispiegarsi. Saggi di critica semantica si intitolava infatti, programmaticamente, la raccolta di lavori che nel 1952 Pagliaro aveva pubblicato, delineando una linguistica che indagava il concreto caso di studio (fosse questo un termine omerico, un verso di Virgilio – «sunt lacrimae rerum» –, un dettaglio morfosintattico del Cantico di Frate Sole o altro ancora) risalendo al significato storicamente, filologicamente accertabile del dato linguistico, e insieme enucleando il valore specifico che questo assumeva nel contesto in esame. Una vera e propria “linguistica della parole”, così De Mauro soleva presentare questa parte del lavoro di Pagliaro: una linguistica che, cioè, riusciva a mettere in relazione, cogliendone la dialettica, i valori funzionali del sistema linguistico (quelli che con Saussure chiamiamo convenzionalmente langue) e gli scarti individuali dell’uso (la parole, appunto), in questo caso condensati in testi di assoluta rilevanza storica e letteraria. Ai Saggi, sia detto per completezza, avevano poi fatto seguito un volume di Nuovi saggi di critica semantica (1956), che raccoglieva scritti composti nell’arco del precedente decennio e infine Altri saggi di critica semantica (1961), contenenti fra l’altro un saggio sul pensiero linguistico vichiano che ha fatto letteralmente epoca.3
De Mauro aveva dunque alle spalle una formazione come linguista vissuta all’ombra del maggior specialista di semantica, in Italia e probabilmente anche in Europa; inoltre, diversamente dalla stragrande maggioranza degli studiosi della sua generazione, aveva fin da giovanissimo coltivato, accanto agli studi glottologici, interessi di prima mano in campo filosofico: stimolati anch’essi, certamente, dal Pagliaro (che fin dal giovanile Sommario di linguistica arioeuropea, del 1930,4 aveva mostrato una straordinaria dimestichezza con gli autori e i testi classici della filosofia), ma sviluppati per così dire “in proprio”, come mostrano le primissime pubblicazioni su Croce i dibattiti filosofico-linguistici del Novecento5 e le letture e riflessioni condotte in vista dell’insegnamento di filosofia del linguaggio, assunto per incarico nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a partire dal 1961. Troviamo qui dunque De Mauro alle prese, anche didatticamente, con il Cours de linguistique générale (1916) di Ferdinand de Saussure (1857-1913) e soprattutto con il grande filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951), affrontato non solo per il Tractatus logico-philosophicus del 1921 (che di tanta notorietà aveva goduto fin dagli anni Venti) ma anche e soprattutto per quelle Philosophische Untersuchungen (edite postume nel 1953), che stavano appena cominciando a emanare, in giro per l’Europa, il loro particolarissimo fascino.
Saussure e Wittgenstein: due autori-chiave per la storia della semantica, che non a caso formano l’asse del quinquennio (1963-1967) nel quale De Mauro si afferma sulla scena nazionale con tre opere di enorme importanza. Anzitutto la Storia linguistica dell’Italia unita (1963), un libro (sul quale qui però non ci soffermeremo) che ha radicalmente rinnovato gli studi di storia dell’italiano, di fatto inaugurando la nostra sociolinguistica; e di seguito Introduzione alla semantica (1965) e l’edizione commentata del Corso di linguistica generale (1967) che, assieme ai lavori degli svizzeri Robert Godel e Rudolf Engler, ha contribuito a restaurare filologicamente e teoricamente il pensiero saussuriano, fino ad allora imbozzolato in una vera e propria vulgata semplificante e sproblematizzante.6
UNA LUNGA TRADIZIONE TEORICA
L’Introduzione alla semantica fu chiamata così per scelta editoriale di Vito Laterza: erano tempi in cui si andava in cerca di strumenti agili di informazione su campi del sapere ancora poco o nulla noti al pubblico, anche a quello colto. Di fatto si trattava invece di una storia dell’idea di significato da Aristotele al Novecento, ricchissima di riferimenti filosofici, da Descartes a Kant, da Leibniz a Vico, nella quale, seguendo e sviluppando le suggestioni di Saussure e del secondo Wittgenstein, viene proposto un rovesciamento della tradizionale concezione “referenzialista” del significato. Quest’ultima, imperniata su un celebre passo del Perì Hermeneías di Aristotele, e cristallizzata dalla tradizione interpretativa facente capo a Boezio,7 ancorava il significato linguistico alla realtà esterna, concepita ora come sommatoria di oggetti atomici, ora, più raffinatamente, come “stati di cose” extralinguistici, dunque negando o sottovalutando l’autonomia della dimensione interna, specificamente linguistica, del significato.
Un celebre e influentissimo libro pubblicato nel 1923, The Meaning of Meaning di Charles Kay Ogden (1889-1957) e Ivor Armstrong Richards (1893-1979),8 aveva dato una forma moderna a questa impostazione, con la teoria (e l’immagine) del cosiddetto “triangolo semiotico”: i simboli linguistici, l’equivalente – per intenderci – dei “significanti” saussuriani, designerebbero dunque oggetti o fatti extralinguistici (i referenti) mediante un’operazione mentale definita “riferimento”. Malgrado il libro cerchi di fare spazio anche ad altre componenti della pratica significativa umana, giustapponendo alla funzione cognitiva di questa la funzione “emotiva” assolta da certe risorse linguistiche, o invocando – soprattutto grazie a una famosa postfazione dell’antropologo Bronisław Malinowski – l’importanza del contesto situazionale, il nocciolo della teoria semantica (fortemente influenzata dall’atomismo logico di Bertrand Russell)9 restava solidamente referenzialista. E come tale aveva trovato ascolto in un contesto storico-culturale nel quale, grazie all’attività del Circolo di Vienna, il rapporto linguaggio-realtà si imponeva come questione cruciale, in quanto articolazione necessaria della possibilità di costruire un linguaggio scientifico, protocollare, dei cui enunciati si potessero dire con certezza, secondo parametri espliciti, le condizioni di verità/falsità. Ma quella che era una necessità fisiologica nell’uso scientifico del linguaggio (ed era a ciò – occorre ripetere – che si rivolgevano gli interessi dell’empirismo logico, non a caso imperniati sulla prima forma del pensiero wittgensteiniano, quella del Tractatus), diveniva forzatura o equivoco una volta che si pretendesse di sottoporre la totalità del linguaggio ordinario all’ipoteca del referenzialismo. Si apriva così una dualità fra l’approccio logico-filosofico al linguaggio (ispirato a Gottlob Frege, a Russell e da ultimo agli scritti semantici di Rudolf Carnap) e quello schiettamente linguistico, che per ovvi motivi ha a che fare con condizioni di uso (per dirla col Wittgenstein delle Ricerche filosofiche) “scabre”, contingenti, disseminate in “giochi linguistici” (Sprachspiele) diversissimi.
Introduzione alla semantica cercava dunque di delineare una teoria del significato linguistico misurata non sull’uso tecnico delle parole, ma sui vari e cangianti usi quotidiani dello stesso, che, per funzionare, hanno evidentemente bisogno di incanalarsi in classi di sensi, insieme comprensive ed elastiche, tali da una parte da ospitare le continue flut...