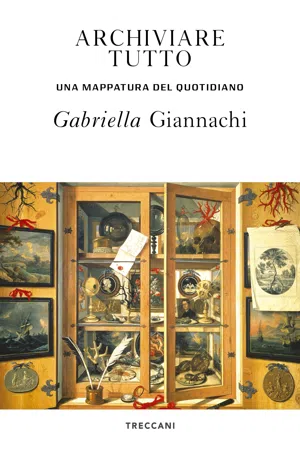![]()
1
BREVE STORIA DELL’ARCHIVIO
[Non c’è] nessun potere politico senza controllo dell’archivio, se non della memoria. La democratizzazione effettiva si misura sempre con questo criterio essenziale: la partecipazione e l’accesso all’archivio, alla sua costituzione e alla sua interpretazione.
Derrida (2005a, p. 14, nota 1)
Secondo alcuni studiosi, le origini del grande entusiasmo nei confronti dell’archivistica che ha caratterizzato la fine del XIX e l’inizio del XX secolo andrebbero individuate nell’Inghilterra vittoriana, in cui l’imperialismo generò una smania di conoscenza e di accumulo di nozioni mirata a sincronizzare e a unificare il flusso di informazioni a livello globale. Allora le pratiche di scrittura venivano paragonate alla cartografia, alla colonizzazione e all’archivistica, fatto che ha portato alla creazione di musei, Stati nazionali e grandi archivi nazionali (Richards, 1993). Secondo altri, tale entusiasmo compare invece in epoca illuminista, come parte della nascente «economia scritturale» (de Certeau, 2010). Esistono paralleli interessanti tra queste specifiche epoche storiche e il XX e XXI secolo, e si sono palesati, tra gli altri fenomeni, in una rinnovata fascinazione nei confronti degli archivi, sebbene oggi si parli solitamente di archivi digitali.
Questo capitolo adotta, nell’introdurre diverse pratiche e metodologie archivistiche nate in epoche ancora più remote, la suddivisione teorizzata da Michael Shanks – archivi 1.0, 2.0 e 3.0 – per mostrare le modalità di evoluzione storica degli archivi. Shanks (2008) spiega che l’archivio 1.0 rivela «la burocrazia nella sua forma primitiva – archivi di templi e palazzi del potere – e l’iscrizione come strumento gestionale»; l’archivio 2.0 indica una fase di «meccanizzazione e digitalizzazione dei database archivistici orientate a un accesso rapido, semplificato e aperto […] e associate inoltre a un’analisi statistica dei dati in essi contenuti» (ibidem); l’archivio 3.0, invece, si compone di «nuove architetture protesiche per la produzione e la condivisione di risorse archivistiche: l’archivio animato» (ibidem).
Il capitolo offre numerosi esempi di archivio per ognuno dei periodi storici presi in esame, ed è costruito sul modello di Shanks, cui vengono provvisoriamente aggiunte le categorie di archivio 0.0 e 4.0. Quest’ultima, in particolare, è pensata per mostrare come gli archivi svolgano ormai una funzione pervasiva all’interno dell’economia digitale.
Inoltre, nelle prossime pagine illustrerò come la popolarità degli archivi preceda di gran lunga la smania archivistica tipica della fase che va dalla fine del XX all’inizio del XXI secolo, evidenziando però come la nascita di ciò che è stato descritto come «pulsione archivistica» (Foster, 2004) o «mal d’archivio» (Derrida, 2005a) sia in effetti un disturbo, nel senso postmoderno del termine (Lyotard, 1985), che è sintomatico della nostra ossessione per l’“aumento”, la documentazione e la trasmissione della nostra presenza.
Archivi 0.0 e 1.0
Sia l’antica Grecia sia l’impero romano possedevano magazzini di archiviazione, sebbene se ne sappia molto poco, perché sono andati distrutti nel corso delle invasioni del V, VI e VII secolo (Duchein, 1992, p. 15). A dire il vero, anche prima di allora esistevano archivi creati, tra gli altri, da egizi, assiri, medi, ebrei e fenici, sebbene pure la maggior parte di questi siano andati perduti nel tempo, probabilmente a causa della deperibilità dei materiali organici (papiro o carta) su cui erano registrati. Gli archivi medievali, d’altro canto, di solito creati e gestiti da enti religiosi, famiglie reali o capi politici e cittadini, sono sopravvissuti e sono rimasti spesso intatti fino ai giorni nostri.
Ovviamente esistono eccezioni anche celebri, come l’editto di Alessandro Magno per Priene, che consiste in una serie di iscrizioni ed è stato definito un «archivio di testi connessi» (Sherwin-White, 1985, p. 69). Ciò che distingue questo caso specifico, così come altri archivi del periodo ellenistico, è che una comunità aveva scelto tali iscrizioni per rendere pubblica una specifica versione degli eventi, suggerendo che la storia di un archivio di tal genere avesse fatto parte, in qualche modo – anche se in una forma in nuce – della storia della comunità cittadina (ivi, p. 74). Questi primi archivi, definiti da Shanks (2008) “archivi 1.0”, non si limitano a illustrare, come suggerisce lui stesso, la burocrazia delle prime forme di Stato, ma rivelano altresì informazioni riguardanti le transazioni tra singoli commercianti (Veenhof, in Faraguna, 2013, pp. 27-63) e spesso immortalano momenti salienti di storie famigliari, alcune delle quali relative alle donne (Jacquert, in Faraguna, 2013, pp. 63-87). Verosimilmente, una forma di pre-archivio (Fissore, 1994, p. 344) – che potremmo appunto chiamare “archivio 0.0” – che si configura tendenzialmente come locale, concentrandosi sul racconto (o, in senso più ampio, sull’intera storia) di un certo individuo o di una comunità. Il dato curioso è che oggi risulta spesso difficile interpretare il significato delle varie componenti di questi archivi. Pertanto, quando si indaga su quelli più antichi, non è sempre chiaro agli archeologi se abbiano sotto gli occhi un archivio o semplicemente rimasugli di qualche materiale di scarto. L’archivista di Stato prussiano Ernst Posner (1972, p. 5), per esempio, racconta che quando Berard P. Grenfell, Arthur S. Hunt e J. Gilbart Smyly hanno scoperto le mummie dei coccodrilli sacri “con papiro annesso” nella città egizia di Tebtunis, hanno deciso di includere nel loro articolo una «“classificazione dei papiri basata sui coccodrilli”, in quanto i papiri contenuti nella pancia di uno stesso animale avrebbero potuto svelare relazioni indicative della loro provenienza amministrativa e della loro organizzazione originaria».
La parola “archivio” proviene dall’antica radice indoeuropea apx, ravvisabile anche nel sanscrito e in altre lingue (Leavitt, 1961, p. 175). Ad Atene, gli “arconti” erano i magistrati supremi che detenevano il potere ed erano allo stesso tempo «gli anziani» (ibidem). La forma neutra dell’aggettivo iniziò col tempo a essere utilizzata come sostantivo e assunse il significato di “residenza o ufficio del magistrato supremo”, “sede del Senato” o, nelle città più piccole, “sala dell’assemblea cittadina” (o anche “municipio”). Al plurale indicava invece i registri pubblici contenuti nella sede del Senato o nel municipio (ibidem). I romani erano soliti utilizzare la parola tabulae per indicare le tavolette, le lastre e i cartelli su cui scrivevano (ivi, p. 176), sebbene in un secondo momento cominciarono anche loro a utilizzare i termini archivium o archium, che avevano mutuato dal greco arkheion. La parola “archivio” indica allo stesso tempo sia «il luogo in cui sono conservati i documenti sia i documenti stessi» (ivi, p. 178).
Inoltre, nel concetto di archiviazione è compresa la pratica della preservazione, in quanto «solo i documenti che meritano di essere conservati» possono entrare a far parte di un archivio (ivi, p. 177). Potrebbe non sorprendere granché il fatto che già nell’Egitto romanizzato il sistema degli archivi di Stato sia divenuto sinonimo dell’amministrazione del medesimo. I cinque sostantivi che hanno iniziato a essere utilizzati regolarmente per indicare gli archivi – ovvero grapheion, agoranomeion, bibliothēkē, katalogeion e mnēmoneion (Cockle, 1984, p. 110) – ci indicano perciò diversi aspetti dell’apparato burocratico che costituiva il centro della sua amministrazione. Così l’archivio ha cominciato a indicare sia un luogo fisico sia il suo contenuto (vedi anche Casanova, 1928, p. 11), e ha assunto il valore di qualcosa che è in grado di persistere nel tempo, verosimilmente compresa, come apprendiamo da Posner (1972), ogni altra cosa ivi contenuta e sopravvissuta insieme e grazie a esso. Tale persistenza è stata resa possibile attraverso i processi di iscrizione, categorizzazione, preservazione e diffusione.
È stato Jacques Derrida (2005a, p. 11, corsivi nell’originale) a evidenziare come l’archivio rappresenti sia il «cominciamento» sia il «comando», ovvero: «Là dove le cose cominciano – principio fisico, storico o ontologico –, ma anche il principio secondo la legge, là dove uomini e dèi comandano, là dove si esercita l’autorità, l’ordine sociale, in quel luogo a partire da cui l’ordine è dato – principio nomologico».
Per Derrida, tale coesistenza di principi fisici, storici, filosofici e nomologici è evidente nell’origine della parola, il latino archivium o archium, che, come abbiamo visto, viene dal greco arkheion e indica «una casa, un domicilio, un indirizzo, la residenza dei magistrati supremi, gli arconti, coloro che comandavano» (ivi, p. 12). Nell’analisi di Derrida, ciò significa che «l’archivio, come stampa, scrittura, protesi o tecnica ipomnestica in generale, non è solo il luogo di stoccaggio e di conservazione di un contenuto archiviabile passato»: piuttosto, «la struttura tecnica dell’archivio archiviante determina anche la struttura del contenuto archiviabile nel suo stesso sorgere e nel suo rapporto con l’avvenire» (ivi, p. 28, corsivi nell’originale). In altre parole, le tecnologie e i relativi processi di ciò che egli chiama «archivio archiviante» formano, e quindi determinano, incontri presenti e futuri con materiali archiviabili. Di conseguenza, nell’analisi del filosofo, «l’archiviazione produce dal momento che registra l’evento» (ibidem). L’archivio non è solamente uno strumento di preservazione e un meccanismo di diffusione, è un sistema di ordinazione per la produzione di conoscenza. Per questa ragione è un sito, è il contenuto di tale sito, è un medium ed è anche il meccanismo stesso, l’«archivio archiviante» della produzione di se stesso (ibidem). In questo senso, l’archivio è anche predicato verbale.
I metodi di categorizzazione sono variati nel tempo e riflettono la trasformazione delle priorità all’interno delle società. Non solo: gli archivi hanno spesso avuto finalità diverse, perfino all’interno di una singola organizzazione o società. Per esempio, la città di Venezia non ha mai avuto un singolo archivio generale: ogni tribunale aveva infatti la possibilità di archiviare i propri documenti in maniera indipendente. Ciononostante, il potente Consiglio dei Dieci, uno dei principali organi di governo della Repubblica di Venezia tra il 1310 e il 1797, i cui atti erano spesso di natura riservata, teneva i propri archivi nella Segreta, specialmente durante il XVII e XVIII secolo, periodo in cui il rischio che venissero mescolati con altri archivi era più alto. Nel 1669 Antonio Negri realizzò un inventario di tali archivi e scoprì che si trattava di settantacinque armari (o casse) ordinati in base all’importanza del tribunale che aveva emesso il giudizio. A ogni modo, col passare del tempo il loro stato di conservazione peggiorò al punto che nel 1692 Pietro Garzoni dovette richiamare l’attenzione del Senato del Consiglio dei Dieci (Casanova, 1928, p. 373) e, nel 1716, vennero rimesse in vigore le antiche regolamentazioni secondo le quali nessuno poteva visitare la Segreta senza permesso o scrivere sui documenti lì conservati. Nonostante queste misure, tuttavia, non passò molto tempo prima che le vecchie pratiche lesive tornassero in auge. Così, nel 1783 venne nominato un “presidente degli archivi” col compito di identificare e mantenere un sistema di preservazione degli stessi. La storia di questi archivi, periodicamente oggetto di scombinamento e degrado fisico, è indicativa del funzionamento delle strutture di governo veneziane, il che suggerisce che l’archivio è generalmente un buon topos per lo studio di come individui e gruppi sociali gestiscono il potere, sia questo potere politico, amministrativo, legale o di altro tipo.
Una delle principali collezioni archivistiche di tutti i tempi, nonché un buon esempio di archivio 1.0, è quella degli Archivi vaticani. Fin dal principio questi archivi non avevano natura localistica e coprivano un arco temporale quantificabile in diverse centinaia di anni, sebbene, com’è tipico in questi casi, una grossa percentuale di essi sia andata distrutta o semplicemente smarrita nel corso del tempo. Proprio come gli Archivi veneziani, quelli vaticani non consistono in un unico archivio fisico, bensì in una serie di collezioni conservate da diversi settori amministrativi che ne riflettono i rispettivi sistemi burocratici. Per questo motivo, a titolo di esempio, c’erano archivi separati, tra i tanti, per il Concistoro, per la Dataria apostolica, per il Tribunale della Rota romana, per il Secretaria Brevium, per il Tribunale della Segnatura apostolica, per la Penitenzieria apostolica, per il Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, per il Sant’uffizio e per i magazzini speciali della Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro (Haskins, 1896, p. 41). Uno degli Archivi vaticani principali è l’Archivio apostolico vaticano, che ospita i beni archivistici della Santa Sede, contiene documenti che risalgono a più di un millennio fa e ospita decine di chilometri di scaffali (Blouin, Yakel, Coombs, 2008, pp. 410-411). I moderni archivi della Santa Sede furono istituiti attorno al 1610 da Paolo V, ma i materiali in essi contenuti erano stati accumulati fin dai tempi apostolici come parte dello Scrinium Sanctae Romanae Ecclesiae, che i papi portavano con sé quando si spostavano da una residenza all’altra. Ciononostante, la maggior parte dei documenti precedenti al papato di Innocenzo III sono andati perduti a causa della fragilità dei materiali e degli sconvolgimenti politici. Nel XV secolo i più importanti documenti rimasti furono trasportati a Castel Sant’Angelo e infine, su intervento di Paolo V, spostati nella Biblioteca segreta dove presero il nome di Archivi segreti vaticani. Nel XVII secolo, sotto Urbano III, conobbero una sostanziale espansione e nel XVIII furono riordinati per la prima volta. Molti fondi si trovano ancora nell’ordinazione predisposta all’epoca. Nel 1810, su ordine di Napoleone, gli archivi della Santa Sede furono portati a Parigi e poi di nuovo in Vaticano tra il 1815 e il 1817.
Questo spostamento causò gravi perdite. Nel 1870, quando le truppe italiane presero Roma, gli archivi ubicati al di fuori delle mura vaticane vennero confiscati dal neonato Stato Italiano e passarono quindi a costituire il nucleo del nuovo Archivio di Stato della città di Roma. Oggi tali archivi, nonostante le molte perdite subite nel corso della storia, consistono in 85 chilometri di scaffali divisi in seicento fondi e coprono ottocento anni di storia, dal 1189 in poi.
Tradizionalmente, gli archivi tenevano traccia di transazioni economiche e giuridiche per specifici scopi burocratici. Per quanto riguarda gli archivi antichi, questi includevano spesso il sistema delle leggi, le testimonianze dei provvedimenti amministrativi, i registri contabili e finanziari, i documenti del sovrano, i registri di controllo dei sudditi e gli atti notarili che salvaguardavano le transazioni (Posner, 1972, pp. 3-4). Tali archivi venivano tendenzialmente utilizzati come strumenti di gestione, legittimazione e consolidamento del potere. Non sorprende quindi che agli archivisti venisse associata una funzione di preservazione del potere. Proprio per questo motivo, quando nel XIV secolo i cittadini di Ferrara, impoveriti e provati da una serie di calamità naturali (tra cui una carestia e un’ondata di peste), si ribellarono contro il corrotto marchese Niccolò II d’Este (1338-1388), assassinarono in modo brutale il suo archivista Tommaso da Tortona (che all’epoca era il segretario della cancelleria di Stato) al grido di: «Lunga vita al marchese, morte al segretario Tommaso» (Brown, 1997, p. 2).
La strategia del marchese, non dissimile da quella di altri principi della casata d’Este, era stata quella di prendere le distanze dalle «politiche nettamente impopolari» del loro stesso governo e scaricare le colpe sui loro consiglieri e sui funzionari comunali, perciò Tortona era stato, in realtà, solo «la prima di una lunga serie di vittime sacrificali» (ivi, p. 11). Per di più, presso la corte d’Este, in tre diverse occasioni (nello specifico, durante il Venerdì Santo, alla vigilia della Festa di San Giorgio e durante la Festa dei poveri) la distruzione di documenti d’archivio era stata ufficialmente permessa e approvata tramite apposita cerimonia (ivi, p. 21), che consisteva in una messa durante la quale il duca, accompagnato da membri del clero e della corte, sullo sfondo dell’altare della cattedrale, liberava alcuni prigionieri e, contestualmente, distruggeva (o quantomeno espungeva) con fare solenne i documenti che li riguardavano. A quel punto gli atti commessi e le storie precedenti sul loro conto venivano cancellati, e i graziati potevano cominciare una nuova vita.
In questo genere di archivi l’iscrizione era sinonimo di potere, sebbene curiosamente, a causa dei frequenti avvicendamenti istituzionali, il loro ordinamento non fosse ancora significativo quanto lo sarebbe diventato nelle epoche successive. A ogni modo, già nel XIII secolo vi era consapevolezza che gli archivi giocassero un ruolo importante nella vita cittadina, e il loro ordine e la loro integrità erano protetti da specifiche procedure e regole (Bonfiglio-Dosio, 2005, p. 95). Tuttavia, come abbiamo visto attraverso l’esempio degli Archivi veneziani, le prassi in merito potevano variare in misura sostanziale.
All’epoca gli archivi erano descritti come loci publici in quibus instrumenta deponentur, ovvero «luoghi pubblici preposti all’ospitare documenti legali» (Duchein, 1992, p. 15; Sandri, 1968, p. 108). Un fatto interessante, peraltro in linea con le supposizioni di Derrida, è che in Ungheria i depositi archivistici erano chiamati loci credibiles, ovvero «luoghi che conferiscono credibilità giuridica ai documenti in essi contenuti» (Duchein, 1992, p. 15). Ciò dimostra come i siti preposti all’archiviazione, più ancora di ciò che in essi era conservato, erano divenuti sinonimo della loro autorità. Quando un documento veniva catalogato in un archivio riconosciuto guadagnava in credibilità, e probabilmente anche in affidabilità.
Ovviamente, gli archivi del periodo storico preso in esame non erano sempre pubblici (non a caso, sia quelli veneziani sia quelli vaticani facevano riferimento esplicito alla segretezza). Fino alla prima guerra mondiale, con la sola eccezione della Francia, gli archivi erano infatti inaccessibili alla maggioranza della popolazione. Il pensiero archiv...