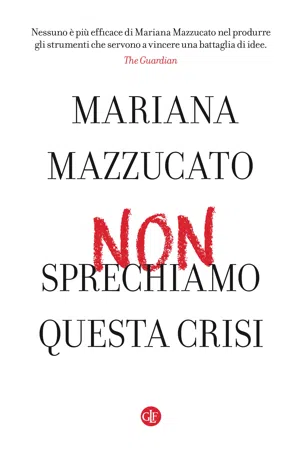1.
La crisi del Covid-19 è un’occasione
per cambiare il capitalismo
Il mondo vive una situazione critica. La pandemia da Covid-19 si sta rapidamente diffondendo
in tutti i paesi, con una portata e una gravità che non si vedevano dai tempi della
devastante influenza spagnola del 1918. Se non si provvederà a intraprendere un’azione
globale coordinata per contenerla, il contagio diventerà presto anche economico e
finanziario.
La gravità della crisi richiede l’intervento dei governi, che cominciano a muoversi.
Gli Stati stanno iniettando stimoli nell’economia e al tempo stesso cercano disperatamente
di rallentare la diffusione della malattia, per proteggere le popolazioni vulnerabili
e contribuire alla creazione di nuove terapie e vaccini. La rilevanza e l’intensità
di questi interventi ricordano un conflitto militare: è una guerra contro la diffusione
del virus e il tracollo economico.
E tuttavia c’è un problema. L’intervento che si richiede necessita di una struttura
molto diversa rispetto a quella scelta dai governi. A partire dagli anni Ottanta,
è stato chiesto ai governi di fare un passo indietro, lasciando che siano le imprese
a imprimere la direzione e a creare ricchezza, e di intervenire solo per risolvere
i problemi quando si presentano. Il risultato è che non sempre i governi sono adeguatamente
preparati e attrezzati per affrontare crisi come quella del Covid-19 o l’emergenza
climatica. Se si parte dal presupposto che i governi debbano attendere il verificarsi
di un enorme shock sistemico prima di decidersi a intervenire, arriveranno sempre
impreparati.
Così facendo, si indeboliscono le istituzioni essenziali che forniscono servizi pubblici
e beni pubblici in senso lato, come il National Health Service del Regno Unito, dove
dal 2015 ci sono stati tagli alla spesa sanitaria per un miliardo di sterline.
Il ruolo preminente degli affari nella vita pubblica ha determinato anche una perdita
di fiducia in ciò che lo Stato può fare da solo, e questo ha portato alla creazione
di numerosi e problematici partenariati fra pubblico e privato che privilegiano gli
interessi del business rispetto al bene pubblico. Per esempio, è stato ben documentato
che i partenariati pubblico-privato nel settore ricerca e sviluppo spesso favoriscono
i cosiddetti farmaci «blockbuster» a scapito di altri, meno appetibili dal punto di
vista commerciale, ma estremamente importanti per la salute pubblica, fra cui antibiotici
e vaccini per una serie di malattie con potenziale epidemico.
A ciò si aggiunge la mancanza di una rete di sicurezza e protezione per le persone
che lavorano in società caratterizzate da disuguaglianze crescenti, specie chi, privo
di tutele, opera nell’ambito della cosiddetta gig economy, ossia l’economia a chiamata.
Ma oggi ci si presenta l’occasione di approfittare di questa crisi per capire come
fare capitalismo in modo diverso. Occorre ripensare il ruolo dello Stato: anziché
limitarsi a correggere i fallimenti del mercato quando si verificano, i governi dovrebbero
assumere un ruolo attivo plasmando e creando mercati che offrano una crescita sostenibile
e inclusiva, oltre a garantire che le partnership con le imprese in cui confluiscono
fondi pubblici siano guidate dall’interesse pubblico, e non dal profitto.
Innanzitutto, i governi devono investire in, e in alcuni casi creare, istituzioni
che contribuiscano a prevenire le crisi e a facilitarne la gestione quando si presentano.
Il budget di emergenza del governo britannico, pari a 12 miliardi di sterline per
il servizio sanitario nazionale, è un’iniziativa lodevole, ma altrettanto importante
è l’attenzione agli investimenti a lungo termine per potenziare i sistemi sanitari,
invertendo le tendenze degli ultimi anni.
In secondo luogo, i governi devono coordinare meglio le attività di ricerca e sviluppo,
orientandole verso obiettivi di salute pubblica. La scoperta dei vaccini richiederà
un coordinamento internazionale di proporzioni titaniche, esemplificato dallo straordinario
lavoro della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Ma i governi
nazionali hanno anche un’enorme responsabilità nel plasmare i mercati guidando l’innovazione
per conseguire obiettivi pubblici, come hanno fatto ambiziose organizzazioni pubbliche
quali la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) negli Stati Uniti quando,
nel cercare di risolvere il problema di far comunicare i satelliti, finanziò quella
che oggi è la rete Internet. Un’iniziativa analoga nel settore sanitario porterebbe
a convogliare i finanziamenti pubblici nella soluzione dei grandi problemi sanitari.
Terzo, i governi devono strutturare i partenariati pubblico-privato così da garantire
che ne traggano vantaggio sia i cittadini sia l’economia. La sanità è un settore che
a livello globale riceve miliardi di denaro pubblico: negli Stati Uniti, il National
Institutes of Health (Nih) investe 40 miliardi di dollari all’anno. Dall’epidemia
di Sars del 2002, il Nih ha speso 700 milioni di dollari in ricerca sul coronavirus.
Visti gli ingenti finanziamenti pubblici destinati all’innovazione sanitaria, i governi
dovrebbero vigilare sui processi per garantire che i prezzi siano equi e che non si
abusi dei brevetti, oltre a salvaguardare la fornitura dei medicinali e controllare
che i profitti vengano reinvestiti nell’innovazione, anziché essere dirottati nelle
tasche degli azionisti.
E devono anche garantire, qualora si rendano necessarie forniture di emergenza – come
medicinali, letti ospedalieri, maschere o ventilatori –, che le stesse aziende che
beneficiano di sussidi pubblici nei periodi di congiuntura favorevole non speculino
alzando indebitamente i prezzi quando le cose vanno male. L’accesso universale e a
prezzi accessibili è essenziale non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.
Questo vale in special modo nelle pandemie: non c’è posto per il pensiero nazionalistico,
come il tentativo di Donald Trump di acquisire in esclusiva per gli Stati Uniti la
licenza per il vaccino contro il coronavirus.
Infine, è quindi giunto il momento di mettere in pratica la dura lezione della crisi
finanziaria globale del 2008. Quando le aziende, dalle compagnie aeree alla grande
distribuzione, si fanno avanti con richieste di salvataggio e altre forme di assistenza,
è importante non limitarsi a distribuire denaro. Si possono dettare condizioni affinché
i salvataggi siano strutturati in modo da trasformare i settori destinatari degli
aiuti, portandoli a far parte di una nuova economia, incentrata sulla strategia del
Green New Deal di ridurre le emissioni di carbonio, investendo al tempo stesso sui
lavoratori per aiutarli ad adattarsi alle nuove tecnologie. E bisogna farlo adesso,
fintanto che lo Stato si trova in posizione di forza. Sfruttiamo questo momento per
ripensare il sistema capitalistico con un approccio che restituisca centralità a tutte
le parti in causa. Non permettiamo che questa crisi vada sprecata.
2.
La triplice crisi del capitalismo
Il Covid-19 è un evento di vasta portata che mette in luce la fragilità di un’economia sempre più globalizzata e interconnessa, e non sarà certo l’ultimo.
Il capitalismo, infatti, sta affrontando almeno tre grandi crisi. Una crisi sanitaria indotta dalla pandemia ha rapidamente innescato una crisi economica con conseguenze ancora sconosciute per la stabilità finanziaria, e tutto questo si gioca sullo sfondo di una crisi climatica che non può essere affrontata con il solito approccio del «business as usual». Non dimentichiamoci che, fino a soli due mesi fa, i media ci proponevano immagini spaventose di vigili del fuoco, e non operatori sanitari, sopraffatti dalla fatica e dal superlavoro.
Questa triplice crisi ha portato alla luce diversi problemi rispetto al nostro modo di «fare capitalismo», che devono essere tutti affrontati nello stesso momento in cui siamo alle prese con l’emergenza sanitaria. Altrimenti, risolveremo semplicemente i problemi in un settore per crearne di nuovi altrove, così come accadde con la crisi finanziaria del 2008. I politici inondarono il mondo di liquidità senza indirizzarla verso opportunità di investimento valide. Di conseguenza, il denaro finì di nuovo in un settore finanziario che era (e rimane) inadatto allo scopo.
La crisi del Covid-19 sta mettendo in evidenza altri difetti ancora presenti nelle nostre strutture economiche, non ultima la crescente precarietà del lavoro, dovuta all’affermarsi della gig economy e al decennale deterioramento del potere contrattuale dei lavoratori. Molto più semplicemente, il telelavoro non è un’alternativa praticabile per la maggior parte dei lavoratori; e sebbene i governi stiano estendendo alcune tutele ai lavoratori con contratti regolari, gli autonomi potrebbero restare abbandonati al loro destino.
Peggio ancora, i governi stanno concedendo prestiti alle imprese in un momento in cui il debito privato è già storicamente elevato. Negli Stati Uniti, il debito totale delle famiglie poco prima dell’attuale crisi era di 14.150 miliardi di dollari1, ovvero 1.500 miliardi in più rispetto al 2008 (in termini nominali). E non dobbiamo mai dimenticare che è stato l’alto livello di indebitamento privato a causare la crisi finanziaria globale.
Purtroppo, nell’ultimo decennio, molti paesi hanno perseguito l’austerità, come se il problema fosse il debito pubblico. Il risultato è stato quello di erodere proprio le istituzioni del settore pubblico di cui abbiamo bisogno per superare crisi come la pandemia da coronavirus. Dal 2015, come si è detto, il Regno Unito ha tagliato i bilanci della sanità pubblica di un miliardo di sterline (poco meno di 1,1 miliardi di euro), sovraccaricando di lavoro i medici in formazione (molti dei quali hanno abbandonato del tutto il servizio sanitario nazionale) e riducendo gli investimenti a lungo termine necessari per garantire che i pazienti siano curati in strutture sicure, all’avanguardia e dotate del personale necessario. E negli Stati Uniti – che non hanno mai avuto un sistema sanitario pubblico adeguatamente finanziato – l’amministrazione Trump ha costantemente tagliato i finanziamenti e le funzioni di diverse istituzioni di primaria importanza, fra cui i Centers for Disease Control2.
Oltre a queste ferite autoinflitte, un settore imprenditoriale eccessivamente «finanziarizzato» succhia valore dall’economia premiando gli azionisti attraverso programmi di riacquisto di azioni, anziché sostenere la crescita a lungo termine con investimenti in ricerca e sviluppo, salari e formazione dei lavoratori3. Di conseguenza, le famiglie si sono impoverite e non dispongono più di riserve finanziarie; per questo incontrano maggiori difficoltà nella fruizione di beni di base come la casa e l’istruzione.
La cattiva notizia è che la crisi del Covid-19 sta aggravando tutti questi problemi. Quella buona è che possiamo approfittare dell’attuale stato di emergenza per cominciare a costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. Il punto non è ritardare o bloccar...