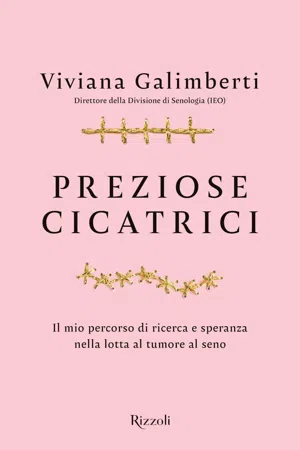“Bello è bello, ma caspita se è lontano.” Fu la prima cosa che pensai arrivando nella periferia sud di Milano ed entrando in quello che era ancora un enorme cantiere in mezzo ai campi. Con il mio solito senso pratico, mi immaginai uscire dal condominio dove vivevo allora in viale Suzzani, zona Bicocca, salire in macchina, percorrere viale Sarca e via Arbe, immettermi nella circonvallazione esterna all’altezza di viale Marche per poi imboccare via Ripamonti fino al numero 435. Tutto questo alle sette di mattina, orario di punta. Per raggiungere via Venezian impiegavo circa un quarto d’ora, qui ci avrei messo una quarantina di minuti, avrei dovuto alzarmi un’ora prima; ma non era la sveglia a preoccuparmi, quanto il traffico e l’idea di dover passare così tanto tempo in macchina per andare al lavoro.
A ben guardare, non avevo ancora un motivo reale di preoccuparmi della distanza e del traffico, perché il Prof fino a quel momento non mi aveva ancora detto se avrei lavorato con lui, in pratica non mi aveva offerto di seguirlo nella sua nuova avventura. Quando però invitò me, il dottor Luini e altri colleghi a vedere il nuovo istituto, lo considerai di buon auspicio. Perché mai avrebbe dovuto mostrarcelo? Per sapere se ci piaceva, per condividere la sua soddisfazione e basta?
Negli ultimi mesi all’Istituto dei Tumori nessuno aveva osato chiedere al Prof cosa sarebbe successo dopo, nel momento che stava per lasciare il suo ruolo e il suo posto in via Venezia. Più che altro: cosa sarebbe successo a noi, perché lui aveva le idee ben chiare. Non aveva certo intenzione di ritirarsi, e come sempre stava lavorando a un grande progetto che aveva reso pubblico già da qualche anno. Nel 1991 aveva infatti convinto imprenditori e istituti bancari a investire in un moderno polo di eccellenza che sarebbe dovuto divenire un punto di riferimento per l’oncologia: si trattava dell’Istituto Europeo di Oncologia.
A pochi mesi dall’inaugurazione dello IEO, le voci all’ottavo piano di via Venezian si riconcorrevano, non si parlava ormai d’altro. Un grande interrogativo aleggiava tra di noi: ci avrebbe chiesto di seguirlo? E se ce lo avesse chiesto, ci saremmo andati? Non era rischioso imbarcarsi in quella impresa?
La verità è che allora nessuno aveva la lungimiranza del Prof di vedere le potenzialità di quel progetto. Per noi comuni mortali rappresentava in un certo senso un salto nel buio. Quelli che avevano meno da perdere erano i contrattisti a tempo come me, quelli che invece avevano il posto fisso temevano di sacrificare la loro sicurezza per andare a lavorare in una struttura privata che poteva non decollare e non offrire le stesse garanzie.
Per me il ragionamento era diverso. Avevo trentasette anni, un contratto a tempo determinato, guadagnavo ottocentomila lire e non ero coperta in caso di malattia e maternità, in pratica se mi ammalavo non percepivo lo stipendio e se fossi rimasta incinta non avrei avuto diritto alla maternità. Tutte le soddisfazioni e le responsabilità che avevo conquistato lavorando all’ottavo piano non trovavano a livello contrattuale ed economico un trattamento giusto. Il legame con mio marito Guido era diventato difficile e di lì a poco ci saremmo separati, non era assolutamente nei miei progetti di quel periodo avere un figlio, e non lo era stato nemmeno negli anni precedenti, ma se anche avessi voluto, avrei dovuto rifletterci molto e, come tante colleghe nella mia stessa situazione, scegliere tra maternità e lavoro. Non lo trovavo corretto allora e non ho cambiato idea al riguardo: la maternità deve essere una scelta libera, consapevole e serena della donna che non dovrebbe essere costretta ad aspettare di avere un lavoro sicuro e delle garanzie per pensare a una gravidanza, che non dovrebbe essere spinta dalla mancanza di tutele a rimandare sempre questo momento, con il rischio che questo momento non si presenti più. Oggi molte più donne che in passato entrano in sala parto oltre i quarant’anni, ma possono considerarsi molto fortunate, visto che a partire da quell’età la fertilità si abbassa notevolmente e la probabilità di rimanere incinte anche. Non avendo in quel momento della mia vita un progetto di famiglia, mi dedicai in maniera quasi totalizzante al lavoro, un tipo di lavoro che di fatto richiede impegno e sacrificio soprattutto quando ne sei innamorata. La mia era passione pura, non lo facevo con l’obiettivo della carriera, ma di imparare e ottenere risultati importanti e utili. Seppure il mio ambiente mi piacesse, mi accorsi però che tra i colleghi c’era qualcuno più arrivista disposto a sgomitare o a calpestare gli altri, passando sopra gli affetti o le amicizie, pur di andare avanti. Io mi convinsi allora che non avrei mai fatto carriera, avevo un carattere poco incline a certi tipi di compromessi e non mi interessava il prestigio in sé. Mi interessava essere riconosciuta per il mio lavoro e per i miei effettivi meriti. Quello che cerco di insegnare oggi ai giovani è di investire moltissimo tempo, risorse e capacità in quello che fanno, ma non per “arrivare”, bensì per imparare quanto più possibile. Questa è una lezione che posso dare, perché nel mio caso ha pagato facendomi fare una bella carriera, potendo così smentire il luogo comune secondo il quale viene premiato solo chi non ha principi morali. Servono molte doti per riuscire, servono il talento, l’abilità, lo studio, il sacrificio, tanta pazienza e pure una piccola dose di fortuna, che ti fa trovare sulla strada le persone giuste.
Nel 1994, il mio futuro lo vedevo in sala operatoria e impegnata nella ricerca. Negli anni appena trascorsi all’Istituto di via Venezian ero stata travolta da quella che considero una specie di missione: sconfiggere il cancro; avevo partecipato a diversi studi, avevo parlato dei risultati di quegli studi in molti convegni, avevo lavorato a stretto contatto con il Prof anche in sala operatoria, avevo capito che si poteva fare tantissimo per il tumore alla mammella. Avanti su quella strada avremmo ridato la speranza alle donne ed eliminato quella specie di rassegnazione che accompagnava ogni nostra diagnosi.
Lo studio sui linfonodi era stato quello che mi aveva coinvolta maggiormente e da cui avevo tratto una grandissima soddisfazione, ma non era stato l’unico. Proseguendo la ricerca Milano I nella quale erano state messe a confronto la mastectomia radicale e la quadrantectomia, con la ricerca Milano II confrontammo invece la QUART (quadrantectomia con dissezione ascellare e radioterapia) e la TART (tumorectomia con dissezione ascellare e radioterapia) con lo scopo di capire se i risultati precedenti fossero dovuti all’intervento chirurgico o alla radioterapia. Avevamo infine concluso che con la tumorectomia, che comporta l’asportazione del tumore con un margine ridotto di tessuto sano rispetto alla quadranectomia, la percentuale di recidive locali era maggiore: in presenza di tumori inferiori ai due centimetri e mezzo era dunque consigliabile l’asportazione di una porzione generosa di tessuto sano attorno al nodulo e un programma di radioterapia post operatoria (questo perché le recidive locali richiedono un nuovo intervento chirurgico che dal punto di vista psicologico è sempre molto pesante per una paziente).
Nello studio seguente, Milano III, avevamo confrontato la QUART con la QUAD (quadrantectomia e dissezione ascellare senza radioterapia) per capire l’impatto della radioterapia nel protocollo della QUART. I risultati ci avevano fatto concludere che la radioterapia era sempre consigliabile nelle donne più giovani, ma poteva essere evitata in quelle che avevano più di cinquantacinque anni, almeno in certi casi specifici. Si trattava di un dato interessante, poiché ci dava un’indicazione sulla fascia di età per la quale era più indicato un tipo di trattamento piuttosto che un altro. Era un piccolo passo, e tanti altri ne avremmo fatti in seguito, per arrivare a trattamenti più mirati che una volta erano studiati sulla fascia di età, poi lo sarebbero stati sulle caratteristiche biologiche del tumore, e dopo ancora su quelle molecolari.
Negli ultimi anni in via Venezian avevamo gettato inoltre le basi di protocolli e tecniche chirurgiche che miravano a fare della restituzione del seno alla donna una parte integrante del trattamento. Fu allora che il Prof aveva cominciato a pensare alla tecnica della mirror quadrantectomy, la quadrantectomia a specchio. Il ragionamento era semplice: se si esegue una quadrantectomia su una mammella, la mammella a cui è stata asportata la sola area in cui è localizzato il tumore risulterà più piccola e diversa dall’altra. Perché allora non sottoporre anche l’altra mammella a un intervento identico per garantire la simmetria del seno? Non era solo una questione di estetica, da donna capivo le implicazioni psicologiche e gli effetti che poteva avere nel percorso di cura un risultato del genere. Negli anni seguenti, avremmo perseverato su questa strada tanto che allo IEO l’oncoplastica sarebbe diventata lo standard.
L’inserimento della chemioterapia neoadiuvante prima dell’intervento al seno fu praticamente l’ultimo progetto importante al quale lavorammo all’Istituto dei Tumori con il professor Gianni Bonadonna, oncologo di fama mondiale che a metà degli anni Settanta aveva introdotto la terapia adiuvante per ridurre le recidive o le metastasi dopo l’intervento chirurgico di asportazione. Il nostro obiettivo era quello di poter fare una chirurgia conservativa anche dove il tumore era più grande di tre centimetri, riducendolo prima con la chemioterapia. Con quello studio capimmo che la terapia neoadiuvante riduceva il tumore al punto di permettere una quadrantectomia e che in una percentuale significativa di pazienti si otteneva una risposta patologica completa, ovvero che all’esame istologico definitivo il tumore non c’era più. Nel 1995 i risultati dello studio sarebbero stati pubblicati sugli «Annals of Surgery», ma a quell’epoca molti di quelli, tra cui io, che avevano collaborato alla ricerca non lavoravano più all’Istituto dei Tumori. Seguendo il professor Veronesi nella sua nuova avventura, eravamo infatti andati allo IEO.
Proprio così. La mattina in cui il Prof ci invitò a visitare il cantiere quasi finito dello IEO, nella struttura mancavano solo i mobili, capimmo che ci voleva con lui nel suo ambizioso progetto. E già solo osservando l’intero complesso intuimmo che qualcosa di grande ci stava aspettando. Ci trovammo infatti di fronte a qualcosa di nuovo, almeno in Italia, un’unità architettonica immersa in un’area libera dai palazzoni della città, con qualche antica cascina a fare da sfondo, una struttura non imponente che risultava subito accogliente, decisamente di più degli anonimi padiglioni a cui eravamo abituati. All’interno, gli spazi erano ampi e luminosi, le stanze erano studiate per ospitare nel più totale comfort massimo due letti. Là sarebbe stata applicata una concezione moderna di ospedalizzazione, che avevamo in parte cominciato a sperimentare all’ottavo piano di via Venezian, una degenza più ridotta in termini di tempo, ma più alta in termini di qualità, dove il paziente sarebbe stato al centro di cure e attenzioni, dall’inizio alla fine.
L’istituto sarebbe dovuto divenire un polo di attrazione per medici e ricercatori di tutto il mondo che avrebbero lavorato insieme e fatto ricerca a livelli avanzati per curare il tumore, con un’attenzione particolare alla qualità della vita e alla prevenzione. Sarebbe dovuto divenire anche un centro attrattivo per i giovani che là avrebbero imparato e si sarebbero formati. Al momento della nostra visita non lo sapevamo ancora, ma di lì a pochi mesi il Prof avrebbe convinto i più grandi esperti italiani e stranieri a lavorare allo IEO, mentre il comitato scientifico del centro avrebbe annoverato tra i suoi membri i premi Nobel per la Medicina Renato Dulbecco e John Michael Bishop.
Il progetto sulla carta era bellissimo, ma applicare a una struttura sanitaria i principi di una organizzazione privata rappresentava per molti un azzardo. Per l’Italia era una novità assoluta e non sapevamo bene cosa aspettarci. Come detto, fra i miei colleghi ero tra quelli che avevano meno da perdere e tutto da guadagnare. Il Prof aveva un bagaglio di esperienze, conoscenze e capacità, in una parola aveva un’autorevolezza tale da convincere banchieri e imprenditori a investire cospicui capitali in quel progetto. Se ci credevano loro, perché non dovevo avere fiducia io? Il fatto che ci fosse lui, per me era una garanzia più che sufficiente. Tanto più che dopo sei anni di contratti a tempo, sarei stata assunta. Non si trattava meramente di una questione economica, ma alla fine la mia professionalità e i miei diritti venivano riconosciuti e questo lo trovavo un passo importante per la mia vita di medico e di persona. Potevo continuare a fare quello che amavo, l’attività clinica e la ricerca avanzata, guardando al mio futuro con più serenità e più consapevole di quanto valesse il mio lavoro, di quanto valessi io.
Non posso però negare di aver avuto anch’io una preoccupazione nel fare quel passaggio. E non c’entrava con il traffico di Milano nell’ora di punta. Una volta approdati in via Ripamonti saremmo dovuti ripartire in qualche modo da zero. Almeno per quanto riguardava la casistica dei pazienti su cui poter fare le nostre ricerche. La forza di un istituto di ricerca ospedaliera consiste anche nel numero dei pazienti che ha curato, sta curando e curerà, perché le loro cartelle rappresentano dati importantissimi per nuovi possibili studi. Noi non avevamo pazienti ed essendo lo IEO una struttura privata non sarebbe stato semplice, e velocissimo, averne il numero necessario a dare validità scientifica al nostro lavoro. Provavo in un certo qual modo una specie di ansia.
E secondo me, anche il professor Veronesi era preso da una qualche forma di ansia, o potrei dire piuttosto smania, mitigata ovviamente dai suoi modi gentili, appena lo IEO aprì. Ebbi questa impressione pochi giorni dopo l’inaugurazione, che avvenne il 30 maggio del 1994, quando cominciò a fare un’azione di pressing garbato ma ostinatissimo affinché fosse tutto in regola dal punto di vista burocratico per poter cominciare a operare. Aveva già messo in agenda i primi interventi e per nessuna ragione al mondo avrebbe posticipato i suoi piani.
Mentre ancora le ruspe finivano gli ultimi lavori dell’arredo esterno, l’8 giugno una quarantanovenne di Bergamo veniva lasciata dal marito nella hall pressoché deserta dell’Istituto. Era la prima paziente dello IEO. Come da programma, il Prof riuscì a operarla. Una quadrantectomia con dissezione ascellare. E ad assisterlo c’ero io.
Qualcosa di grande era iniziato.
L’attesa. L’impazienza. Il momento più difficile. Penoso anche.
C’è chi sostiene che non bisognerebbe avere come pazienti le persone alle quali tieni molto, ma non è una regola professionale o ontologica, anche perché non sarebbe poi così fondata. Quando si ammala qualcuno a cui tieni molto, un parente o un amico, sei coinvolto e questo potrebbe farti perdere la lucidità, il pensiero che muoia potrebbe indurti a voler provare qualsiasi cosa per salvargli la vita, o per staccarti il più tardi possibile da lui, senza capire il limite oltre il quale non è più cura, ma accanimento. E nessuno si meriterebbe di finire la propria vita in questo modo. Soprattutto se gli vuoi bene.
Operare però è diverso, è quello che so fare meglio, è il modo in cui sono più brava a occuparmi degli altri, mi sento più tranquilla se posso farlo io, soprattutto se sono legata alla paziente. Diversamente mi sentirei impotente. La sala operatoria è il mio campo, il bisturi la mia arma, quando il tumore c’è, non posso sconfiggerlo in altro modo se non stando in prima linea.
Laura, poi, non mi aveva lasciato altra possibilità. Anche volendo, non si sarebbe fatta seguire da nessun altro.
«Devi essere tu» mi aveva detto al telefono.
Aveva appena fatto la mammografia di controllo e c’era qualcosa che non andava.
«Vieni qui, ti visito e facciamo gli altri esami che servono» le dissi per tranquillizzarla.
«Se devo essere operata, lo farai tu o nessun altro!» Aveva già deciso.
All’epoca Laura non abitava a Milano. Da molti anni viveva in provincia di Varese, al confine con la Svizzera. L’ospedale vicino casa sua sarebbe stato per lei la scelta più comoda, ma aveva bisogno di me, come medico e come persona. E decise di curarsi allo IEO.
La capivo, se fossi stata al suo posto, se mi fossi dovuta operare io, avrei voluto chiudere gli occhi con lo sguardo fisso in quello di una persona che mi vuole bene. Quando sei in sala operatoria, a guardare il mondo dalla tua prospettiva orizzontale, con l’anestesista che ti chiede in quale posto vorresti volare prima di pigiare sullo stantuffo della siringa e di farti addormentare, puoi essere la persona più solida, ma le paure arrivano, una dopo l’altra, incontrollate. Non c’è solo quella della malattia. Sono tanti i pensieri: e se dovesse essere peggio di come sembra? E se qualcosa andasse storto durante l’intervento? E se non aprissi più gli occhi? Tutto quello a cui non avevi pensato prima, affiora. Anche l’irrazionale. Poi devi fare i conti con il momento in cui ti sveglierai. Come ti sentirai? Avrai nausea? E al petto? Proverai male. Assenza. Come sarà? Mille timori, paure, insicurezze. Tutte le pazienti avrebbero diritto a un gesto d’amore, una carezza, proprio come quella che il Prof dava alle sue prima dell’anestesia.
A Laura avevo detto: «Stai tranquilla, andrà tutto bene, ci sono io qui con te!».
Lei si era addormentata e io avevo cominciato a incidere. Per prima cosa avevo prelevato il linfonodo sentinella per mandarlo subito ad analizzare. Proseguii con l’asportazione della ghiandola mammaria preservando l’areola e il capezzolo, che mi avrebbe permesso di fare una mastectomia conservativa, quella che chiamiamo nipple-sparing. Mentre operavo, continuavo però a pensare al verdetto dell’anatomopatologo, e mi scoprii ansiosa. Mi scoprii a pregare che il linfonodo fosse negativo. Almeno avrei evitato a Laura l’asportazione di tutti i linfonodi e si sarebbe ripresa prima. Quello era il pensiero che avevo spesso quando operavo pazienti giovani e ancora molto attive nel lavoro e nella vita privata.
Io e Laura siamo nate nello stesso anno, a pochi giorni di distanza, io il 12 dicembre e lei il 19. Laura è mia cugina, figlia di zia Giancarla, la sorella di mia madre. Siamo cresciute insieme nel cortile di ...