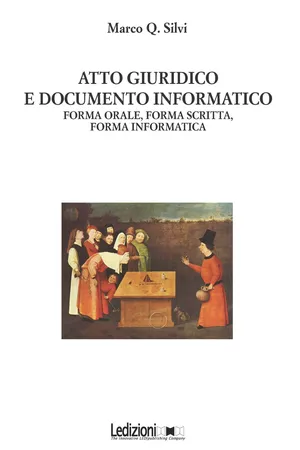![]()
PARTE I
TEORIA
La rappresentazione del tutto limita la diversità del dettaglio, anche nel caso di una visione d’insieme appena abbozzata.
Fiedrich D. E. Schleiermacher
![]()
1.
ELEMENTI DI UNA TEORIA DELL’ATTO GIURIDICO
L’azione possiede una sua logica peculiare.
Dunque, quando un’azione è iniziata,
la sua logica procede implacabile.
Yukio Mishima
1.1. Atti linguistici e atti giuridici
Se riconosciamo una dimensione linguistica dei fenomeni giuridici e se riteniamo che gli atti giuridici altro non siano che un particolare modo di agire mediante il linguaggio (se riteniamo che gli atti giuridici siano atti linguistici che acquistano un certo “rilievo” in un determinato ordinamento e in virtù di quell’ordinamento), allora la domanda principale è: che cosa è un atto linguistico? Cosa significa agire mediante il linguaggio?
La risposta alla domanda e la comprensione della risposta sono complesse. Il cammino che porta a esse passa attraverso alcuni concetti e distinzioni che si svolgono – in modo sintetico e senza pretesa di completezza – nel presente capitolo 1.
1.1.1. Distinzioni preliminari: enunciato, enunciazione, proposizione
In primo luogo, è opportuno richiamare introduttivamente alcune nozioni utili, da un lato, per meglio comprendere cosa sia un atto linguistico e, dall’altro lato, per fornire al discorso un lessico più rigoroso e appropriato.
Si distingue pertanto il significato dei seguenti termini utilizzati per designare differenti “entità” linguisticamente rilevanti: ‘enunciato’, ‘enunciazione’, ‘proposizione’.
Per ‘enunciato’ [inglese: ‘ sentence’, tedesco: ‘Satz’] si intende un insieme di parole avente senso compiuto. ‘Vietato fumare’ è un enunciato. ‘Papé satan papé satan alleppe’ non è un enunciato perché l’insieme di parole non ha senso compiuto. Quando diciamo che l’espressione ‘È vietato fumare’ consta di tredici lettere, stiamo parlando dell’enunciato italiano ‘È vietato fumare’.
Per ‘proposizione’ [inglese: ‘proposition’, tedesco: ‘Proposition’] si intende il significato, il senso, di un enunciato. Il significato dell’enunciato ‘È vietato fumare’ consiste nel fatto che sia vietato fumare, che v’è un divieto di fumare, oppure (ciò che è la stessa cosa) che v’è un obbligo di non fumare.
Per ‘enunciazione’ [inglese: ‘utterance’, tedesco: ‘Äußerung’] si intende l’atto del proferire, del pronunciare un determinato enunciato. Se Tizio dice a Caio “È vietato fumare”, Tizio sta enunciando l’enunciato ‘È vietato fumare’. Più in particolare, se Tizio è un Re che non tollera il fumo e Caio il suo attendente che ama invece fumare, mediante l’enunciazione dell’enunciato ‘È vietato fumare’ Tizio ingiunge (comanda, ordina) a Caio di non fumare, ossia Tizio (Re-intollerante-al-fumo), dicendo a Caio (attendente-fumatore) “È vietato fumare”, compie un atto, un atto di linguaggio, l’atto di linguaggio denominato ingiunzione (comando, ordine).
Gli atti linguistici si compiono mediante l’enunciazione di enunciati.
La pragmatica (o pragmatica linguistica) è la scienza che studia gli atti linguistici, ossia l’agire umano mediante enunciazioni di enunciati compiute in determinati contesti. La semantica studia, invece, i significati degli enunciati collocati in determinati testi, mentre la sintassi si occupa della corretta struttura degli enunciati.1
1.1.2. Ambivalenza pragmatica vs. ambiguità semantica
Le distinzioni compiute sub 1.1.1 consentono di comprendere meglio due fenomeni, la cui comprensione illumina le medesime distinzioni e la loro raison d’être.
Esempio del primo fenomeno. L’enunciazione dell’enunciato ‘Da oggi è vietato fumare’, se compiuta dal Re ormai spazientito dai suoi sudditi dediti al vizio del fumo, e diretta al Cancelliere di Corte competente a disporre le azioni necessarie a far rispettare la volontà del sovrano, è un comando rivolto ai sudditi. Infatti, pronunciando le parole ‘Da oggi è vietato fumare’, il Re ha compiuto un atto che ha una particolare funzione, quella di prescrivere un determinato comportamento.
Ma l’enunciazione del medesimo enunciato ‘Da oggi è vietato fumare’, se compiuta da uno studente che si trovi in un’aula che da quel giorno era stata riservata ai non-fumatori, e diretta a un amico in risposta alla richiesta di quest’ultimo se si possa fumare, non è un comando, bensì una informazione (rivolta all’amico) sulle regole vigenti. Pronunciando le medesime parole del Re, ma in un contesto del tutto diverso, lo studente ha compiuto un atto (linguistico) che ha una particolare funzione, quella di descrivere un certo “stato di cose” (il divieto di fumare in quella determinata aula).
Esempio del secondo fenomeno. L’enunciato ‘Non devi fumare’, se rivolto dallo studente a un amico che entrando in un’aula in cui è vietato fumare sta per accendersi una sigaretta (in una situazione analoga a quella descritta nel primo esempio) potrebbe significare che “È vietato fumare”, oppure “Ti è vietato fumare”, o “Hai l’obbligo di non fumare”.
Se il medesimo enunciato ‘Non devi fumare’ è, invece, pronunciato da una studentessa amante del fumo e diretta a uno studente che abitualmente non fuma ma che per mero compiacimento della ragazza decide di fumare, significherebbe, invece, l’esatto opposto, ossia che “Non sei obbligato a fumare!”, oppure “Fumare è facoltativo”, oppure “Non v’è alcun obbligo di fumare”.
I due fenomeni sono apparentemente simili, ma categorialmente diversi.
Il primo fenomeno opera a livello di enunciazioni. Si tratta di un medesimo enunciato (nell’esempio, l’enunciato ‘Da oggi è vietato fumare’) che ammette (almeno) due enunciazioni (nell’esempio, un’enunciazione prescrittiva – l’atto di comando del Re; e una enunciazione descrittiva – l’atto dell’informazione compiuto dallo studente). Si tratta di un fenomeno pragmatico.
Il secondo fenomeno opera invece a livello di proposizioni. Si tratta di un medesimo enunciato (nell’esempio, l’enunciato ‘Non devi fumare’) che ha (almeno) due significati, due proposizioni (nell’esempio, il significato che fumare è vietato, e il significato che fumare è facoltativo). Si tratta quindi di un fenomeno semantico.
Con il sintagma ‘ambivalenza pragmatica’ ci si riferisce al primo fenomeno, ossia al fenomeno per cui un medesimo enunciato ammette (in potenza) più enunciazioni.
Ad esempio, l’enunciato ‘questo è tuo’ ammette almeno due enunciazioni: una enunciazione descrittiva (se pronunciato da Tizia al fidanzato Caio che le domanda a chi appartenga il maglione che Tizia indossa, Tizia informa Caio sulla proprietà del maglione che indossa) e una enunciazione ascrittiva (se pronunciato da Caio che porge alla fidanzata Tizia il regalo che le ha acquistato – Caio dona a Tizia il regalo ascrivendogliene la proprietà).
Con il sintagma ‘ambiguità semantica’ ci si riferisce, invece, al secondo fenomeno, ossia al fenomeno di enunciati che possono avere diversi significati.
Ad esempio, l’enunciato ‘Non devi inserire Filosofia del Diritto nel piano di studi’ può significare, alternativamente, che “Non sei obbligato a inserire Filosofia del Diritto nel piano di studi” (“Hai la facoltà di inserire o meno Filosofia del Diritto nel piano di studi”), oppure che “Non devi inserire Filosofia del Diritto nel piano di studi” (“Ti è proibito inserire Filosofia del Diritto nel piano di studi”).2
Si osservi: a fronte di un enunciato pragmaticamente ambivalente è il contesto in cui si svolge l’azione che consente di chiarire quale tipo di enunciazione viene compiuta. A fronte di un enunciato semanticamente ambiguo è il contesto in cui l’enunciato si trova (ad esempio, all’interno di un testo scritto, ma anche nell’ambito di un contesto di soggetti che agiscono tra loro enunciando l’enunciato ambiguo) che consente di selezionare il significato dell’enunciato, la proposizione che l’enunciato ha (con il sintagma ‘contesto pragmatico’ ci si riferisce al contesto in cui si svolge l’azione e che consente di chiarire il tipo di enunciazione che viene compiuta).
1.1.3. Usi del linguaggio: uso descrittivo vs. uso prescrittivo
Come visto sub 1.1.2, un enunciato può essere proferito per compiere atti diversi. Ciò dipende dal contesto pragmatico in cui si compie l’enunciazione del determinato enunciato. Come visto, mediante il discorso, noi agiamo, compiamo azioni: impartiamo ordini, rendiamo informazioni, attestiamo che qualcosa è avvenuta, ecc.
Sub 1.1.2 è stata mostrata una delle principali differenze tra i diversi usi del linguaggio: un enunciato può essere proferito per rendere una informazione attorno a uno stato di cose (nell’esempio, si trattava dello studente che informava l’amico sul nuovo divieto di fumare nell’aula), oppure per ordinare a qualcuno di tenere una certa condotta (nell’esempio, il Re ordinava ai sudditi di cessare di fumare). Nel primo caso, il linguaggio è utilizzato con una funzione descrittiva, nel secondo caso con funzione prescrittiva.
1.1.3.1. Si osservi: i concetti di descrittivo e di prescrittivo possono essere ritenuti concetti di genere, nel senso che un uso descrittivo o prescrittivo del discorso è compiuto mediante specifici atti linguistici.
Il comando, l’intimazione, la diffida, l’ingiunzione, l’atto di statuizione di un c.d. dovere generale e astratto, sono atti linguistici che presentano caratteristiche diverse.
Ad esempio, il comando è l’atto con cui chi comanda prescrive a un soggetto suo subordinato di fare alcunché; l’intimazione è l’atto con cui un soggetto che vanta un diritto nei confronti di un altro soggetto prescrive a quest’ultimo di rispettare tale diritto.
Ma, sia l’atto del comando (eseguito ad esempio mediante l’enunciazione dell’enunciato ‘Io ti comando di catturare il ladro’ – proferita dal commissario nei confronti dell’appuntato), sia l’atto dell’intimazione (eseguito ad esempio mediante l’enunciazione dell’enunciato ‘Io ti intimo di adempiere al contratto’ – compiuta dalla parte adempiente nei confronti della controparte inadempiente) sono casi specifici in cui il discorso è compiuto con funzione prescrittiva.
1.1.3.2. Si osservi inoltre: prescrittivo e descrittivo non esauriscono le funzioni del linguaggio. In realtà, gli usi del discorso sono molteplici: ad esempio, si può parlare per commuovere qualcuno, per convincere qualcuno di una tesi (c.d. funzione espressiva), oppure per trasferire un diritto o attribuire una responsabilità a qualcuno (c.d. funzione ascrittiva).
L’uso ascrittivo del linguaggio è un fenomeno ancora non sufficientemente studiato ma filosoficamente provocante, in quanto sembra porsi a metà strada tra descrittivo e prescrittivo.
Si prenda, ad esempio, l’enunciazione dell’enunciato ‘Questo è tuo’ compiuta dal padre che regala al proprio figlio un cimelio di famiglia: essa è esecuzione di un atto linguistico con cui viene ascritta la proprietà del cimelio al figlio.
Da un lato, l’ascrizione sembra avere in comune con la descrizione il fatto di attestare un certo stato di cose (nell’esempio, che la proprietà del cimelio è del figlio). Tuttavia, l’ascrizione differisce dalla descrizione in quanto, con l’ascrizione, il fatto che uno stato di cose sia in un certo modo è il prodotto, il risultato, costituito per mezzo dello s...