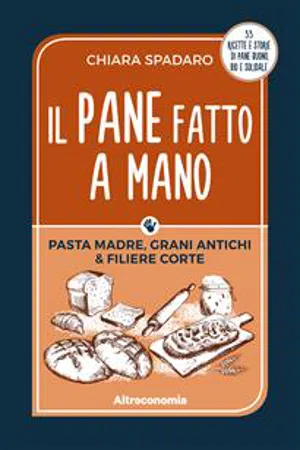
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Pasta madre, grani antichi & filiere corte
Pane, pizza, focacce e dolci, con grani tradizionali, farine bio e pasta madre.
Tutta farina del nostro sacco: la ricetta base per la pasta madre e 33 ricette perfette di pane, pizza e focaccia, tigelle e taralli, croissant e molto altro.
Questo manuale porta acqua al mulino di un pane casalingo, bio, sano e solidale: spiega infatti in modo semplice le tecniche per panificare e i segreti dei grani antichi, varietà che preservano salute e biodiversità. Con l'intervento dei maggiori esperti e le storie delle filiere corte, biologiche e solidali nate in tutta Italia.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il pane fatto a mano di Chiara Spadaro in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Arte e Arte culinaria. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Capitolo 1. La farina del nostro sacco
“Allora è grano, semi di cereali, vento
che muove i passi, e canta: sotto i piedi
ci sono le grandi pianure, le pietre bianche
di strade bianche di strade che portano al mare…”
Fabio Pusterla, “Corpo stellare” (2010)
IL GRANO
Vi siete mai chiesti quale grano abbia tra le mani la “donna che semina il grano” cantata da Fabrizio De André? Se “voltiamo la carta” appare un contadino: “il villano che zappa la terra”.
La storia del grano, infatti, come quella di altre colture, è sempre stata strettamente legata alle scelte dei contadini e alla loro saggezza millenaria.
Ma con l’industrializzazione dell’agricoltura, in Italia e altrove, lo scenario è cambiato: l’esigenza - sempre più imperiosa - di aumentare le rese e di produrre grani adatti alle lavorazioni industriali ha portato a selezionare solo le varietà più produttive e redditizie e di più semplice lavorazione, facendoci dimenticare valori come il rispetto della terra e della biodiversità in campo, così come alcune importanti proprietà nutritive delle varietà storicamente coltivate.
Non era certo questo l’obiettivo di Nazareno Strampelli (Macerata, 1866-1942), il grande agronomo e genetista marchigiano che cambiò l’agricoltura italiana e non solo, lavorando sul miglioramento genetico del grano tenero attraverso incroci (“ibridismo”) con semi provenienti da ogni parte del mondo. Il suo obiettivo era semplice: creare varietà con maggiori rese, più basse e più resistenti all’allettamento e ad altre avversità come la ruggine e con un ciclo vegetativo che anticipasse la maturazione. L’Ardito fu il primo di una lunga serie di incroci (se ne contano circa 800), di cui una sessantina verrà coltivato e commercializzato: tra le molte Sementi Elette - come le chiamava - da lui create Strampelli è anche “padre” del grano Senatore Cappelli, protagonista della cosiddetta “battaglia del grano”
del ventennio fascista. Strampelli è considerato un precursore dell’agronomo statunitense Norman Borlaug, premio Nobel per la pace nel 1970, principale artefice della “Rivoluzione verde” che migliorò sì le rese nei Paesi del “Terzo mondo” ma incentivò anche l’uso massiccio di fertilizzanti chimici e antiparassitari e di tecniche agricole non sostenibili.
Le conseguenze del “miglioramento genetico” e della meccanizzazione - pur con vantaggi indubitabili (ad esempio meno fatica per gli agricoltori) - si sconteranno però in altri termini: il massiccio ricorso a fertilizzanti e pesticidi, la dipendenza di chi coltiva dal loro acquisto e da quello del seme - un mercato in mano a poche multinazionali -, il peggioramento della fertilità, l’erosione dei suoli, un forte consumo di acqua, una minore variabilità genetica, l’uniformità delle farine e dei prodotti alimentari derivati, la cui salubrità è controversa.
In Italia, soprattutto con l’avvento della “Rivoluzione Verde” e l’introduzione dei fertilizzanti azotati, diventò più pressante l’esigenza di trovare un cultivar di bassa taglia, resistente all’allettamento, alle malattie e con un’alta resa. Al Centro della Casaccia di CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare, poi trasformato in ENEA) si sperimentavano a questo scopo mutazioni indotte dall’irraggiamento in campo da fonti radioattive, come il Cobalto 60. Proprio da un incrocio fra un grano mutante radio-indotto dal Senatore Cappelli e un ibrido di grano duro e tenero proveniente dal Centro Internacional de Mejoramento de Maize & Trigo messicano, si ottenne negli anni 70 la varietà registrata con il nome Creso, il cui successo e diffusione furono enormi. Nel giro di pochi anni diventò il grano duro più diffuso: tutti ne avete mangiato in grandi quantità, sotto forma di pasta. Dal Creso, incrociato con altre varietà, è scaturita buona parte delle varietà di frumento duro che oggi si coltivano, a scapito di molte altre.
Il “miglioramento genetico” o breeding ha - in sintesi - sortito il lento tramonto delle varietà locali, che non avevano bisogno di chimica e di particolari lavorazioni del terreno, sostituite da nuove cultivar molto più produttive. L’industria della trasformazione industriale si è di buon grado adattata a lavorare grani (di cui oltre la metà arriva dall’estero) e farine con caratteristiche che, come vedremo, le rendono adatte e resistenti alle lavorazioni e agli impasti industriali ma che fanno molto discutere per il possibile impatto sul nostro organismo.
Ma che cosa sono quindi i “grani antichi”?
I “GRANI ANTICHI”
Si definiscono impropriamente e convenzionalmente grani antichi o tradizionali le cultivar ad alto fusto e bassa resa selezionate dai contadini in migliaia di anni di storia agricola in uno specifico territorio ed esistenti prima della cosiddetta “Rivoluzione Verde”. In altre parole quelle che hanno mantenuto intatto il loro codice genetico originale e non hanno mai subito pratiche moderne di miglioramento genetico.
Lo studioso Enzo Spisni, docente di Fisiologia della Nutrizione all’Università di Bologna riassume così in pochi punti le differenze sostanziali tra i grani pre-rivoluzione e quelli post-rivoluzione:
• la taglia: grani pre-rivoluzione sono a taglia alta (oltre il metro e trenta), mentre i moderni sono a taglia bassa (molto al di sotto del metro);
• la produttività per ettaro, che aumenta molto nei moderni a fronte però dell’aumento dell’input di azoto attraverso la concimazione;
• la minore variabilità genetica, nel senso che le cultivar antiche erano un insieme di genotipi con una biodiversità complessivamente elevata, mentre post-rivoluzione si è andati verso la selezione di grani “in purezza”, fatta di piante tutte geneticamente identiche, con una perdita netta di biodiversità non trascurabile. Mentre una variabilità genetica ampia è in grado di adattarsi ai mutamenti ambientali, una variabilità genetica ridotta richiede un maggior intervento dell’uomo che spesso si traduce in utilizzo di prodotti chimici.
• la produttività per ettaro, che aumenta molto nei moderni a fronte però dell’aumento dell’input di azoto attraverso la concimazione;
• la minore variabilità genetica, nel senso che le cultivar antiche erano un insieme di genotipi con una biodiversità complessivamente elevata, mentre post-rivoluzione si è andati verso la selezione di grani “in purezza”, fatta di piante tutte geneticamente identiche, con una perdita netta di biodiversità non trascurabile. Mentre una variabilità genetica ampia è in grado di adattarsi ai mutamenti ambientali, una variabilità genetica ridotta richiede un maggior intervento dell’uomo che spesso si traduce in utilizzo di prodotti chimici.
Chi coltiva e trasforma in pane e pasta le vecchie varietà di grani locali, conosce bene le loro caratteristiche vincenti: possono crescere e produrre senza la chimica di sintesi (sono comparse quando quest’ultima non esisteva) e riescono a dare un raccolto dignitoso, sia per quantità, che per qualità organolettiche, limitando il lavoro alla rotazione colturale; poiché sono molto più alte delle nuove varietà, non temono le erbe infestanti e per gli stessi motivi si prestano alla coltivazione con metodi di agricoltura biologica, che conservano la fertilità del suolo, salvaguardano l’ecosistema e la sua biodiversità, consumano meno energia, riducono al minimo il rilascio di residui nel terreno, nell’aria e nell’acqua. Del resto un campo di cereali antichi, ad esempio un “campo catalogo” di una delle aziende associate alla Rete dei Semi Rurali ( www.semirurali.net) si riconosce a occhio. Le vecchie varietà crescono infatti molto più alte, hanno una moltitudine di forme e colori unici. Ognuna di queste varietà ha proprietà nutritive, organolettiche e caratteristiche specifiche - ad esempio alcune sembrano più facilmente digeribili - e ciascuna porta con sé una storia che, quando fortunosamente si è conservata, abbiamo la responsabilità di trasmettere. Perché la biodiversità va coltivata, attivando un circuito economico virtuoso a sostegno di quelle piccole comunità contadine che lavorano la terra con il minimo impatto.
UN CUSTODE DEL GRANO: GIUSEPPE LI ROSI
Il Rinascimento del pane, a cui abbiamo accennato, ha tra i suoi “maestri” Giuseppe Li Rosi -, uno dei pionieri dell’agricoltura biologica della Sicilia. Nella sua azienda a Raddusa nella Città Metropolitana di Catania (che è “Città del grano”), tra le miniere di zolfo e le cave di gesso, coltiva su oltre 200 ettari solo cereali di varietà storiche siciliane. Gli abbiano chiesto di raccontarci il senso del suo lavoro.
Giuseppe, che cosa sono i grani antichi?
Preferisco chiamarli “grani locali”. Il termine “antichi”, infatti, non ci aiuta a focalizzare la questione, se consideriamo che tra 50 anni i grani che oggi chiamiamo moderni potrebbero essere considerati antichi. Con grani locali intendiamo quelli che appartengono alla biodiversità tradizionale di un territorio e che, in questo momento storico, stanno diventando un’occasione di trasformazione culturale ed economica dell’azienda. Questo perché, attraverso la riscoperta delle varietà storiche dei grani, gli agricoltori tornano a essere i protagonisti delle filiere locali, facendo la selezione in campo delle varietà che più gli interessano e riscoprendone la storia, e le aziende possono offrire un prodotto che è molto apprezzato dai consumatori.
Quali varietà state selezionando in Sicilia?
In collaborazione con la Stazione Consorziale Sperimentare di Granicoltura della Sicilia, a Caltagirone (CT, www.granicoltura.it), fondata nel 1927, siamo partiti dalla varietà che era considerata la più scadente, la meno apprezzata: Timilìa o Tumminìa. È una varietà di grano duro con un glutine meno tenace rispetto ai grani ad alta resa, che permette quindi di realizzare dei prodotti con un gluten index inferiore a 60% (mentre i grani moderni hanno indici superiori al 90%). Poi abbiamo riscoperto la Maiorca, un grano tenero con uno stelo esile, che matura velocemente, e dà una pregiata farina bianca. Quindi abbiamo scoperto di avere sempre avuto nella nostra terra (senza mai saperlo valorizzare) il grano duro Khorasan (lo stesso registrato con il marchio canadese Kamut®): si chiama Perciasacchi, o Strazzavisazz, per la forma appuntita del chicco. Il grano duro Russello, invece, non è mai andato perduto perché è sempre stato coltivato nella Sicilia Sud orientale, per produrre il pane a pasta dura degli Iblei, tipico delle provincie di Ragusa e Siracusa. Questo “rinascimento” dei grani antichi ci ha poi fatto riscoprire altre vecchie varietà, la Scorzonera, il Nero delle Madonie e il Margherito o Bidì, un grano duro simile al Senatore Cappelli, selezionato nella contrada Margherito di Ramacca (CT) negli anni 20 e usato per fare il “pane di Ramacca”.
Quali varietà sono più interessanti per panificare con pasta madre?
I grani duri Margherito e Timilìa sono ideali per il pane e hanno un indice glutinico molto basso. Mentre il primo lavorato in purezza produce comunque un pane meraviglioso, per la Timilìa è meglio fare delle miscele con altri frumenti più forti: noi per “rinforzare” gli impasti deboli usiamo il “miscuglio” di Salvatore Ceccarelli (vedi p. 23) e riusciamo così ad avere pani ben lievitati.
Da questa riscoperta dei grani locali è nata Simenza. Che cos’è?
La nostra “cumpagnìa siciliana sementi contadine” è una rete di 150 tra agricoltori, allevatori, mugnai e pastai, fornai e ricercatori che lavorano in Sicilia su un totale di 4.500 ettari di cui 1.500 di grani locali e miscugli, (vedi p. 22) per aumentare la biodiversità delle aziende agricole. Sono aziende di piccole e grandi dimensioni, anche molto diverse tra loro: possiamo avere dai 30 ai 300 ettari di terra, ma lavoriamo tutti su uno stesso territorio e pensiamo che le nostre diversità possano essere un punto di forza e unione. Così, il “piccolo” riesce a portare il suo prodotto d’eccellenza nelle nicchie dei mercati locali e dei Gruppi d’acquisto solidali e il “grande” ha la capacità produttiva per soddisfare le richieste più grosse, ma sempre con distributori selezionati. Questa collaborazione ci sta anche permettendo di abbassare i costi, garantendo dei prodotti di eccellenza anche a chi normalmente non può permetterseli.
I 10 vantaggi dei grani antichi
1. Non sono stati coltivati con l’aiuto di fertilizzanti e pesticidi e contribuiscono a difendere la terra e le acque.
2. Proprio perché non hanno bisogno di prodotti chimici e fertilizzanti sono adatti a essere coltivati con metodo biologico.
3. Hanno in media un contenuto maggiore in elementi minerali e antiossidanti rispetto ai grani “modernii”.
4. Sono caratterizzati da una differente “qualità” di glutine, che ha una forza in media inferiore a quella dei grani moderni.
5. Alcune ricerche affermano che il loro consumo ha effetti infiammatori minori rispetto a soggetti sensibili al glutine (non celiaci!).
6. Anche se con rese più basse, aumentano la sicurezza alimentare dei contadini anche grazie alla tecnica dei miscugli.
7. Aumentano la biodiversità in campo e hanno un corredo genetico molto più ricco dei grani moderni.
8. Difendono la cultura del pane tradizionale e locale e della panificazione casalinga e collettiva.
9. Alcuni grani antichi sono anche particolarmente adatti alla panificazione con pasta madre.
10. Il pane e la pasta da grani antichi hanno caratteristiche organolettiche particolari e spesso molto gradevoli al palato.
GRANI TENERI, GRANI DURI E ALTRI GRANI
Proviamo a classificare - sia pure in modo non scientifico - i diversi tipi di grano. La prima distinzione è - potrebbe sembrare banale, ma non lo è - tra grani teneri e grani duri.
Si tratta di due diverse specie vegetali, entrambe della famiglia delle graminacee, genere Triticum: turgidum (o durum) è il grano duro; aestivum quello tenero. Da quest’ultimo si ricava la farina (come vedremo tra poco) più adatta alla panificazione; dalla macinazione del grano duro invece si ottengono farine e semole, più grossolane, utilizzata spesso per la pasta.
Tra i grani teneri ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Il pane fatto a mano
- Indice dei contenuti
- Introduzione. Chi va al mulino s’infarina
- Capitolo 1. La farina del nostro sacco
- Capitolo 2. La pasta madre
- Capitolo 3. Tutte le ricette
- Capitolo 4. Il pane sociale