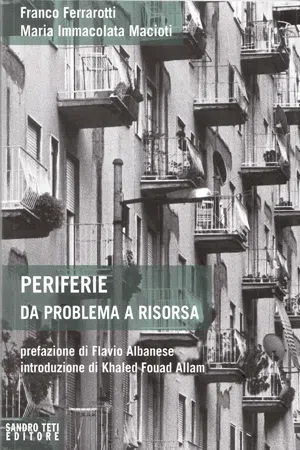![]()
seconda parte
periferie romane tra memoria e possibili futuri
di Maria Immacolata Macioti
![]()
Una premessa metodologica
Sono ormai decenni che nell’ambito della sociologia si discute di storie di vita (biografie raccolte da un ricercatore) e di autobiografie e del loro utilizzo ai fini di una migliore comprensione del reale. Ogni biografia è infatti, in sé, una microstoria: la sociologia ha da tempo aperto un ampio dibattito, su questo approccio, al proprio interno ma anche con psicologi sociali, antropologi, storici.
La biografia di persone “comuni” rappresenta infatti una reazione a una storiografia astratta e ideologizzante, sostanzia letture che privilegiano studi di mentalità, storia dal basso, approfondimenti riguardanti determinati contesti sociali.
Il rapporto storia/sociologia passa attraverso interrogativi su quale tipo di storia, quale tipo di sociologia. Interrogativi difficili, su cui ancora oggi, a tanti anni di distanza dai primi studi in merito [1], dagli studi usciti in Italia, dai primi convegni (tra cui quello dal titolo Biografia, storia e società, tenutosi nella vecchia Facoltà di Magistero in Roma [2]), non vi è unanimità di consensi: in Italia prevale ancora nettamente un approccio statistico-quantitativo. Eppure esistono ormai soprattutto all’estero ma anche in Italia pubblicazioni, insegnamenti, scuole di alta formazione, master sull’approccio qualitativo, in cui la raccolta e l’utilizzo di materiali biografici e autobiografici è centrale. Su piano internazionale poi da tempo si è aperto, all’interno della ISA (International Sociological Association) un comitato di ricerca (RC) denominato Biography and Society, che dà spazio a questo tipo di orientamento, che stimola studi, ricerche, riflessioni che vengono presentate e discusse nei convegni internazionali dell’Associazione.
Tra i sociologi, Franco Ferrarotti è stato certamente uno degli antesignani nel ricorso all’orientamento qualitativo nella ricerca, già in qualche modo adottato nei suoi studi sulle periferie romane, da cui le pubblicazioni Roma da Capitale a periferia e, soprattutto, Vite di baraccati [3] in cui venivano riportati brani di conversazioni registrate in borgata a fine anni Sessanta. Più tardi, pubblicherà, con alcuni suoi collaboratori, Vite di periferia [4].
Non solo: Ferrarotti si è a lungo interessato di dare basi teoriche solide a questo orientamento alla ricerca, interrogandosi sui rapporti tra storia e sociologia in Storia e storie di vita [5], prendendo in esame i temi dei rapporti tra vita quotidiana e rappresentazione sociale, anche in relazione alle esigenze di un nuovo storicismo critico, in grado di forzare i limiti di un razionalismo astratto, ormai poco in grado di dar conto della corposità del reale [6]. Ancora, interrogandosi intorno al tema del tempo, ne Il ricordo e la temporalità [7]: testo che completa una ideale trilogia intesa a meglio fondare studi basati sulla memoria, costituita dal ricordo fondante di esperienze vissute come significative, selezionate dal soggetto in base non solo a un mondo, a un contesto esperienziale individuale ma, secondo lo studioso, comunitario e di gruppo… Esistono, a parere di Ferrarotti, interconnessioni significative delle esperienze temporali vissute, interconnessioni che concorrono a formare una tradizione. I tempi significativi di esperienze personali non sono infatti necessariamente singoli, a sé stanti ma probabilmente assumono significato nella loro interconnessione, nella condivisione da parte di chi si riferisce allo stesso contesto: nel caso delle nostre ricerche ad esempio ci siamo spesso imbattuti in ricordi personali (quando si era conosciuto il Gobbo del Quarticciolo; quando si era avuto il bombardamento su Roma, rovinoso per la zona di San Lorenzo; quando si era determinato il tristemente noto rastrellamento del Quadraro) che erano però, che sono tuttora ricordi condivisi, che hanno formato una partecipata tradizione in certe zone della città.
Esperienze vissute, esperienze ricordate: quelle dalla più lunga vita, quelle che danno significato, sono alla base della sociologia qualitativa proposta da Ferrarotti. Il quale torna ancora su queste tematiche ne La sociologia alla riscoperta della qualità [8], in cui, a partire da un riesame del positivismo, sottolinea la necessità di una scienza sociale non più asettica e distaccata ma consapevole della problematicità del convivere umano, onde evitare un suo sostanziale impoverimento. Non tutti i problemi sono ugualmente importanti, non tutti possono essere affrontati con metodologie standardizzate, che si avvalgono di questionari precodificati, scale di atteggiamento e altri strumenti di questo genere. Naturalmente, spesso il ricercatore deve rispondere alle esigenze di un committente, non sempre ha libertà di scelta riguardo ai temi di indagine, troppo spesso è in qualche modo condizionato dal mercato: ma questo è certamente un forte limite della ricerca stessa, comporta un problema epistemologico di non piccola portata.
Quindi, approccio qualitativo come orientamento non dominante, in sociologia; eppure, decisamente presente e vivace nella disciplina, a livello soprattutto internazionale [9] e soprattutto occasione, causa di dialogo e raffronto tra le scienze sociali.
È stato quindi a partire dalla piena consapevolezza dell’importanza di un approccio qualitativo (ma anche della sua problematicità, delle difficoltà di portare avanti in modo adeguato un’ampia ricerca con questo orientamento) che nel 2006 abbiamo proceduto alla replica degli studi condotta da Franco Ferrarotti a Roma in alcune zone periferiche a fine anni Sessanta: dando vita quindi a una ricerca longitudinale, fatto abbastanza atipico nel panorama italiano. Allora, oggetto di ricerca erano state la borgata Alessandrina, il Quarticciolo, l’Acquedotto Felice. [10]
Nel 2006 si sono prese in esame le zone di allora, per le quali la dizione “borgata” sarebbe oggi certamente impropria: godono di collegamenti con il centro, vedono altre zone al di là del Raccordo anulare, verso i Colli Albani; queste sì, vissute oggi come zone decisamente periferiche. Le aree da noi esaminate si sono del resto trasformate nel tempo, tanto da poter essere considerate zone di insediamenti piccolo e medio borghesi. Anche nel 2006 si è quindi scelto di far ricorso a un orientamento qualitativo: che si è tradotto in osservazione scientifica, in interviste in profondità a testimoni privilegiati e ad abitanti delle tre aree, interviste in cui si lasciava volutamente molto spazio a chi parlava, in confronti tra alcuni intervistati.
La ricerca è stata finanziata dall’Assessorato alle politiche culturali, voluta dall’allora assessore Gianni Borgna. Si proponeva di comprendere e valutare i mutamenti socio-culturali intercorsi, le prevedibili linee future. L’ha condotta il Master Teoria e analisi qualitativa dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza. È stata diretta da Franco Ferrarotti e da me e in questa sede cercherò di dare conto dell’andamento della ricerca: forzatamente, a grandi linee.
Il quadro strutturale
Uno dei primi problemi che ci siamo trovati di fronte riguardava l’individuazione delle zone da studiare. Oggi infatti l’Alessandrino, l’Acquedotto Felice e il Quarticciolo si trovano all’interno di più Municipi, sono aree diversamente estese rispetto a quanto non lo fossero a fine anni Sessanta, quando si trattava di realtà ancora largamente agricole, spopolate: interessano infatti ben quattro municipi, l’XI, il X, il VI e il VII; riguardano i quartieri Tuscolano, (Q VIII), Don Bosco (Q XXIV), Appio Claudio (Q XXV), Alessandrino (Q XXIII) e in piccola parte anche il Prenestino-Centocelle (Q XIX).
Dopo una prima fase di familiarizzazione col terreno, di colloqui preliminari, di interviste con testimoni privilegiati, e dopo aver consegnato un primo stato d’avanzamento dei lavori, mentre discutevamo su come proseguire la ricerca nella seconda e ultima fase, si è proceduto a una verifica delle sezioni di censimento, restringendo il terreno (i tempi erano costrittivi, un rapporto finale avrebbe dovuto essere consegnato entro il dicembre 2006). Barbara Bechelloni e Francesca Colella hanno quindi preso in esame i relativi dati presso l’Anagrafe comunale: se ne è ricavata una mappa delle tre aree, rispondente a confini e appartenenze a fine anni Sessanta, mappa che è stata affissa nella stanza che ha rappresentato il punto di riferimento per tutti i ricercatori e che è stata inviata a coloro che coordinavano i gruppi di ricerca che nel frattempo si erano venuti delineando. E che da allora (cioè dopo la consegna di un primo rapporto provvisorio) ha dato orientamenti più precisi circa le realtà da tenere presenti. Sulla base delle aree di censimento attinenti Francesca Della Ratta ha esaminato più in particolare i dati dell’ultimo censimento, quello del 2001, con riguardo alle tre zone che ci interessavano, comprendenti comunque praticamente il 5% (si tratta del 4,9%) della popolazione romana: sono stati da lei estrapolati e messi a confronto i dati riguardanti le tre aree cui si farà riferimento.
Pur assolutamente convinti della opportunità di procedere a interviste in profondità, è apparso a noi tutti opportuno se non necessario fare una esplorazione delle zone anche su base quantitativa, cercare di avere indicazioni riguardanti aspetti fondanti, strutturali. Ad esempio, sembrava importante saperne di più circa l’agiatezza o la povertà degli abitanti, non avere solo basi impressionistiche in merito, tanto più che ormai è più difficile di quanto non lo fosse un tempo cogliere visivamente le dimensioni della povertà, dopo la scomparsa delle borgate e dei borghetti, strutture che da sé denunciavano la condizione sociale degli abitanti, che versavano troppo spesso in situazioni di assoluta povertà. Sembra infatti più difficile cogliere oggi il fenomeno della povertà relativa, più umbratile, meno esibita.
Ci siamo quindi rivolti all’ISTAT e al Comune stesso, abbiamo chiesto aiuto all’INPS, cui abbiamo fornito i nomi delle vie e i codici di avviamento postale delle zone che ci interessavano. L’INPS ci ha quindi fornito dati riguardanti le pensioni sociali erogate in zona: da cui una prima idea (anche qui, la coincidenza non è perfetta) circa l’esistenza di fasce di povertà, assoluta o relativa, nelle zone prese in esame.
Un’altra fonte che si è utilizzata per avere un quadro di fondo è stata quella della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari): l’indicazione dei prezzi per terreni e case ci è sembrata infatti utile a completare un primo quadro riferito alla struttura della zona.
I testimoni privilegiati: Acquedotto Felice, Alessandrino, Quarticciolo
Intanto, il gruppo di ricerca cercava di acclimatarsi con l’area in questione, un’area comunque molto vasta. Per qualche mese i ricercatori hanno fatto passeggiate in zona, parlando con le persone del luogo, informandosi circa l’esistenza e la consistenza di luoghi di raduno, negozi, mercati; ma anche di centri anziani, parrocchie e chiese. Hanno cercato di capire quali fossero (e se esistessero) i luoghi più frequentati dagli anziani e dai giovani. Si è cercato cioè di fare osservazione partecipando nel contempo, per quanto possibile, alla vita del luogo. Si è trattato di una fase preliminare di orientamento, che ci ha permesso di procedere con la scelta di testimoni privilegiati: persone cioè che vivevano lì da molto tempo, in grado quindi di raccontare non solo di sé ma anche dei mutamenti occorsi nel tessuto sociale, di tante vicende vissute dagli abitanti.
Intanto alcuni ricercatori avevano incontrato Ferrarotti per discutere con lui dei temi da affrontare e di come condurre le interviste. Altri incontri sono stati programmati lungo l’arco dei primi mesi per discutere con tutto il gruppo dei più stretti collaboratori le prime interviste fatte, le difficoltà che si erano incontrate, il modo di procedere. Sia Giovanna Gianturco che io stessa abbiamo letto le interviste, man mano che arrivavano le sbobinature, per far rilevare approfondimenti possibili, argomenti ancora non esplorati eppure prevedibilmente utili. Per notare interruzioni, bruschi passaggi da un argomento all’altro, domande che rivelavano scarsa attenzione da parte del ricercatore e così via. L’approccio qualitativo è infatti indubbiamente di difficile applicazione, richiede capacità ma anche sensibilità e disponibilità verso l’altro. I risultati però, se tutto procede bene, sono in genere più proficui di quanto non accada con l’applicazione di tecniche quantitative, poiché si va più in profondità e chi parla ha maggiori possibilità di spiegarsi, di proporre argomenti che giudica interessanti.
I ricercatori erano tutti già laureati; alcuni erano, come si è accennato, studenti di un Master specificamente rivolto alla ricerca qualitativa; altri avevano anche conseguito un Dottorato in Teoria e ricerca sociale o erano dottorandi: tutti quindi già avevano letto una ampia mole di studi e riflessioni sull’approccio qualitativo, studiato ricerche condotte sulla base di premesse del genere.
Ma, come sempre, la teoria è una cosa e la realtà è un’altra. Chi aveva già esperienze di ricerca, aveva condotto inchieste statistico-quantitative, basate su questionari predisposti: si è trattato delle persone che hanno incontrato maggiori difficoltà, proprio perché inizialmente convinte di saper condurre bene una intervista, di non aver bisogno di ulteriori suggerimenti.
Ci eravamo posti come finalità quella di avere per ognuno dei tre quartieri venti interviste in profondità (per arrivarvi, le interviste sono state ben più numerose), registrate e trascritte con una attenzione sostanziale ai contenuti e, per quanto possibile, ai modi espressivi dei soggetti che erano protagonisti dell’intervista, per ogni zona.
Facevamo intanto anche incontri e dibattiti sulla trascrizione, che rappresenta sempre un momento significativo e nodale. Di comune accordo, il gruppo di ricerca ha deciso di lasciare le eventuali espressioni dialettali (si trattava di un “romano” un po’ rielaborato, dato che molti dei protagonisti erano immigrati a Roma vari decenni or sono dal sud d’Italia), alleggerendo tuttavia il parlato di eventuali ripetizioni che appesantivano troppo il testo e di interiezioni tipiche dell’oralità [11]. Interventi, questi ultimi, di regola comunque segnalati (con tre puntini tra parentesi, laddove si saltavano alcune parole; in corsivo e tra parentesi, laddove si sono aggiunte poche parole esplicative da parte del ricercatore o dell’estensore del testo scritto). Si è suggerito di fare riferimento, per le trascrizioni, al Dizionar...