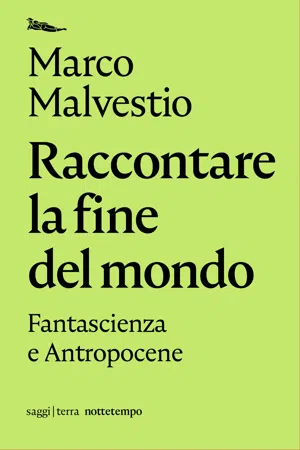![]()
1. L’era dell’atomo
Il 6 agosto 1945, un Boeing B-29 Superfortress chiamato Enola Gay, in omaggio al nome della madre del pilota, sganciò una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima, causando la morte di decine di migliaia di persone e radendo al suolo la città. Dei 255.000 abitanti, 66.000 perirono e 69.000 rimasero feriti; 60.000 dei 90.000 edifici della città vennero distrutti o gravemente danneggiati, e così gran parte dell’impianto idrico. Tre giorni dopo, il 9 agosto, l’esercito americano sganciò un altro ordigno nucleare su Nagasaki, causando 39.000 morti e 25.000 feriti (su 195.000 abitanti), oltre che la distruzione di 20.000 edifici su 50.0001. La pelle dei feriti era nera di scottature, i loro capelli scomparsi, bruciati dal fuoco; i cadaveri erano irriconoscibili, e molti (quelli più vicini al punto di detonazione) vennero semplicemente spazzati via dall’energia della bomba. Sia a Hiroshima che a Nagasaki, entro la fine dell’anno, il numero di morti avrebbe poi raggiunto i 140.000 per città, a causa delle ferite e delle radiazioni2.
Letto cursoriamente, il resoconto di questi fatti può anche sembrare poco interessante: la storia del Novecento, e in particolare quella della Seconda Guerra Mondiale, abitua presto alle cifre mastodontiche dei massacri. Non molto tempo prima, il 10 marzo 1945, lo stesso esercito americano aveva colpito Tokyo con delle bombe incendiarie causando quasi 100.000 morti: il maggior numero di vittime nella storia in un singolo raid aereo, anche più di quelli delle bombe atomiche. C’è una differenza, però, ed è il motivo per cui vale la pena riportare le cifre esatte: i morti di Hiroshima e Nagasaki non sono stati causati da un raid aereo (quello di Tokyo è stato compiuto da più di 300 bombardieri), ma da due singole bombe.
La novità senza precedenti di Hiroshima e Nagasaki non riguarda la mera contabilità delle vittime, ma semmai il tipo di potenza che l’uomo è stato in grado di sprigionare, pari a 20.000 tonnellate di dinamite: per trasportarle ci sarebbero voluti almeno 2000 aeroplani. La forza di questa bomba “era come quella del sole stesso. Era il potere elementare dell’universo, un’arma distruttiva senza precedenti, che annunciava una nuova era rivoluzionaria nell’arte della guerra e nella tecnologia”3.
Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki sono state le prime conosciute dal grande pubblico, ma non le prime a essere fatte detonare: il 16 luglio 1945 ebbe infatti luogo ad Alamogordo, New Mexico, il Trinity Test – la prova della nuova arma che rappresentava il culmine del Manhattan Project, un progetto di ricerca pluriennale che coinvolse centocinquantamila persone e il cui costo arrivò alla cifra di quasi due miliardi di dollari dell’epoca4.
In un articolo del 2015, Jan Zalasiewicz e il suo team di ricerca hanno proposto come data di inizio dell’Antropocene proprio “il momento della detonazione della bomba atomica Trinity […] alle 05:29:21” del 16 luglio 19455. L’esperimento Trinity segna il momento a partire dal quale è pienamente rilevabile, a livello stratigrafico, la presenza massiccia di radionuclidi artificiali, nello specifico del carbonio-14: un segnale immediatamente percepibile, in altre parole, del peso della specie umana come forza geologica. La presenza di carbonio-14 tocca il suo massimo grado dopo il 1963, l’anno della messa al bando internazionale dei test di superficie, in cui arriva al 190% in più rispetto ai livelli del 1950 – “picchi di 14C sono stati documentati in carote di ghiaccio, anelli di accrescimento degli alberi, coralli, stalagmiti e stalattiti delle grotte e sedimenti delle saline”6.
Tuttavia non è solo la quantità di radioattività sprigionata dalla bomba atomica, evento prodigioso che presiede all’avvio della Grande Accelerazione, a segnalarla come snodo cruciale dell’Antropocene: è anche il fatto che, per la prima volta (e ancora di più con le bombe all’idrogeno sviluppate a partire dal decennio successivo), la specie umana si trova davanti a un fenomeno, e per di più un fenomeno di origine esclusivamente antropica, in grado di spazzarla via completamente. Ogni catastrofe che l’uomo ha affrontato nel corso dei secoli, ogni pandemia, ogni terremoto, ogni eruzione vulcanica, ogni guerra ha significato perdite tragiche, talvolta persino il tracollo di alcune civiltà, ma mai un rischio per la sopravvivenza stessa dell’umanità. L’energia atomica, in altre parole, mette in risalto la doppia natura, distruttrice e creatrice, dell’ingegno umano, che caratterizza l’Antropocene.
L’energia atomica, nei suoi usi positivi e distruttivi, ha modellato l’assetto geopolitico della seconda metà del Novecento7. La strana forma del conflitto che ha determinato per quasi cinquant’anni gli equilibri globali – la Guerra Fredda, ovvero un conflitto costante ma mai combattuto direttamente dalle nazioni in questione – è stata resa possibile proprio dal deterrente atomico, dal fatto cioè che entrambe le potenze erano in possesso di un arsenale nucleare in grado di annientare completamente l’altra. La mutua distruzione assicurata (Mutual Assured Destruction, il cui acronimo, piuttosto eloquente in inglese, è MAD) ha garantito oltre mezzo secolo di paradossale pace ai paesi dell’Occidente, e delocalizzato i conflitti militari in altre zone del pianeta.
Non c’è da stupirsi, dunque, se l’atomica ha anche colonizzato quasi immediatamente l’immaginario occidentale, ora come futuribile fonte di energia senza fine, ora come incubo di fine del mondo8. L’iniziale entusiasmo per l’atomica americana (che in fin dei conti, secondo i suoi promotori, risparmiò una costosissima e sanguinosissima invasione del suolo giapponese) si tramutò presto nell’ansia per un conflitto, quello nucleare, che non aveva precedenti per capacità distruttiva e che nel 1957, col lancio della campagna satellitare sovietica, e nel 1962, con la crisi dei missili di Cuba, rischiò di tramutarsi in realtà.
La guerra nucleare è stata, per tutto il Ventesimo secolo, una prospettiva concreta, e anche se oggi si parla sempre meno di bomba atomica e la tensione tra Russia e Stati Uniti non è ai livelli di metà Novecento, gli arsenali nucleari continuano a esistere, e il loro potenziale distruttivo resta intatto. Che fosse tematizzata esplicitamente o meno, l’atomica, e con essa la possibilità realistica dell’annientamento dell’uomo per mano dell’uomo, ha rappresentato una presenza costante nel dibattito pubblico e nell’immaginario letterario e cinematografico. Come ha scritto Martin Amis nel suo appassionato saggio “Pensabilità”, “un uomo con una pistola senza sicura puntata in bocca può vantarsi di non pensare mai alla pistola senza sicura. Ma la assapora, in continuazione”9.
La psicosi della bomba è ben rappresentata da un celebre racconto di James Graham Ballard, “La spiaggia terminale” (1964). All’epoca, Ballard era l’esponente più noto di quella new wave che negli anni sessanta e settanta ha riportato l’attenzione della fantascienza dalle distese disabitate del cosmo all’interiorità umana: che ha spostato l’accento, in altre parole, dalla space opera e dai toni del romanzo d’avventura a generi più riflessivi e impegnati, come la distopia o il romanzo post-apocalittico, aprendo le porte alla successiva ondata cyberpunk. “La spiaggia terminale” intercetta proprio questa intuizione: la bomba e il paesaggio atomizzato come spazi interiori.
In un mondo post-atomico, dopo una Terza Guerra Mondiale, il protagonista del racconto, Traven, si reca su un’isola del Pacifico utilizzata per esperimenti nucleari. Traven, che non riesce a superare la morte della moglie e del figlio, vive in questo paesaggio stravolto in preda a continue allucinazioni. “Quest’isola è uno stato mentale”10, gli dice uno degli scienziati che ancora la popolano: un paesaggio devastato, fatto di bunker in rovina e relitti di aerei (nello specifico di un Boeing Superfortress, lo stesso modello usato per bombardare Hiroshima e Nagasaki), in cui l’esplosione nucleare ha fuso la sabbia, e dove non ci sono che elementi di origine antropica – torri, fortificazioni, casematte. “Se l’uomo primitivo sentiva il bisogno di assimilare gli eventi verificatisi nel mondo esterno alla sua psiche individuale”, scrive Ballard, “l’uomo del Ventesimo secolo aveva invertito la tendenza”11.
In questo paesaggio stravolto, come si confà a una vera e propria ghost-story dell’era atomica, Traven ora vede apparirgli le immagini della moglie e del figlio, ora conversa col cadavere di un giapponese; allo stesso tempo, comincia a mostrarglisi una bambina adocchiata in una foto. Se siamo portati a pensare, con la geologia, che il presente sia utile per investigare il passato, nell’isola “la chiave del presente risiedeva nel futuro. L’isola era un resto fossile del tempo futuro, i suoi bunker e le casematte illustravano il principio secondo il quale il reperto fossile della vita era fatto di corazze ed esoscheletri”12. L’isola di Traven è un mausoleo del presente, in cui la tecnologia compare solo come testimonianza di qualcosa che avrebbe potuto essere, e non come possibilità per il futuro – gli aerei non possono più volare, i bunker non hanno più alcuna funzione precisa. Questo paesaggio sintetico, intrinsecamente modificato dall’opera dell’uomo fin nelle sue più minime parti, testimonia l’impatto dell’uomo sulla natura nell’Antropocene, e il crollo della distinzione, nell’immaginario, tra natura e cultura.
Come sempre accade, è nella cultura di massa che si intravedono i primi e più massicci segni di penetrazione dell’energia atomica nell’immaginario. Ma che forme prende, effettivamente, la paura del nucleare? La prima e più importante immagine legata alla bomba è quella del fungo atomico: il segno tangibile della potenza dell’ordigno. Se le fantasie di fine del mondo caratterizzano l’immaginario da sempre, i racconti apocalittici dell’era atomica sono inquietantemente radicati nel reale. L’ansia che nascondono i romanzi e i film in cui la bomba, intenzionalmente o per errore, spazza via la razza umana non è quella del cautionary tale, ma quella della possibilità pienamente realizzabile.
Questa preoccupazione è ben presente in Addio Babilonia di Pat Frank, pubblicato nel 1959. Tra i primi, e i più fortunati, romanzi del dopo-bomba, Addio Babilonia racconta le conseguenze di un attacco atomico agli Stati Uniti, focalizzandosi sul microcosmo di una piccola cittadina della Florida, Fort Repose. Frank ricostruisce nel dettaglio quelli che potrebbero essere gli effetti di una vera guerra atomica, ponendo l’accento sugli aspetti pratici che una dissoluzione delle strutture organizzative dello stato moderno comporterebbe. Dopo che Washington viene attaccata e il governo degli Stati Uniti sterminato, e dopo che Fort Repose viene tagliata fuori dal resto della Florida, le banche non servono più a nulla e si torna al baratto (il direttore della banca locale, incapace di immaginare un mondo senza denaro, si uccide); i cittadini devono organizzare una milizia di fortuna; non c’è più elettricità, e bisogna tornare a conservare gli alimenti sotto sale. Uno alla volta, tutti i generi alimentari e di consumo per cui si dipendeva da un approvvigionamento esterno cominciano a scarseggiare – da quelli tutto sommato superflui come la schiuma da barba, a quelli essenziali, come l’insulina per i diabetici.
Il titolo del romanzo viene dall’Apocalisse: “Guai, guai, immensa città, Babilonia, possente città; in un’ora sola è giunta la tua condanna!” (18:10). Coerentemente con il riferimento biblico, Addio Babilonia pone l’accento sulla necessità di una redenzione morale, facendo subire ai personaggi negativi un contrappasso per le loro azioni (chi ha saccheggiato le case e rubato la gioielleria poi muore perché i gioielli stessi erano contaminati dalle radiazioni), e costringendo il protagonista, Randy, a redimersi. Se all’inizio del romanzo Randy è uno scapolo svogliato e con una certa tendenza all’alcolismo, dopo la bomba smette di bere, si attiva per organizzare la comunità, si fa carico della moglie e dei figli del fratello defunto, e infine si sposa.
Forse il dato più interessante di Addio Babilonia, che è uno dei primi testi a elaborare questo punto, è la velocità con cui avviene il collasso; per tutto il romanzo, alla guerra viene fatto riferimento semplicemente come a “il Giorno”: “sembrava incongruo chiamare ‘il Giorno’ una guerra – la Guerra russo-americana, Oriente-Occidente, o Terza Guerra Mondiale – perché la guerra, in realtà, era finita in un giorno”13. Soprattutto, si tratta di una guerra che porta distruzione totale senza che la popolazione veda effettivamente combattimenti o scontri aperti. Immaginare il conflitto atomico, nella fantascienza di quegli anni, significa immaginare qualcosa di totale e insieme di invisibile: qualcosa di infinitamente più grande del singolo essere umano e su cui, come su una punizione divina, sembra impossibile esercitare qualsiasi controllo.
Un elemento ricorrente, nelle fantasie post-atomiche, è l’assenza: i paesaggi urbani consueti, solitamente affollati di genti e merci, sono deserti; i simboli e i ritmi del consumismo occidentale sono svuotati di senso. Le immagini di supermercati senza più prodotti, di zone residenziali senza più abitanti e di case invase dalla vegetazione fanno parte del repertorio di qualsiasi romanzo o film post-apocalittico, ma sono particolarmente appropriate quando si parla di energia atomica. Del resto, le evacuazioni di Hiroshima e Nagasaki, e poi di Černobyl’ e Fukushima, sono tutto fuorché fantasie: i dintorni di Černobyl’ restano inabitabili ancora oggi.
Poche opere sono state in grado di raccontare questa assenza come il racconto “Cadrà dolce la pioggia” di Ray Bradbury, contenuto in Cronache marziane (1950), una delle opere cardine della fantascienza del secolo scorso. Siamo nel 2026, in un futuro post-atomico: ad Allendale, California, la casa automatizzata che in passato è stata la residenza della famiglia McClellan continua a operare come se nulla fosse. Il racconto, completamente privo di agenti umani, segue le azioni ripetitive e meccaniche della casa, dalla sveglia alla preparazione dei pasti, dalla pulizia all’intrattenimento. Quando la scena si sposta all’esterno e la casa cura il giardino, ci viene rivelato che un’esplosione atomica ha spazzato via il resto della città, e che della famiglia McClellan non restano che le ombre stampate sul muro dal fuoco della bomba:
Dieci e un quarto. Gli spruzzi d’acqua, sul prato del giardino, s’accrebbero vorticosi fino a diventare auree fontane, ricolmanti la molle atmosfera mattutina di scintillanti riflessi. L’acqua irrorò i vetri delle finestre, scorrendo poi lungo il lato di ponente, calcinato, là dove la parete della casa era stata privata dal fuoco d’ogni traccia di vernice. Tutto il lato di ponente della casa era nero, meno cinque punti: là dove si vedeva la sagoma dipinta di un uomo intento a sarchiare un prato. Dove, come in una fotografia, una donna era china a cogliere fiori. Più lontano (le immagini erano bruciate sul legno in un solo titanico istante), un bambino, le braccia alzate verso la palla che aveva lanciato, e dinanzi al bambino una fanciulla, lei pure con le mani alzate, per prendere la palla, che non sarebbe scesa mai14.
Questa immagine spaventosa e rivelatrice, che d’improvviso rende manifesto il destino della famiglia che abitava la casa, non è un’invenzione di Bradbury: dopo le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, molti documentarono le tracce umane lasciate dalla detonazione. Eiichi Matsumoto, in una celebre fotografia scattata durante un reportage nel dopo-bomba, ritrae una scala e una figura umana stampate sulla parete in legno di una casa. Questa foto, come le silhouette di Bradbury, letteralmente negativi fotografici, rappresenta un fenomeno paradossale, che contraddice le leggi della fisica per come ne facciamo esperienza tutti i giorni: le ombre, che per definizione non possono esistere senza qualcuno o qualcosa che le proietti, sopravvivono al corpo anche quando il corpo ha cessato per sempre di esistere.
I segni dell’uomo però, un poco alla volta, scompaiono tutti: ed è anche il destino della casa, distrutta da un incendio dopo che il ramo di un albero, spinto dal vento, rompe una finestra e sparge del solvente sui fornelli. La casa è avvolta dalle fiamme, e non ne rimane che una parete – quella che contiene il sistema di comunicazione, che continua a ripetere incessantemente la data del giorno.
Nel momento in cui viene utilizzata, la bomba, apice della tecnica umana, disintegra la separazione tra natura e cultura e simultaneamente svuota di significato le opere dell’uomo. Come l’isola di Ballard, anche la casa di Bradbury è uno spazio eminentemente spettrale: dove, cioè, i residui di una civiltà precedente sopravvivono in forma di fantasmi senza pace. La condanna alla coazione senza senso della tecnologia abitativa della casa di Allendale è un monito contro i rischi dell’attivismo e del volontarismo umano dell’Antropocene, e il lusso dell’abitazione senza più nessuno a poterla abitare incarna la duplice natura, promettente e disperante, dell’energia nucleare.
La radicale ambivalenza dell’energia atomica (la sua utilità e la sua incredibile pericolosità) non è limitata ai suoi usi bellici, ma si estende anche a quelli civili. In tempi recenti abbiamo avuto due enormi catastrofi, quella di Černobyl’ (1986) e quella di Fukushima (2011). Gli incidenti hanno causato vaste contaminazioni e costretto gli abitanti ad abbandonare le loro case e i loro paesi, anche se il numero diretto delle vittime è certo più contenuto di quello seguito alle bombe: per l’esplosione a Černobyl’ si parla di un centinaio di persone morte direttamente (ma il numero dei morti per effetti collaterali negli anni successivi varia di molte migliaia a seconda delle stime).
Il pericolo per la salute causato dalle radiazioni, che sono in grado di uccidere le cellule e di modificare il DNA provocando tumori, è uno dei principali elementi dell’immaginario nucleare. La paura delle radiazioni, nella fantascienza post-apocalittica dell’era atomica, prende due forme: quella di una morte silenziosa, a cui non è possibile sfuggire, e quella della mutazione.
Un’esplosio...