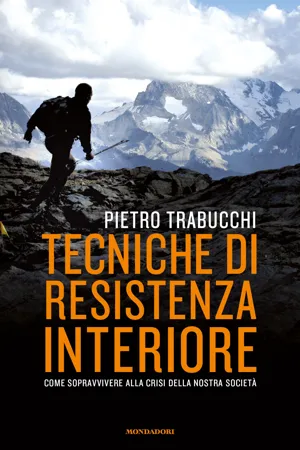Come dice un detto zen, «Nessuno aprirà la porta al tuo posto». Il che, tradotto in un linguaggio pratico, significa ribadire che aspettarsi che la realtà cambi da sola è illusorio: devi prenderti la responsabilità della tua vita e cambiare tu per primo. È quindi venuto il momento di tradurre tutta la teoria delle pagine precedenti in una prassi capace di farci recuperare le risorse che ardono ancora sotto la cenere di abitudini scorrette e disattenzione. Ciascuno di noi, infatti, possiede dentro di sé molte più risorse di quanto pensi, nonostante la pressione sociale a farci credere il contrario.
Questo spero di essere riuscito a dimostrarlo senza ricorrere a sensazionalismi retorici o a qualche forma di suggestione carismatica, ma facendo leva su modelli e dati scientifici. Nella nostra specie la resilienza rappresenta la norma, non l’eccezione. Essere resilienti non è una questione da Rambo, da invasati dei corsi di sopravvivenza o da esteti del muscolo ipertrofico: è una caratteristica intrinsecamente umana. Forse – considerando quanto abbiamo osservato in merito allo sviluppo motivazionale della nostra specie – è l’attitudine umana per eccellenza: si tratta della capacità di affrontare difficoltà complesse e di adattarsi al cambiamento senza smarrire la spinta motivazionale. Essa ha permesso la sopravvivenza degli ominidi a partire dai cambiamenti climatici che estesero le savane due milioni di anni fa.
Oggi si parla molto di stress, spesso a sproposito. Entro certi limiti, noi siamo fatti per gestire lo stress. Anzi, in qualche modo abbiamo addirittura bisogno dello stress. Senza richieste da parte dell’ambiente – problemi da risolvere, difficoltà da affrontare, obiettivi da raggiungere – il nostro cervello si atrofizza. I nuovi neuroni non sopravvivono se non sono stimolati sufficientemente. Certo, occorrono un livello di sfida ottimale e obiettivi appropriati: ma la nostra vocazione evolutiva non sta nel divano di casa, né nell’adorazione del tubo catodico.
È vero, oggi molte persone si sentono stressate. Ma non perché le condizioni di vita odierna, crisi permanente compresa, siano più difficili che nel passato (per lo meno nell’Occidente post-industriale). Malattie, fame, violenza indiscriminata, migrazioni hanno rappresentato lo scenario quotidiano per millenni. Solo qualche secolo fa (la durata di un sospiro se si considera il tempo sulla Terra degli ominidi) non esistevano ospedali e antibiotici, né diritti umani, né fognature, né il concetto stesso di infanzia o prerogative per la donna.
È davvero difficile sostenere che oggi le condizioni di vita siano – in generale – peggiori. È vero che le persone si sentono stressate, ma questo è dovuto in gran parte al fatto che le capacità di reazione sono scomparse. La resilienza oggi è, in termini collettivi, indebolita. Tuttavia, messe alle strette e prese singolarmente, le persone sono capaci di recuperare le risorse e di sconfiggere i fantasmi che li sabotavano da dentro. Questo da sempre, anche nei momenti di maggior benessere collettivo: chi fa la fame, o chi soffre per qualche motivo, prima o poi riesce a tirare fuori la propria resilienza. Ma anche chi non è stato costretto dagli eventi ad allenare la propria resistenza interiore oggi deve compiere uno sforzo in tal senso. Altrimenti farà la fine della rana bollita, che non si accorge che l’ambiente sta drammaticamente cambiando. E quando lo fa è troppo tardi per sviluppare qualsiasi capacità di adattamento.
Allenare e far crescere le risorse interiori è una disciplina. Intendo dire che si concretizza in un insieme di azioni pratiche che richiedono impegno ed esercizio costante. Non è qualcosa che si risolve solo a livello speculativo, imparando un po’ di nozioni teoriche. La teoria del libro non basta. Bisogna essere disposti a mettersi lì e a praticare. Bastasse aver letto per cambiare, si tratterebbe di un processo magico: ebbene, mettetevi il cuore in pace, non lo è.
Ai fini di potenziare le risorse interne, cambiare stile di vita è molto più efficace che circoscrivere il cambiamento all’adozione di una qualche forma di tabella di allenamento. Per questa ragione non vi proporrò un programma di allenamento vero e proprio, ma solo una serie di idee: troverete di seguito un mix di stimoli che raccolgono elementi derivanti dalla psicologia cognitiva, dalle tecniche corporee, dalla mindfulness, dall’allenamento sportivo, dalla metodologia dell’esercizio e dalle neuroscienze.
Arrivare a integrare questi elementi nella propria vita reale personalizzandoli costa fatica: ma porta a un risultato molto più efficace che mutuare passivamente un programma standard già fatto e seguirlo in modo pedestre. La resilienza va allenata a partire dal contesto quotidiano, dalle pratiche di vita ordinarie, dalla nostra vita normale. Solo così è davvero utile.
Poi esistono applicazioni specifiche allo sport per sviluppare la resilienza che hanno una forma più vicina ai programmi di allenamento e sono molto interessanti. Ma qui ne accenneremo soltanto.
Tenere a bada gli auto-sabotatori
I nostri pensieri e le nostre credenze sulla realtà non coincidono mai del tutto con gli eventi reali. Esiste sempre un margine di errore, un certo livello di distorsione. Quando l’errore diventa sistematico e notevoli le dimensioni della distorsione, ci troviamo in presenza di quelle che, in termini tecnici, vengono definite «deformazioni della valutazione cognitiva». Io preferisco chiamarli «auto-sabotatori», cioè modi di farsi del male da soli. Non solo gli auto-sabotatori sono un fenomeno reale, ma producono anche effetti tangibili sulla motivazione e sui comportamenti; sono infatti alla base di tutti quegli atteggiamenti che minano la resilienza individuale.
Alcuni auto-sabotatori originano dalle vicende individuali della persona e vengono appresi nel corso della sua vita:1 l’atteggiamento pessimistico, per esempio, è il risultato di due trappole cognitive costanti che il soggetto ha appreso fin dalla più tenera infanzia. Una viene definita «permanenza» e consiste nella convinzione che i propri fallimenti, le proprie incapacità o l’effetto degli eventi negativi abbiano una durata temporale illimitata. Un ragazzino prende un brutto voto a scuola: questo è l’evento negativo reale. Se all’evento concreto lui accompagna anche il pensiero «Non ci riuscirò mai», il nostro amico ha aggiunto una distorsione che non esiste nei fatti oggettivi: la convinzione che prenderà sempre brutti voti. Questa distorsione non è neutra, perché condiziona i suoi comportamenti futuri: per esempio, demotivandolo dallo studiare di più (vi ricordate? Se il soggetto è convinto che il suo sforzo non otterrà effetti, tende a rinunciare). L’altra distorsione tipica dei pessimisti è la «pervasività», cioè la costante generalizzazione – del tutto arbitraria – delle caratteristiche negative personali. Infatti, tornando all’esempio di prima, un conto è dire «Non sono forte in matematica», un’altra cosa è affermare, sulla base di quell’unico voto negativo: «A scuola sono una frana» o, addirittura, «Sono un incapace».
È quindi bene ricordare di nuovo che gli auto-sabotatori sono modi di farsi del male perché determinano un effetto pratico sui nostri comportamenti: possono demotivarci dall’impegnarci in qualcosa, oppure farci evitare delle situazioni interessanti o farci rinunciare a degli obiettivi.
Anche se molte delle trappole cognitive hanno origine nella storia individuale dei soggetti, molte altre hanno invece radici culturali. Sono quelle che ci interessano di più e che esamineremo qui; l’obiettivo di questa breve carrellata è quello di sviluppare consapevolezza nei loro confronti, per prevenirne gli effetti nefasti sul comportamento. Cominciamo a esaminare la trappola cognitiva del «si può e si deve evitare ogni forma di disagio».
Essere resilienti non significa che una persona non sperimenti difficoltà o sofferenza. Anzi, proprio il fatto di crederlo rappresenta una trappola cognitiva che ci rende più deboli. Una delle caratteristiche mentali delle persone molto resilienti è il fatto di vedere il disagio come parte del gioco che si sta giocando. Mi spiego: come abbiamo visto, la nostra cultura è permeata dall’imperativo che si possa e debba sfuggire qualsiasi stato di disagio. Tuttavia questa pretesa non è sempre realizzabile.
Quando dunque la sofferenza giunge, molti cadono nella trappola cognitiva del «non è giusto!» perché inconsapevolmente coltivavano l’aspettativa che «ciò non DEVE capitare» o che l’universo funzioni in modo intrinsecamente equo. Tali pensieri rappresentano in maniera evidente degli auto-sabotatori: sono aspettative destinate a essere costantemente deluse dai fatti, e quindi generatrici di frustrazione.
Questo approccio comporta che alla sofferenza causata dagli eventi reali si sommi quella derivante dalla non-accettazione della situazione. A volte questa sofferenza aggiuntiva diventa altrettanto dolorosa di quella originaria. Le persone molto resilienti, da un punto di vista cognitivo, «vedono» il disagio come «parte del gioco», cioè sono capaci di accettarlo. Nella nostra cultura la parola «accettazione» possiede una connotazione spesso negativa, perché viene associata al cedimento, alla debolezza, alla rassegnazione. «Accettare», in questo frangente, significa semplicemente evitare il vittimismo e la sofferenza aggiuntiva che esso comporta. «Accettare» non presuppone che la tua situazione ti piaccia; vuole soltanto significare che hai compreso che infuriarti, maledire il genere umano, minacciare ritorsioni all’intero universo non cambia la tua situazione e crea solo un ulteriore prelievo dalle tue riserve metaboliche. Non ti resta che conservare tutta l’energia possibile per rimboccarti le maniche e metterti a lavorare per risolvere la situazione.
Infine, «accettare» vuole dire anche saper stare in contatto con la sofferenza. Anche con quella emotiva, non solo quella fisica. Oggi abbiamo la pretesa di poter cambiare stato d’animo non appena avvertiamo sensazioni negative, quasi come si cambia canale alla televisione se il progamma che stiamo vedendo non ci piace.
L’illusione dello zapping emotivo ci deruba di un aspetto molto positivo che, paradossalmente, le emozioni negative possiedono. Cercando di fuggire dagli stati d’animo sgradevoli, non ne cogliamo l’utilità profonda. Se non ce ne siamo sbarazzati in millenni di evoluzione un motivo ci deve pur essere: le emozioni negative, infatti, non sono inutili. Paura, ansia, tristezza, rabbia ci avvertono che qualcosa non va. Ci forniscono la motivazione, e spesso anche la spinta fisica, a muoverci per uscire da situazioni indesiderabili, o per trovare delle soluzioni. Perfino la tristezza ha questo significato. Dunque, le emozioni definite (forse un po’ frettolosamente) «negative» non vanno evitate o assopite con i farmaci: vanno ascoltate. Al contrario, se evitiamo sempre di ascoltarle, finiremo per rispondere in modo inopportuno alle difficoltà che la vita quotidiana ci presenta.
Esiste poi un’altra credenza fuorviante: il mito del «talento». A questo proposito non abbiamo contestato l’esistenza di predisposizioni e attitudini negli esseri umani, fatto per altro innegabile. Piuttosto abbiamo criticato – per il suo impatto sui comportamenti reali – la convinzione che la riuscita in qualsiasi attività umana sia frutto del possesso gratuito di abilità innate: il «dono del talento». Abbiamo visto che le predisposizioni hanno bisogno di un’enorme quantità di impegno ed esercizio per trasformarsi in eccellenza concreta. Ma anche che credere, al contrario, che tutto si riduca alla questione di possedere o non possedere talento, in fondo fa comodo. Perché libera dalla responsabilità della mancata riuscita, fornendo un solido alibi. La trappola cognitiva del talento va ribaltata concettualmente: non è che faccio una cosa solo se ci sono portato. Il pensiero deve diventare: la faccio, allora «portato» ci divento.
Bonificare l’ambiente attentivo
Uno dei primi passi per accrescere la resilienza consiste nell’eliminare i fattori che ne erodono lo sviluppo. Abbiamo parlato a lungo, nei capitoli precedenti, degli effetti delle tecnologie digitali. Ora, la pretesa di eliminarle dalla nostra vita rappresenta un’illusione. Quello che possiamo realisticamente fare è:
- rendere meno passivizzante e più consapevole il rapporto con queste tecnologie;
- limitarne l’uso, cioè fare attenzione ai rischi mentali di essere perennemente connessi altrove;
- toglierci alcune illusioni, come quella del multitasking.
I media digitali possiedono la caratteristica di passivizzare l’utente. Quanto più la loro fruizione viene resa attiva e intenzionale, minori saranno i danni che essi producono su cervello e attenzione. C’è una bella differenza, per esempio, tra un ascolto passivo della televisione, inteso come sottofondo di altre attività come mangiare, o riempire la noia del tempo libero, e un utilizzo più attivo come scegliere in modo premeditato un film, vederlo, e poi magari discuterci sopra. Nel primo caso l’attenzione non può essere focalizzata e diretta perché manca a priori la scelta di cosa sia rilevante e cosa non lo sia. In una situazione del genere le aree prefrontali si abituano a rinunciare a esercitare le loro prerogative. Si potrebbe dire che imparano ad «andare in letargo».
Le occasioni e i modi per aumentare la fruizione attiva e intenzionale dei media digitali sono veramente tante: un altro campo, per esempio, dopo l’intrattenimento, è quello dell’informazione. Si può ricevere l’informazione in forma più inerte e predigerita, come attraverso il format dei telegiornali; oppure possiamo scegliere di cercare attivamente le notizie sul web, magari diversificando quotidianamente le fonti, la scala (da locale a planetaria) e la lingua dei notiziari. Possiamo alternare l’utilizzo di giornali digitali e quotidiani cartacei: la scrittura nei primi è molto più povera e sintetica. I secondi usano un linguaggio più ricco e livelli diversi di approfondimento ed elaborazione dei contenuti. Insegnare alle nuove generazioni a usufruire di entrambe le fonti significa abituare il loro cervello a usare più codici di elaborazione della realtà. Da un punto di vista degli effetti cognitivi, l’impiego di Internet stimola il pensiero associativo: l’utente apre «finestre» e passa da un contenuto all’altro seguendo una logica che non è quella sequenziale del testo scritto. Il pensiero associativo è meno intenzionale ed è legato a un ordine creativo personale. Senza voler stabilire una gerarchia tra forme di pensiero, ma utilizzando esclusivamente un punto di vista neurofisiologico, va sottolineato che durante lo sforzo sequenziale il controllo dell’attenzione è molto più forte e le aree prefrontali sono più attivate. Detto in parole povere, va bene navigare su Internet, ma ogni tanto stimolate nei vostri figli la lettura di un libro (cartaceo o digitale): dal punto di vista del cervello sarà come fare un bell’esercizio di meditazione e di autodisciplina.
Radicarsi nel corpo, rientrare in contatto con la realtà
Molte persone trascorrono gran parte del tempo della loro vita in posti che non si trovano nel «qui e ora». Possono essere imprigionate in un mondo di pensieri e di immagini mentali; oppure dissociarsi dal presente concreto per connettersi tecnologicamente con un altrove virtuale. Per ritornare indietro, per «tornare a casa», bisogna radicarsi nel corpo. In termini pratici, dobbiamo restaurare la comunicazione tra il cervello e le sensazioni del corpo. Voglio essere ancora più esplicito: dobbiamo imparare a riportare l’attenzione su quello che il corpo sente (e che spesso non ci piace sentire).
Se noi ignoriamo sistematicamente le sensazioni corporee, questo ha degli effetti sul funzionamento dell’organismo.2 La ricerca ha dimostrato, per esempio, che le persone che sono attente e connesse con se stesse quando mangiano tendono a ingrassare di meno.3 Questo perché sono maggiormente in contatto con i segnali di fame e di sazietà che derivano dal loro corpo. Per ripristinare il legame con le sensazioni corporee, cerco di diffondere nei miei corsi, oppure di utilizzare con gli atleti, tecniche di focalizzazione sul corpo come quelle di rilassamento. Il termine «rilassamento» è un termine usato convenzionalmente, ma che può indurre equivoci. Solitamente ci immaginiamo una persona rilassata come qualcuno in pieno benessere, che ha un contatto gioioso con il proprio corpo. Bene, non è sempre così. Abbiamo visto come sia importante regolare correttamente le aspettative: le tecniche di rilassamento sono in genere metodologie dove si addestra l’attenzione a focalizzarsi sul corpo.
L’obiettivo è quello di entrare di più in contatto con quello che c’è dentro di noi; il che non sempre è piacevole, o gioioso, o gradevole. Ma è sempre importante perché è reale. Il mito del «perfetto benessere» è l’altra faccia della trappola cognitiva del «non devo provare nessun tipo di disagio».
Questo campo è ricchissimo di tecniche e alcune di esse sono molto note, collaudate e validate. Qui non intendo caldeggiarne una in particolare. Sono infatti convinto che la scelta della tecnica dipenda molto dalle propensioni personali; e la preferenza individuale è importante perché può condizionare anche l’efficacia e i risultati della tecnica stessa. Ciò che è importante sapere è che questi metodi hanno una base comune: pur partendo da stimoli e procedure differenti, tutte sfruttano una serie di risposte neurofisiologiche simili.
Ma saper ascoltare e regolare le reazioni corporee è decisivo anche per un altro motivo: la gestione dello stress dipende – oltre che dall’eliminazione delle trappole cognitive – anche dalla capaci...