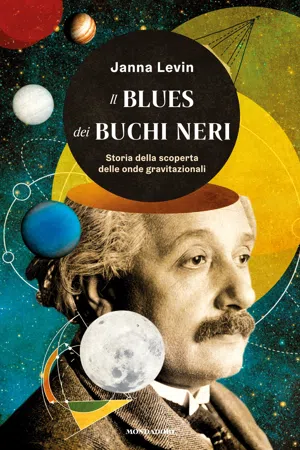Rochus E. Vogt era stato licenziato da provost del Caltech, la qual cosa non sembrava certo il miglior viatico per il ruolo di direttore di un progetto nascente di dimensioni titaniche, profondamente innovativo e tecnologicamente enigmatico. Non è il caso di attribuirgli troppo significato, ma Vogt era il titolo conferito, nel Sacro Romano Impero, al funzionario che sovrintendeva su determinati territori. In altre parole, Vogt significa qualcosa di simile a provost.
Nonostante il nome profetico, Robbie dice di se stesso: «Sono noto come persona che detesta qualsiasi autorità».
Come provost ha manifestato una devozione al Caltech che supera quella verso qualsiasi Paese e, pur non amando l’espressione, ammette che «killer su commissione» era una precisa descrizione del compito del provost. La sua fedeltà a un’istituzione intellettuale più che a un Paese ha forse, almeno in parte, un carattere difensivo. I tedeschi cresciuti negli anni dell’ascesa del nazismo hanno tutto da guadagnare da una storia personale che li veda in contrasto con la nascente autorità, altrimenti lo scenario alternativo è quello della collusione implicita, che costituirebbe un precedente imbarazzante per un provost. Va precisato che Vogt, ed è documentato, ebbe tutte le reazioni politiche corrette al totalitarismo (orrore e rifiuto) e tutte le reazioni adeguate alla Costituzione e alla protezione dei diritti individuali (ammirazione e accettazione). Ma la sua incrollabile fedeltà nei confronti del Caltech era una valida alternativa a qualunque nazionalismo.
Quando lo incontro nel suo ufficio al Caltech mi dice: «Ieri era l’8 maggio. L’8 maggio del 1945, avevo quindici anni. Ero appena stato prigioniero di guerra e giurai a me stesso che mai nella vita una qualsiasi stupida autorità avrebbe avuto alcun potere su di me».
Sapevo già, all’inizio della conversazione, che i nazisti avevano distrutto la sua educazione privilegiata nella Germania meridionale. Dopo la guerra, si adattò a fare il bracciante agricolo e poi l’operaio siderurgico. Infine, i suoi studi lo portarono nei più prosperi Stati Uniti: a quell’epoca era già diventato Robbie, nomignolo che gli aveva dato un soldato americano con il quale stranamente aveva fatto amicizia. L’americano, in realtà, era un ispettore degli armamenti assegnato alla sua università per garantire che non venissero fabbricate armi nucleari, e l’ingegnere dell’industria tedesca dell’acciaio Rochus, nel suo ruolo di rappresentante degli studenti, costituiva un collegamento. Nulla di tutto ciò spiega perché Vogt fu licenziato.
Vogt fu ricercatore capo in uno dei principali esperimenti della missione Voyager, il Cosmic Ray System. Attualmente le due sonde Voyager si trovano a più di 15 miliardi di chilometri dalla Terra, una distanza maggiore di quella raggiunta da qualsiasi altro oggetto di produzione umana. Sono ormai quasi tra le stelle, oggetti interstellari che si stanno scrollando di dosso il mantello magnetico del Sole, acciaio remoto esposto alla carezza dei venti delle stelle più lontane. Un po’ enfatico, ma vero. Vogt si batté per estendere gli obiettivi della missione allo spazio interstellare, sostenendo che il veicolo dovesse portare una quantità maggiore di idrazina – una sgradevole sostanza chimica necessaria per indirizzare la sonda oltre il sistema solare – il che riduceva il carico utile a disposizione degli scienziati planetari. Oggi spiega: «Più lontano arriviamo, più dobbiamo ridurre la velocità di trasmissione perché la sonda trasmetta … I generatori al plutonio, che forniscono l’energia, dureranno ancora da cinque a dieci anni e poi si esauriranno. Allora non ci sarà energia sufficiente per comunicare … Molto probabilmente accadrà tra altri cinque anni, quando saremo nello spazio interstellare a misurare lo spettro galattico dei raggi cosmici. Peccato che stia dicendo “noi” e non “io” … Adesso fanno le scoperte. E questa è l’unica cosa che mi dispiace. L’amministrazione me ne ha privato e fa male. Ma soltanto perché sarebbe stato divertente vedere le cose per primo».
Lanciato nel 1977 da un angolo desertico, Voyager è una sonda senza equipaggio ma con incisi dei messaggi sul nostro pianeta, il cui ritratto è stato curato da una commissione presieduta da Carl Sagan. Lo scopo meno serio della missione era fungere da gloriosa bottiglia portata dai venti interstellari con il compito di custodire una serie di souvenir nel caso che là fuori dovesse esserci un altro essere vivente e fosse interessato agli inventori della missione. Alcuni cittadini sollevarono delle obiezioni, dato che i dischi fonografici d’oro con le incisioni svelavano, in forma diagrammatica, la posizione del nostro delicato pianeta a potenziali aggressori. Ma gli extraterrestri dovranno prima trovare Voyager, un minuscolo frammento di metallo nel vuoto immenso dello spazio interstellare. Tra decine di migliaia di anni la sonda non avrà ancora incontrato un altro sistema stellare. E trovarci con i normali metodi di un esploratore galattico, quali che siano, deve essere più facile che trovare prima Voyager e decifrarne il messaggio soltanto per voltarsi indietro e individuare il nostro sistema solare in un’immagine periferica.
Per diventare provost, Vogt lasciò ad altri la responsabilità della sua missione prima che Voyager giungesse alla frontiera esterna del campo magnetico del Sole, quando per il Cosmic Ray System sarebbe stato davvero il momento di raccogliere frutti. Nell’accettare la carica di provost, rifletté sulla possibilità, qualora fosse stato licenziato (ma perché prendere in considerazione anche solo la possibilità?), di ritornare alla sperimentazione sui raggi cosmici. In un’intervista dei primi tempi del suo mandato, Vogt presagiva: «Se tornassi indietro, i miei colleghi dovrebbero dispiacersi per me, perché sono fuori dal mondo. Non sarebbe giusto mettere in imbarazzo le persone in quel modo. Quindi è chiaro che dovrò entrare in un campo del tutto nuovo». Murph Goldberger, allora rettore del Caltech, effettivamente lo fece licenziare nel giro di qualche anno. Se Murph avesse potuto semplicemente licenziarlo e se il potere decisionale fosse stato nelle sue mani, probabilmente avrebbe calato la mannaia anche prima. Ma per destituire un provost il consiglio di amministrazione dev’essere d’accordo e, sebbene Vogt fosse considerato un funzionario esperto e illuminato e fosse molto apprezzato dagli amministratori fiduciari, veniva anche dipinto come paranoico con un carattere difficile, e forse la descrizione non sembrava così inverosimile o ingiusta. Risentimento e biasimo avvelenarono il rapporto tra gli amministratori, che dovette essere interrotto. Questi particolari sanno di pettegolezzo e può darsi che non siano così interessanti o pertinenti se non per il fatto che collocano Vogt proprio dove lo voleva il destino.
Forze negative lo spingevano a quel punto focale: di fatto disoccupato (anche se ancora con uno stipendio), senza la possibilità di tornare alla sua precedente disciplina scientifica («Non sarebbe giusto mettere in imbarazzo le persone in quel modo»), relegato nel seminterrato di un istituto di fisica in deprimente prossimità della toilette degli uomini (senza né un laboratorio né un gruppo di lavoro), ridimensionato dalla delusione (perché il corpo docente non aveva espresso solidarietà quando era stato licenziato?), pronto «a entrare in un campo del tutto nuovo». Forze positive lo trattenevano con uguale intensità: ambizione, lungimiranza, vitalità. Tutto quello che occorreva era il differenziale di pressione causato dalla liquidazione intenzionale della Troika, praticamente proprio sotto i suoi piedi, proprio in fondo al letterale e proverbiale corridoio (in realtà, dopo il licenziamento, il suo ufficio era un piano sotto quello di Kip) e Robbie Vogt fu risucchiato nell’incarico.
Non volle mai quel posto e sarebbe stato licenziato anche come direttore del progetto LIGO. «Non ho mai avuto rapporti con il progetto LIGO in venticinque anni» avverte, come se la nostra conversazione non potesse portare a nulla. Ma mi accoglie nel suo ampio ufficio d’angolo in un edificio che non può essere definito altrimenti se non come quartier generale del progetto LIGO, alla fine di un corridoio che ospita colleghi con cui non ha mai parlato in un quarto di secolo. Scienziati di primo piano nel gruppo del progetto LIGO lo hanno visto senza averlo mai conosciuto ed esprimono scetticismo, oltre a preoccupazione per il fatto che mi troverò in fondo al corridoio nel famoso locale d’angolo insieme al famigerato, massiccio, spaventoso Robbie Vogt, come se quell’uomo infestasse un oscuro e terrificante stanzino dell’infanzia, che sarebbe stato meglio rimanesse sigillato per sempre.
L’ultimo giorno del mandato di Vogt come provost, il preside della divisione di Fisica, Matematica e Astronomia del Caltech si era presentato nel suo ufficio e Vogt gli aveva detto: «Porta via la tua lista» riferendosi a qualsiasi questione del dipartimento che potesse richiedere l’attenzione di un provost. «È finita. Mi sono appena dimesso.» Il capo della divisione, Ed Stone, aveva risposto: «Mio Dio, è terribile». Spiega Vogt: una Commissione di ricerca lo aveva indicato come direttore del progetto LIGO. Stone aveva l’incarico di avvicinarlo quando fosse di buon umore e di trovare il modo di mettere sotto una luce accattivante la nuova offerta di lavoro. Ma data la coincidenza con il licenziamento come provost, l’offerta appariva come un premio di consolazione. La risposta di Vogt era stata: «Ed, sei fuori di testa. Non ci metterò mano».
Kip suppone che, sebbene quel giorno Ed Stone possa aver tentato di valutare la reazione di Robbie come serio candidato alla carica di direttore, il posto non gli fu offerto che diverse settimane dopo le sue «dimissioni» da provost.
Quando ci accomodiamo nel suo ufficio, Robbie mi dice di essere stato costretto a diventare direttore del progetto LIGO. «Rifiutai, ma il mio rifiuto non fu accettato.» La sua resistenza si basava su un generico sospetto nei confronti del campo d’indagine a causa dei rivelatori a barra risonante di Weber e delle sue discusse rivendicazioni. «Detto per inciso, Weber era un personaggio tragico. In realtà era un bravo scienziato, ma talmente ossessionato dalla rivelazione delle onde gravitazionali da fraintendere grossolanamente i dati.»
Alla fine Vogt aveva ceduto alla forte pressione amministrativa. (Era stato minacciato, a suo dire.) «Ma nel momento in cui decisi di accettare l’incarico divenne il mio progetto e gli ero totalmente dedito. E avevo bisogno di questa dedizione.»
Nel 1987 Vogt era il direttore del progetto LIGO e un nuovo campo gli si spalancava davanti. I tre della Troika – Ron Drever, Rai Weiss e Kip Thorne – erano improvvisamente liberi di perseguire i loro destini nell’ambito del progetto. Robbie ha espresso solo parole di lode per Kip, «che merita il premio Nobel», e per Rai Weiss, «un bravo scienziato, un brav’uomo». Elogia perfino Ron Drever: «Sapevo che Drever era uno scienziato veramente brillante. Solo che come persona era un tipo stravagante». (Per la cronaca, l’opinione corrente è che la Troika, come gruppo, sarà presa in considerazione per il Nobel.) Robbie portò nel suo nuovo ruolo tutte le sue caratteristiche lodevoli e tutti i suoi difetti. Qualcuno ha osservato (e le parole mi sono state riferite come una descrizione adeguata anche se di terza mano, per cui le lascio senza attribuzione e alla vostra discrezione): «Nessuno era più intuitivo e creativo di Robbie, nessuno era più abile a risolvere un problema. E nessuno era più abile a crearne uno».
Nel 1989, Rochus E. Vogt, in qualità di ricercatore capo, sottopose alla NSF la massima espressione degli sforzi del gruppo congiunto Caltech-MIT: una proposta approfondita, meditata, di 229 pagine, intitolata The Construction, Operation, and Supporting Research and Development of a Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (Costruzione, funzionamento, ricerca e sviluppo di supporto di un osservatorio delle onde gravitazionali a interferometria laser). La proposta inizia con la citazione:
Non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini.
MACHIAVELLI, Il Principe, 1513, cap. 6
Rai la definisce un capolavoro. Tutti i partecipanti al progetto LIGO furono coinvolti nell’impresa e ne venne fuori una concezione accurata, difendibile e convincente, due osservatori da 4 km che operavano all’unisono su coste diverse degli Stati Uniti. L’haiku di Rai alla fine era stato proposto con decisione alla NSF per 193.918.509 dollari, in una lucida esposizione a favore di uno strumento realisticamente possibile – un nuovo portale d’accesso all’universo – da costruire nell’arco di quattro anni a cominciare dal 1990. LIGO presenta nel sommario del documento i suoi due obiettivi: «1) Verifiche della teoria della relatività generale… e 2) l’apertura di una finestra osservativa sull’universo che differisce in modo fondamentale da quella fornita dall’astronomia delle onde elettromagnetiche o delle particelle». Tale proposta segnò l’inizio, se non il compimento, della vicenda di Vogt come direttore del progetto LIGO. E la NSF approvò il finanziamento.
200 milioni di dollari non approdano come se niente fosse in un conto bancario. Per quanto significativa possa apparire la somma, il budget non era strabiliante in termini comparativi, a fronte, per esempio, di quelli per gli acceleratori di particelle, che raggiungono l’ordine dei miliardi. Tuttavia il progetto LIGO rappresentava lo sforzo più impegnativo intrapreso dalla NSF e si dovette chiedere al Congresso uno stanziamento di fondi speciale. Un grosso ostacolo era stato superato, certo, ma ne sarebbero nati altri. La raccomandazione del finanziamento da parte della fondazione segnò l’inizio di una lunga battaglia per assicurarsi l’approvazione del Congresso, alcuni membri del quale avevano preso di mira LIGO perché, secondo Robbie, pensavano che il progetto (e forse la scienza in generale) fosse uno spreco di denaro. Il Congresso ritardò l’erogazione dei fondi e quindi la costruzione dei siti. Per due anni Robbie fece avanti e indietro tra la California e Washington per corteggiare il Senato e la Camera dei rappresentanti. Divenne una figura familiare nelle anticamere del Congresso, tra i capiufficio, e nelle commissioni di spesa.
Robbie convinse il Caltech che aveva bisogno di un lobbista, una mossa ancora oggi impopolare tra alcuni membri del corpo docente del Caltech. Dopo molte resistenze, fu assunta una professionista che lo consigliasse e Vogt tornò a Washington più attrezzato per sciogliere l’intoppo. Pur essendosi ben preparato per l’audizione del 13 marzo 1991 alla Commissione sulla scienza, lo spazio e la tecnologia della Camera dei rappresentanti, non lo era per niente alla controdeposizione. Fu infatti in questa audizione congressuale che il rispettabile astronomo Tony Tyson pronunciò una valutazione rovinosa.
L’impegno di Tony Tyson sulle onde gravitazionali risaliva al 1971, quando aveva costruito una propria versione delle barre di Weber. In anni di esperimenti con le barre l’unico evento rivelato era stata un’esplosione nucleare sotterranea di prova effettuata in Alaska. Un ordigno nucleare da quasi 5 megaton era stato sganciato in un pozzo verticale. In seguito alla detonazione il suolo dell’Alaska si era sollevato tutto intorno di almeno 15 m in meno di 1 secondo, emettendo un’onda d’urto che si era propagata compiendo diversi giri intorno alla Terra e facendo risuonare il congegno di Tony nella sua struttura ai Bell Laboratories. All’epoca in cui il progetto LIGO fu oggetto di dibattito al Congresso, Tony era passato ad altre aree di ricerca, ma si considerava ancora un sostenitore del progetto.
Quando ricevette la richiesta di deporre da parte della Sottocommissione sulla scienza, pensò: «È meglio che non mi faccia coinvolgere», finché non ricevette un ordine di comparizione. Mancando meno di un mese all’audizione, convenne di preparare un calcolo ingegneristico per la valutazione della fattibilità tecnologica del progetto. Tony parlò in favore del progetto LIGO o, quanto meno, in favore dei progressi tecnologici di prim’ordine che prometteva. Ancor oggi Tony sostiene: «Se c’è una nuova finestra sull’universo, dovremmo usarla per guardare». Ma in quell’occasione riassunse una serie di preoccupazioni sul risultato scientifico finale, preoccupazioni che erano condiv...