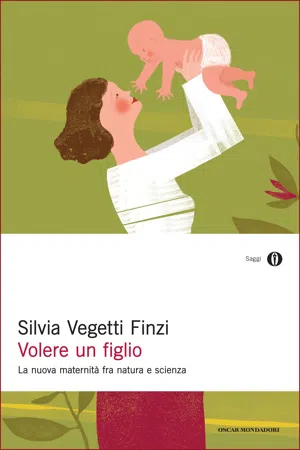
- 312 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La diffusione della contraccezione e delle biotecnologie consentono di avere o non avere figli, secondo le proprie esigenze e i propri desideri, ma, a fronte di queste possibilità, la cultura non ha ancora elaborato un'etica condivisa. In questo libro l'autrice ripercorre l'esperienza della maternità cercando di recuperare il significato di questa fondamentale esperienza, per poi analizzare i problemi della sterilità, dell'aborto e della fecondazione artificiale. In appendice il saggio presenta anche un'intervista con Carlo Flamigni, il maggior esperto italiano nel campo della procreazione assistita.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Volere un figlio di Silvia Vegetti Finzi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Philosophy History & Theory. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Parte terza
NASCERE NELL’EPOCA DELLA TECNICA
IX
Tecnologie della fecondazione umana: perché ora?
La società borghese moderna che ha creato per incanto mezzi di produzione e di scambio così potenti, rassomiglia al mago che non riesce più a dominare le potenze degli inferi da lui evocate.
KARL MARX
Con martellante frequenza ci vengono presentati dai mass media, con toni concitati e scandalistici, casi di nascite tecnologicamente indotte secondo le più fantasiose combinazioni.
Il tutto viene enfatizzato come una nuova scoperta scientifica, come l’inarrestabile trionfo del progresso. In realtà le cose non stanno così.
Secondo alcune ricostruzioni storiche,1 le prime manipolazioni eugenetiche sono coeve all’allevamento animale, alla selezione e combinazione delle caratteristiche ottimali delle specie addomesticate. Si fa menzione di inseminazione artificiale a uso veterinario nel Talmud (II secolo d.C.) e in un Codice arabo del 1322. Nel 1780 l’abate Lazzaro Spallanzani (1729-1799) verificò sperimentalmente la fecondazione artificiale sui mammiferi, riuscendo a inseminare meccanicamente una cagna. Qualche anno dopo, l’inglese John Hunter estese quelle scoperte alla specie umana, lasciando una memoria nella quale raccontava di avere fecondato artificialmente una sua paziente per ovviare a una malformazione genitale del coniuge che rendeva sterile il loro rapporto. Nell’Ottocento il milanese Paolo Mantegazza, uno dei più noti esponenti della medicina positivistica, formulava per la prima volta l’ipotesi di una banca dello sperma.
Da quando le tecniche di refrigerazione hanno permesso di conservare a lungo lo sperma, la fecondazione artificiale è divenuta uno dei cardini della zootecnia. Ma bisognava giungere alla seconda metà degli anni Settanta, dopo la nascita di Louise Brown in Inghilterra nel 1978, perché la fecondazione artificiale estesa agli umani divenisse una pratica di dominio pubblico.
Se adottiamo una prospettiva storica, ciò che ci appare (o meglio ci viene venduto) come una serie ininterrotta di scoperte scientifiche altro non è che un susseguirsi di perfezionamenti tecnici, senza che vi sia un reale avanzamento in termini di sapere e di potere.
Tanto che le terapie delle disfunzioni ginecologiche sono pressoché ferme agli anni Sessanta. E le ricerche sulla prevenzione della sterilità umana, che sappiamo in gran parte provocata da cause ambientali, sono quasi inesistenti.
Dobbiamo pertanto mutare il nostro approccio, riformulare il problema, e chiederci piuttosto come mai solo ora sia divenuta intellettualmente pensabile e moralmente accettabile l’estensione di tecniche veterinarie alla specie umana.
Da una parte le biotecnologie sono antiche come la civiltà, dall’altra si proiettano nel futuro sotto forma di ingegneria genetica. Data l’inarrestabile accelerazione della tecnica, il suo impersonale procedere, ho l’impressione che non ci resti molto tempo per pensare ed eventualmente prendere posizione. Dopo non vi sarà che la necessità dei fatti compiuti e l’ovvietà delle abitudini mentali. Sinora l’opinione pubblica ha accettato tutte le eventualità che le sono state presentate più con stupore che con preoccupazione, senza rendersi conto della ricaduta di conseguenze che ogni alterazione dei processi vitali comporta.
La difficoltà di assumere un atteggiamento critico nasce dalla segreta complicità tra gli artifici della procreazione e il desiderio inconscio, come se le fantasie della notte avessero trovato nella tecnica il loro braccio temporale. Per cui le figure stesse del sogno, la straordinaria combinatoria onirica dei fantasmi notturni divengono, in laboratorio, risultati efficienti, prodotti reali attorno ai quali si definiscono nuovi ambiti specialistici e nuovi profili professionali. Nella società tutto questo attiva poi un mercato, fatto di scambi, di speculazioni, di competizioni, dove gli scoop giornalistici funzionano da volano. Si intrecciano così complessi legami tra industria farmacologica, offerta di servizi pubblici e privati, artificiosa attivazione di desideri e di speranze. Ne deriva un circolo vizioso che si alimenta da solo. Non è un caso che, una volta superati i tabù plurisecolari intorno alla nascita e alla morte, appena la generazione umana si è resa manipolabile come quella veterinaria, si è assistito a una straordinaria accelerazione e inversione di tendenza, per cui le applicazioni sull’uomo hanno preceduto in molti casi quelle sugli animali.
In particolare, come osserva Jacques Testart, la fecondazione in vitro (FIV) – ottenuta nella seconda metà degli anni Cinquanta sui conigli, a opera contemporaneamente di M.C. Chang negli Stati Uniti e C. Thibault in Francia – è stata estesa agli umani nel 1969 da R.G. Edwards, molto prima che ai bovini, dove ciò accadrà solo nel 1980. E, mentre il primo bambino nato da FIV è del 1978, il primo vitello nato con un intervento analogo è del 1982 e il primo pollo del 1990.2
Ma come si è resa possibile una così inquietante alleanza tra desiderio onirico ed efficacia tecnica? Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto ricostruire processi di lunga durata.
Il disincanto del mondo
Se prendiamo come punto di riferimento il rapporto dell’uomo con la natura, possiamo collocare le tecnologie procreative al termine di quell’evoluzione culturale che Max Weber denomina «disincanto del mondo». Un mutamento progressivo che si organizza intorno a due grandi snodi epocali.
Il primo è costituito dal passaggio dalle religioni politeistiche a quelle monoteistiche, in particolare dal paganesimo al cristianesimo. Nelle religioni politeistiche, dove prevale una visione unitaria del mondo, l’uomo fa parte della natura e partecipa dei suoi processi magico-animistici. Dèi e demoni, uomini e animali, esseri viventi ed energie cosmiche interagiscono tra di loro senza che nessuna linea di demarcazione li divida. Nella mitologia antica l’uomo può essere figlio di divinità, di genitori umani ma anche di bestie o di elementi naturali personificati, come le ninfe e i satiri. Ma con l’avvento del monoteismo l’uomo, in quanto figlio di Dio, si colloca al di sopra di tutte le altre creature. Una separazione destinata a favorire il costituirsi dell’atteggiamento scientifico, fatto di estraneità, di razionalità, di rigore, di oggettivazione dei fenomeni al fine di conoscerli e formalizzarne le leggi costitutive.
Paradossalmente, osserva Max Weber, al suo sorgere la scienza ha utilizzato per affrancarsi dal dominio della religione proprio quelle accuse di irrazionalismo, primitivismo e superstizione con le quali secoli prima il monoteismo aveva squalificato il paganesimo. Nel suo procedere l’impresa scientifica porta a compimento la dissacrazione della natura; spezzando l’incanto dell’animismo, lo ha sostituito con la traduzione delle forze vitali in simboli astratti e quantificabili. «Il libro della natura è scritto in numeri» dirà Galilei. In quanto si sente radicalmente distinto da una natura ormai dissacrata e reificata, l’uomo può procedere, senza alcun sentimento di empietà, al dominio e allo sfruttamento dell’ambiente che pure lo contiene. La metafora della Madre Terra, che per secoli aveva simbolizzato la dipendenza vitale dell’uomo dalla natura, e insieme il rispetto e la gratitudine che il figlio deve a colei che lo ha generato, viene sostituita dalla scienza moderna con un modello meccanicistico che misconosce l’intrinseca compartecipazione di uomo e mondo, di micro e macrocosmo. Il senso di superiorità rispetto agli altri esseri viventi, indotto dalla visione monoteistica che fa dell’uomo una figura demiurgica, non viene scalfito neppure dal procedere del progresso scientifico.
Come abbiamo già accennato, secondo Freud, l’umanesimo rinascimentale, che pensa l’uomo al centro del mondo e il mondo a misura dell’uomo, è stato minato da tre grandi rivoluzioni scientifiche che, mutando la nostra visione del cosmo, hanno inferto all’immagine idealizzata che l’uomo ha di se stesso tre «ferite narcisistiche».
La prima deriva dalla scoperta copernicana, dal suo modello cosmologico che emarginando la Terra, facendone uno dei tanti pianeti che ruotano intorno al Sole, priva l’uomo della sua collocazione sovrana al centro dell’universo. La seconda, quella darwiniana, lo esilia dalla discendenza divina, inserendolo nella genealogia degli animali. La terza infine, quella psicoanalitica, colpisce al cuore la sua intrinseca superiorità dimostrando che l’uomo non è «padrone in casa propria». Ciò che chiamiamo pomposamente «coscienza» non è che un fluire continuo di differenti contenuti mentali, mentre le determinazioni al pensare e all’agire provengono prioritariamente da una dimensione che non saremo mai in grado di padroneggiare completamente: l’inconscio.
Ma è proprio riconoscendo la divisione che lo attraversa e le differenti logiche della psiche che l’uomo acquisisce consapevolezza e soggettività. Poiché però il cammino è lungo e faticoso, si capisce come, nonostante i colpi inferti dalla scienza, la gratificante antropologia umanistica, la sua consolatoria idealizzazione dell’uomo, resista tenacemente nel pensiero spontaneo. Non soltanto le scienze umane si sono sviluppate per ultime, rispetto a quelle della natura, ma non hanno sostanzialmente modificato il nostro modo di rappresentarci. L’uomo si considera sempre un essere completamente razionale, automotivato, capace di instaurare con gli altri contratti equi, basati su valori comuni e benefici reciproci. Si tratta di un’illusione che troppi avvenimenti si incaricano di smentire, ma che tuttavia riemerge continuamente, forse perché necessaria al vivere insieme, alla stipulazione del contratto sociale stesso. Giustamente l’uomo si oppone a considerare se stesso un oggetto di conoscenza tra gli altri, a farsi cosa tra le cose. Anche se le scienze obiettive, si pensi alle neuroscienze, minano con forza la sua residua soggettività, dimostrando come molti comportamenti siano indotti da processi biochimici, egli continua ad affermarla perché proprio nel gioco dialettico tra essere soggetto e oggetto della conoscenza consiste il senso della nostra umanità. Un senso che non risiede più nell’essenza dell’uomo, garantito dalla presenza di un’anima immortale, ma nella relazione con gli altri, cui è affidato il riconoscimento della nostra fragile identità.
L’ultima frontiera
Nel processo di desacralizzazione dell’uomo e del mondo, qui sommariamente evocato, la procreazione ha rappresentato un ambito privilegiato di resistenza per cui i suoi confini sono stati oltrepassati per ultimi. Non è casuale che per secoli l’applicazione delle competenze zootecniche non sia stata estesa all’ambito umano: una barriera di sacralità lo ha pervicacemente difeso. Ma, una volta saltate inibizioni plurisecolari, le tecnologie della procreazione umana hanno proceduto in modo tendenzialmente autonomo e separato dal complesso della cultura, senza cercare in linea di massima di interloquire con la società. Eppure siamo di fronte ad accadimenti epocali. Come afferma il Manifesto di bioetica laica: «Se la rivoluzione scientifica e tecnologica dell’era moderna ha permesso all’uomo di modificare radicalmente la natura che lo circonda, la rivoluzione biologica e medica dischiude la possibilità che egli intervenga sulla propria natura».3 Tuttavia la «seconda rivoluzione scientifica» non ha finora suscitato attese e timori analoghi a quelli che accompagnarono la nascita della scienza e del mondo moderno. La riflessione bioetica, benché abbia prodotto, soprattutto all’estero, una massa enorme di pubblicazioni, non è ancora diventata un sapere condiviso; i suoi interrogativi destano flebili emozioni e inquietano solo poche coscienze.
Il perché di questo scarto credo si possa ricercare nella storia ma anche nell’epistemologia del pensiero scientifico occidentale, dove la riproduzione artificiale ha funzionato da rivelatore di una separazione tra laboratorio e società civile che a fatica si va ricomponendo.
Solo in questi ultimi anni la ricerca scientifica è giunta a minacciare la residua intimità dell’uomo, il punto di congiunzione tra natura e cultura, individuo e società: l’ambito sacro della sessualità e della generatività. Il tutto perseguendo un ideale di ricerca pura e finalità di intervento terapeutico che la pongono al riparo dal dubbio e dalla critica.
Lo scienziato si presenta infatti all’opinione pubblica come un prolungamento dei suoi strumenti, come loro impersonale, asessuato ed emotivamente neutro. Se questa è la sua funzione, il suo compito consiste nel formulare e verificare ipotesi che si pongono quasi automaticamente nel corso della ricerca. Ma in una società capitalistica l’impresa scientifica si rivela inscindibile da una volontà di controllo e di sfruttamento dell’uomo sulla natura e, basti pensare al commercio d’organi, dell’uomo sull’uomo. Ma nella contrapposizione tra il soggetto e l’oggetto della conoscenza vengono negati, come abbiamo visto, tanto l’appartenenza dell’uomo al mondo quanto il suo coinvolgimento nel processo conoscitivo, che si presenta come impersonale progresso verso la verità e il bene.
Nei suoi studi sullo sviluppo intellettuale, Piaget ha dimostrato invece che la conoscenza obiettiva non è un dato di fatto ma una conquista lenta e difficile.
Inizialmente il bambino vive immerso in un mondo animato, dove regna l’indistinzione tra l’uomo e le cose, tra il sé e il non sé, tra ragione e desiderio. L’infanzia è calata in un universo magico, per certi versi simile a quello delle culture primitive, dal quale progressivamente si affranca rinunciando all’egocentrismo cognitivo e all’onnipotenza del desiderio.
Nel suo modello, anche la scienza segue un cammino analogo a quello dell’individuo, un percorso che conduce dalla soggettività all’oggettività, dall’assoluto al relativo, dal concreto all’astratto, dall’immaginario al simbolico. Prendendo le mosse dalle concezioni magiche del mondo, la scienza occidentale rappresenta il punto d’arrivo di un progresso lento ma costante che non intende lasciare dietro di sé residui o opacità. Il parallelismo tra l’evolversi della conoscenza individuale e di quella collettiva è assai suggestivo ma finisce per misconoscere molte cose: l’insopprimibile appartenenza dell’uomo al mondo naturale e sociale, il suo essere a un tempo soggetto e oggetto della conoscenza ma soprattutto l’impossibilità di un processo razionale isolato da quello affettivo, di un sapere della mente avulso da quello del corpo. Sappiamo invece che l’intelligenza è sempre «intelligenza emotiva».
L’apporto della psicoanalisi consiste appunto nel reintrodurre il coinvolgimento e l’ambiguità là dove regna l’eccesso della luminosità e del rigore. L’uomo porta anche nel sapere più astratto l’interferenza della sua complessità. Tale interferenza si rende tanto più evidente quanto più la conoscenza si approssima alla sua intimità, a bisogni, desideri, affetti non sempre limpidi e lineari. L’ideologia della scientificità richiede invece di negare ogni commistione. Lo scienziato si pone di fronte all’altro come a una cosa, un oggetto estraneo da ridurre a componenti elementari, anche quando «l’altro» è il suo simile o, al limite, se stesso.
La biologia, scienza della vita, ha tradizionalmente costituito il suo patrimonio di sapere sull’animale morto. L’investigazione del corpo ha richiesto, preventivamente, la sua uccisione, la sua trasformazione in cadavere. Sappiamo che, storicamente, la fisiologia si fonda, come ha ricostruito Mario Vegetti ne Il coltello e lo stilo (1979), sulla dissezione anatomica. All’organismo – come complessità delle funzioni vitali – si sono sostituite le sue parti, i sistemi parziali che lo compongono. Con l’avvento della medicina moderna, la totalità e l’unità si sono smarrite nella molteplicità delle competenze. Non deve pertanto stupire, dati questi presupposti, che la biologia contemporanea individui tre agenti essenziali nel processo di riproduzione: l’ovulo, lo spermatozoide e l’utero.
Un precedente autorevole è costituito dalla biologia arist...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Volere un figlio
- Introduzione
- Parte prima. LA MATERNITÀ ALLA LUCE DI UNO SGUARDO FEMMINILE
- Parte seconda. OMBRE SUL DESIDERIO MATERNO: IL FIGLIO CHE NON C’È
- Parte terza. NASCERE NELL’EPOCA DELLA TECNICA
- LA CURA DELLA STERILITÀ ATTRAVERSO LE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA. Intervista di Marina Mengarelli a Carlo Flamigni
- Riferimenti bibliografici
- Note
- Copyright