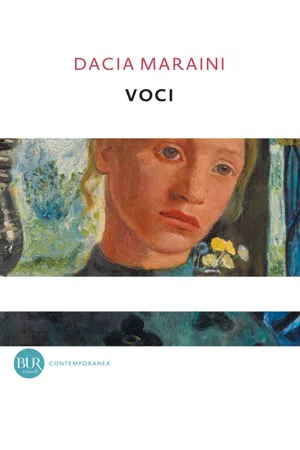Uno
Il taxi mi deposita davanti al cancello di via Santa Cecilia. Ma perché tanto stupore? sono di nuovo a casa, mi dico, sono tornata; ma è come se non lo riconoscessi questo cancello, questo cortile, questo palazzo dalle tante finestre aperte. Ho una spina infitta nel palato, come il presagio di una sciagura. Cosa mi aspetta in questa dolce mattina che porta con sé gli odori conosciuti del ritorno? cos’è che preme sui miei pensieri come se volesse distorcerli e cancellarli?
Cerco con gli occhi la portiera, Stefana, che a quest’ora di solito sta smistando la posta nella guardiola, ma non vedo né lei né il suo allampanato marito, Giovanni. Attraverso il cortile tirandomi dietro la valigia a rotelle che, sulla ghiaia, non ne vuole sapere di camminare. Mi fermo un momento in mezzo al pietrisco per dare uno sguardo intorno: gli oleandri e i gerani rosa sono sempre lì nelle aiole, anche se coperti da un velo di polvere estiva, la fontanella dalla pietra muschiata gocciola, al suo solito, con un rumore di rubinetto rotto; i due grandi tigli sono carichi di fiori e sembrano i soli a non languire per il caldo, i soli estranei a quell’aria cupa che oggi grava sulla mia casa. Se ne stanno lì, nel leggero vento estivo, a scuotere i loro mazzetti di fiori pelosi e profumati.
Le finestre che danno sul cortile, così spesso occhiute, oggi sembrano tutte cieche, anche le scale sono deserte e stranamente silenziose. L’ascensore mi deposita con un soffio stanco all’ultimo piano, il mio.
Mentre cerco nella borsa le chiavi di casa, vengo raggiunta da un penetrante odore di disinfettante da ospedale. Mi volto e vedo la porta della vicina di pianerottolo socchiusa. Faccio due passi, la spingo con le dita e la vedo scivolare su se stessa, docile e leggera, rivelando un corridoio inondato dal sole, la frangia di un tappeto arrotolato e un paio di scarpe da tennis azzurre, bene appaiate proprio accanto alla porta.
Il mio sguardo si sofferma di nuovo, incuriosito, su quelle scarpe celesti che, così pulite, illuminate dal sole, suggeriscono l’idea di passeggiate felici, salti in punta di piedi, corse sui campi da tennis dietro una palla che vola. Ma perché giacciono lì, immobili, integre e slacciate di fronte alla porta aperta? Sono troppo bene appaiate per fare pensare che qualcuno se le sia tolte rientrando a casa, con un gesto di impazienza; c’è qualcosa di composto e definitivo in quel loro stare esposte agli sguardi dei curiosi, con i lacci arrotolati sulle tomaie.
Dal fondo dell’appartamento sento arrivare delle voci e, subito dopo, mi vedo davanti la faccia di Stefana dai grandi occhi dolenti.
«Non l’ha saputo?»
«Che cosa?»
«È morta cinque giorni fa, l’hanno uccisa.»
«Uccisa?»
«Venti coltellate, una furia... e non l’hanno ancora preso, poveri noi.»
Una voce da cospiratrice; le iridi che slittano verso l’alto mostrando il bianco della cornea. Mi ricorda un quadro di Delacroix: una espressione di allarme, come di chi abbia veduto con gli occhi della mente la catastrofe incombente e non trovi le parole per raccontarla. Un pallore da sottoscala, che “si nutre di vite altrui”, come dice Marco; eppure Stefana Mario è una donna intelligente e consapevole. Le guardo le mani che sono grandi e capaci, mi chiedo se sia stata lei, con quelle mani, a rivestire la morta.
«Ma perché l’hanno ammazzata?»
«Non si sa, non sembra che abbiano rubato niente... un finimondo, doveva vedere, è arrivata la polizia, è arrivato il giudice istruttore, sono arrivati quelli della scientifica, i giornalisti, i fotografi, e tutti con le scarpe sporche che andavano su e giù per le scale... Il funerale è stato l’altro ieri... Ora abbiamo pulito tutto, ma ci sono ancora dei poliziotti di là che prendono misure... dice che oggi mettono i sigilli.»
Mi accorgo che sto stringendo la chiave di casa fra le mani con una tale forza che mi dolgono le giunture.
«Vuole entrare, Stefana, le faccio un caffè?»
«No, devo tornare giù, non c’è nessuno in portineria.»
La sento scendere i gradini, rapida, con le scarpe di pezza che emettono appena un leggero tonfo smorzato. Apro la porta di casa, trascino dentro la valigia; annuso l’aria che sa di chiuso, spalanco le imposte, mi chino sulle piante che se ne stanno reclinate, pallide e impolverate. Eppure l’acqua non è loro mancata, Stefana le ha innaffiate tutti i giorni come era nei patti; ma quello stare al chiuso, nel silenzio di una casa vuota, le avvilisce; non amano stare sole, le mie piante e me lo dicono con voci chiocce in un sussurro dietro le spalle.
Mi seggo alla scrivania davanti ad un mucchietto di lettere arrivate durante la mia assenza. Ne apro una, ma mi accorgo che leggo senza leggere: torno sulla prima frase due, tre volte, poi smetto. Il mio pensiero, come un asino giallo visto una volta in un quadro di Chagall, tende misteriosamente a volare fuori della cornice. Mi chiedo cosa so della mia vicina ammazzata a coltellate: niente; una donna è stata uccisa dietro la porta accanto e io non so neanche come si chiamasse.
La incontravo qualche volta in ascensore, la guardavo di sottecchi come si guarda una persona che ti sta di fronte in treno o in autobus, con un senso di colpa per la curiosità maleducata che ti anima. Perché, poi, sarà maleducato occuparsi del proprio dirimpettaio?
Era alta ed elegante, la mia vicina, portava i capelli castani chiari tagliati a caschetto. Il naso piccolo, delicato, il labbro superiore particolarmente pronunciato, che quando si arricciava in un sorriso rivelava dei denti piccoli e infantili, un poco sporgenti. Un sorriso da coniglio, avevo pensato vedendola la prima volta, timido e timoroso come di chi è abituato a rosicchiare pensieri segreti. Gli occhi grandi, grigi, la fronte spaziosa, la pelle delicata, bianca, cosparsa di efelidi. La voce, quelle rare volte che l’ho sentita, mi è sembrata velata, come di chi tema di esporsi e infastidire, una voce piegata su se stessa, resa opaca dalla ritrosia, con dei guizzi inaspettati di ardimento e di allegria.
Abitava da sola, come me, e su di noi vegliavano la portiera Stefana e il suo evanescente marito Giovanni Mario, che si comportano come due vecchi genitori indulgenti, mentre in realtà sono più o meno nostri coetanei.
Ma perché la vicina tornava così tardi la notte? a volte, nel dormiveglia, sentivo la sua porta che si chiudeva con un tonfo, e la chiave che girava nella toppa con insistenza, trac, trac, trac. Anche le persiane venivano sprangate con energia, le sentivo sbatacchiare bruscamente sia di sera che di giorno.
Perché la mattina usciva silenziosa, stanca e intontita e perché ogni tanto partiva con aria furtiva portandosi dietro solo una borsa gialla tipo zaino?
Eppure tutte e due eravamo “da proteggere” secondo la mentalità del palazzo, perché vivevamo sole, perché facevamo lavori faticosi che ci tenevano spesso fuori casa, io con la mia radio e lei... ma qui mi fermo perché non so altro.
Riprendo in mano la lettera e ricomincio a leggere: è il conto del commercialista. Ne apro un’altra: è la rata del computer da pagare. Poi c’è la bolletta della luce, scaduta...