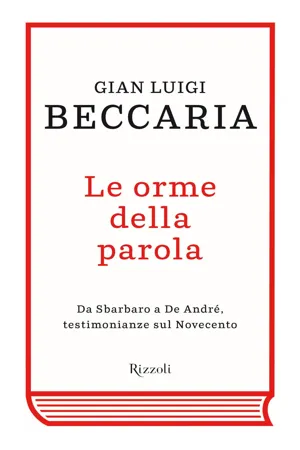![]()
Poesia
![]()
1
Sbarbaro, Pianissimo e oltre
Sbarbaro continua a essere una presenza novecentesca ineludibile. Da Pianissimo (1914) tocca sempre partire, se si vuole mettere nel rilievo dovuto l’importanza di un poeta che è stato capace di allargare ulteriormente le proposte del primo Novecento: quelle che avevano inaugurato nelle nostre lettere un inedito timbro semplice e familiare, amato le «trite» parole, consuete e sommesse, dal tono abbassato sino al «pianissimo»;1 con la differenza però che Sbarbaro, rispetto agli altri, mostrava in soprappiù che si può abbassare senza rovesciamenti e senza polemica;2 mostrava insomma che l’abbassamento prosastico del verso si può anche operare senza mettersi a fare i conti col passato, senza entrare nel gioco delle allusioni, del controcanto, dell’ironia letteraria, ma cominciando semplicemente a usare le parole che non sappiano d’accatto («Anche della mia lingua» scriveva in Fuochi fatui 1916-1918 «ho una conoscenza approssimativa. Tante parole le evito, malsicuro del loro significato; e se non le cerco nei dizionari, non è solo che dei dizionari diffido, ma che una parola non assimilata in tanti anni, non divenuta carne e sangue, mi saprebbe sempre di accatto»). Certo, i libri si fanno coi libri, e anche in Sbarbaro si incontrano rimandi a D’Annunzio, e anche a Pascoli. Certamente polemico verso D’Annunzio è l’allusivo v. 21 di Taci anima stanca di godere («Perduta ha la sua voce / la sirena del mondo, e il mondo è un grande / deserto»),3 eco dell’inizio della Laus Vitae: «Laudata sii, Diversità / delle creature, sirena / del mondo». E più tardi, in Liquidazione 1928, s’incontrano presenze segnatamente dannunziane del tipo «baia calda e cilestra», o «l’albasia dei mari».
D’Annunzio non solo, ma anche Pascoli, dicevo, trapela (sia pure in forma competitiva), se penso a Trucioli 1920 [69],4 quando compare lo scricciolo che «sferruzza nelle pause le sue limettine d’argento», e ai «fili strepitosi della pioggia» di Trucioli 1914-1918. E ci potrebbe essere Govoni dietro al rospo che «ha gonfiato il suo palloncino e canta. Punta di diamante, la nota riga il cristallo grigioroseo della sera in cui i lustri occhi attoniti dei canali, le casupole chiotte, gli alberi spirituali hanno un’immobilità da stampa» (Trucioli 1920 [74]). Comunque sia, uno studio sistematico delle fonti di Sbarbaro è ancora da fare. Magari seguendo le tappe e i tramiti di qualche suo (per quanto raro) ardimento neologistico, come in Trucioli 1920 (la folla indomenicata, le villanelle indomenicate, il lironzolo, i cristallami, l’erbaglia, sdigiunare, gli uomini che s’ingolettano), o in Cartoline in franchigia quell’intalparsi, o per certe immagini che non saprei dire quanto inedite (vedi per esempio in Trucioli 1920 [77] il somarello malconcio che gli spalanca addosso «la tastiera giallognola dei denti»).
Dicevo dell’importanza di Pianissimo 1914, raccolta che ci consegna uno Sbarbaro testimone non solo di una vicenda individuale, ma anche generazionale, di grande rilievo nel primo Novecento europeo. Sullo sfondo ci stanno Baudelaire, Laforgue, e Rimbaud, anche se tutto sommato la poesia di Sbarbaro non muove, al modo dei poeti maledetti, da un lucido totale rifiuto per la realtà. Era, la sua, una realtà cui guardava certo con «asciutti» occhi, «limpidi» e «chiari», estranei insomma e indifferenti, ma che talora si riempiono delle lacrime di un escluso che chiede (invano) di essere ammesso, che bussa alla vita… e la vita lo sopravanza, la vita gli sfugge. Eppure, del «bisogno d’infelicità» si nutre, per poter scrivere: la felicità e la salute sono nemiche del mestiere di poeta, salute e insipienza sono inseparabili, scriveva Sbarbaro in una lettera giovanile a Barile: «Qualche volta mi auguro di essere una zucca: cresce in un momento, s’avventa su, occupa un gran posto, è contenta di vivere, fa dei frutti vistosi quanto insipidi e si gode l’aria e il sole».
In Pianissimo disperazione e infelicità sono i sentimenti dominanti: o meglio, s’impone la volontà di perseguire la propria degradazione (si rilegga Esco dalla lussuria) e di osservare, intorno a sé, la degradazione degli irregolari, di chi vive ai margini della società. Resa e rassegnazione dunque di fronte all’infelicità, e ad un tempo perdizione: sono le due costanti di Pianissimo, articolate in temi centrali come il senso di esclusione, di inadeguatezza, il timore di non farcela a stare a galla, di non poter raggiungere la vita desiderata e non posseduta, la dichiarazione dell’impraticabilità dell’amore e la vanità della sua attesa (scrive in Trucioli 1920 [48]: «Capisco che non camminerò mai per una strada fuori mano tenendo una donna allacciata. / E costei che è vicina e pare aspetti le parli e sarebbe tanto dolce baciare / la vedo lontana, cosa che non mi riguarda»). La solitudine dunque, l’incomunicabilità, sono situazioni sentimentali svolte in Pianissimo sullo sfondo di un angoscioso paesaggio metropolitano: «città di pietra» immensamente vaste e vuote, con case mute, immobili, indifferenti, vie deserte, vi si cammina «pei lastrici sonori della notte» immersi nel silenzio, intorno «le miriadi degli esseri / sigillati in se stessi come tombe», finestre buie aperte nella notte, e «negli atrii di pietra voce d’acqua!» (immagine di gelo che sarà poi ripresa da Caproni). Più rari gli squarci di strade dove condurre a spasso la propria «muta meraviglia»: «Ci sono vie che si aprono formidabili come domande cui non si può rispondere / altre ch’empiono d’ardimenti come fanfare improvvise / altre che pacificano come la voce del mare…» (Trucioli 1920 [41]). Più insistita la matrice infernale (si legga Talor, mentre cammino per la strada) impressa nei visi degli uomini che vagano in quelle strade come nel vestibolo dell’Inferno, trascinati per le vie dalla necessità, una folla di gente che gira in tondo, al pari degli ignavi: un brulicare dei vivi, fantocci, condannati inconsapevoli. Il poeta si muove estraniato come «sonnambulo». Come quel sonnambulo che erra per le vie in Baudelaire o in Rimbaud. Lo Sbarbaro di Trucioli («burattino», «marionetta», «fantoccio ebbro e tragico», «rottame alla deriva»; «mentre vado per strada, e di me non m’avvedo») scorre in parallelo col Pianissimo di «Talor, mentre cammino per la strada / […] mi dimentico il mio destino d’essere / uomo tra gli altri e, come smemorato, / anzi tratto fuor di me stesso / […]», e di «Andando per la strada così solo […] mi pare d’esser da me stesso assente». Pianissimo descriveva per la prima volta nelle nostre lettere lo spaesamento esistenziale di chi contempla un paesaggio metropolitano abitato da un’umanità misera e offesa, cupa e perduta (prostitute, ciechi, mendicanti: e vedi Trucioli 1920 [83] «Ho nel sangue la predilezione dei quartieri miserabili. Mi specchio negli abietti della società, nei diseredati…»), un’umanità di esseri soli e disperati che tentano di sollevarsi («per uno sforzo d’ali i gomiti alzo…» in Pianissimo, Talora nell’arsura della via, cui corrisponde in Trucioli 1920 quell’implume «teso» nell’inutile sforzo di scapole, «nell’impazienza dell’impossibile volo»), una solitudine che non conosce che qualche raro rapporto positivo con la vita, qualche rara parentesi, quando si apre (ma solo a tratti) a momenti di fraternità, di momentanee paci. Ricorrente è il tema dell’osteria che affratella, «il mio luogo cordiale. / Un antro. Ci si sta gomito a gomito» (Trucioli 1920 [39]; e vedi in Trucioli 1930-1940, Gente all’osteria: «Gente che il trovarsi insieme affratella, quasi la gioia d’ognuno dipendesse da quella di tutti. Non c’è chi stia sulla sua. Un po’ il vino, un po’ l’aria della domenica, le fisonomie vengono incontro. Le distende una confidenza reciproca…»; e in Trucioli 1920 [85] «Dalla stanza imbiancata, a pianterreno, dove spacciano un vino sanguaccio, due uomini escono, tenendosi vicendevolmente la mano sulla spalla e parlano inteneriti»). L’osteria è approdo per l’oblio, luogo dell’ebbrezza, della momentanea felicità, ai suoi tavoli si fanno «i più meravigliosi viaggi»… ma appena fuori, è in agguato la solitudine, come in quella bellissima, amara Lettera dall’osteria dedicata a Silvio Volta, l’amico prediletto (porta la data «Genova 1913»):
In istato di grazia, amico Volta,
di notte da una bettola ti scrivo.
bene, di contemplare
tra la nebbia del vino i paesaggi
di cui rozz’arte ornò all’intorno i muri,
e l’ostessa baffuta o la ridente
ragazzotta che reca la terrina.
vicino; a chi sorride
sorridere; volere a tutti bene;
scantonato dal Tempo e dallo Spazio,
guardare il mondo come un padreterno.
come la mongolfiera che s’invola;
sentir come tappeti di velluto
i lastricati sotto il piede incerto;
e voglia di cantare a squarciagola.
nave che sbanda, al consueto porto.
Fuggir di gatti innanzi al passo sordo.
Rettangolo di luce, prepotente,
nel vicolo che fruscia di fantasmi.
Acre odore, allo svolto, di cloruro.
Poi che dato non m’è d’amare alcuno,
m’aggrappo come naufrago alle cose.
[…]
un tema che sarà qualche anno dopo svolto in Trucioli 1920 [86], A Carlo Tomba, quando con l’amico si raccolgono intorno al «mezzolitro» (lo stesso che sarà poi ripreso, ancora, da Caproni, La festa notturna, in Res amissa: l’«antico mezzolitro» che riscalda i cuori):
Se penso la mia gioventù poca e artefatta vedo il bianco affilato viso di lui che mi sedeva in faccia nella luce falsa delle taverne. Taceva. Tra me e lui era il mezzolitro centro d’un mondo.
Bicchiere su bicchiere si beveva finché la mano dell’uno cercava quella dell’altro. Il gelo era rotto che ci faceva toccarci come spettri. E uscivamo a braccetto pel mondo trasformato.
Nella piazza il cantastorie allargava cerchi d’incanto dai quali non si poteva uscire.
Come d’un eldorado andavamo in cerca d’una locanda […] Oh le vite che abbiamo vissuto! Eravamo, per momenti, la ragazza seria al banco; il contabile che viene a pulire le lenti sulla soglia del fondaco; la vecchia che ritira il soldo nel luogo pubblico; l’uomo buio che si scontra; la bambina che traversa a salti la strada e che un portico ingoia…
Vite d’un attimo più intense della nostra, vacua.
Vite d’un attimo. Dopo momenti di rassegnazione e perdizione, dopo sperdimento nei meandri della città, Sbarbaro apre queste riappacificazioni col mondo, ricomposizione dei conflitti, un ritorno alla tenerezza indulgente verso gli uomini e le loro vite d’un attimo.
Sbarbaro è stato il grande poeta dell’anonimo, dell’umile. Ma «sotto l’apparente assenza di pietà» (come scrive di lui Giorgio Caproni) scorre «il filo d’oro d’un amore scontroso ma profondissimo per il prossimo».5 Da una amara radice fioriscono colori e tenerezze (ecco in Fuochi fatui, a proposito dell’‘amarezza’ che gli si era attribuita: «Amaro? Nella radice, se mai: la radice contorta che permette di essere all’aria un mazzo di fiori»). Dagli umili (o dai dannati) trae motivi d’amore e di fraternità («predilige i negletti, cioè i licheni della società umana» scriveva ancora Caproni).6 Sbarbaro è poeta di tenerezze: per l’indifeso, così come per i piccoli animali (qualche rapida citazione: Trucioli 1920 [76] «I batuffoli di lana bigia o giallina dei pulcini dagli occhietti palpebranti»; e ivi la rana che «Palpita tutta: il gorgozzule di raso bianco, la pancetta fredda, i forellini delle nari. Di fermo non ha che le perline nere degli occhi»). Tenerezze che si distendono in compiaciute testure dai rilievi fonici marcati, note tenute, scatti di doppie («Gli anitraccoli sparnazzanti nella pozzanghera. Bordeggiano. Si disputano clamorosamente coi becchi di legno magari il pezzo di carta» ivi).
Tenerezze per la vita alternanti con le disperazioni della non vita. Sbarbaro è stato il grande poeta della tenera e disperata tensione al vivere, collocandosi sul discrimine tra vita e non vita, tra vita e fatica a vivere: basterebbe citare lo Sbarbaro dei licheni, la sua – dice così – «predilezione per le esistenze in sordina» (Licheni, in Trucioli 1930-1940), la sua «attrazione irresistibile per le minime esistenze» (Fuochi fatui 1940-1945), per il frammento rifiutato come il truciolo, inerte e inutile come il lichene.7 Confessava in una lettera a Gianni Scalia del ’56:8 «In realtà, i licheni (come già un tempo i muschi) non sono per me che un alibi, o, se vuole, una forma di disperazione». La sua predilez...